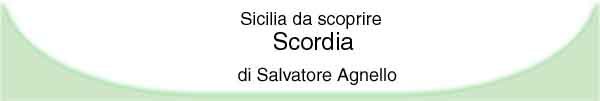
Un miraggio dietro l' angolo di Salvatore Angelo
Tra storie e antropologia di Nuccio Gambera
Monumenti arte e religione di Claudio Parisi
Un "immersionme" in scordia di Ntonio La Furno
Un allievo di Raffaello nella chiesa di San Rocco di Claudio Parisi
Dalla disgregazione sociale e culturale allo sviluppo : Che fare?
Un miraggio dietro l' angolo
 Scordia
come numerose altre piccole e medie realtà meridionali, nel corso
dell'ultimo decennio è stata protagonista di una rapida crescita
economica, che insieme ad una ricchezza e un benessere diffusi, ha prodotto
profonde trasformazioni nella cultura e nei comportamenti quotidiani dei
suoi attori. Allo sviluppo disordinato e spesso gonfiato" delle attività
economiche trainate dalla favorevole congiuntura del mercato degli agrumi,
anello portante della sua economia, ha comisposto la diffusione di modelli
di consumo, di stili di vita, di canoni estetici, di forme di relazione
sociale assai povere di retroterra nel tradizionale tessuto culturale
delle comunità. Più
delle naturali differenze e tensioni tra una generazione e l'altra, ha
prevalso il carattere accelerato dei mutamenti nella struttura socio-economica
che ha piegato la cultura dei tradizionali istituti (famiglia, scuola,
chiesa e organismi politici) alle nuove regole dei consumo di massa. La
quantità e qualità dei beni acquistati ha rappresentato
infatti il misuratore, il più attendibile empiricamente, della
progressione del processo di emancipazione dalla miseria e dagli stenti,
che hanno segnato secoli della storia di questa comunità contadina,
alla agognata sufficienza, celebrata con successo in una esplosione di
consumi senza precedenti. Che
un tale passaggio non sia stato indolore a denunciarlo è la cronaca
che in più occasioni ha dovuto registrare fatti criminali di rilevante
dimensione, e
la diffusione di forme estreme e dolorose di disagio sciale, insieme ad
assai meno marginali espressioni di comportamenti giovanili micro-devianti
in parte riconducibili allo stereotipo psico sociologico dei protagonisti
del celebre cult-movie Gioventù bruciata. La
constatazione di una così contraddittoria realtà seppur
acquisita dal senso comune come un fatto trasparente, non penetra oltre
la superficie la coscienza collettiva, nè suscita più seri
interrogativi circa il carattere radicale dei mutamenti che hanno investito
la società.
Nella piccola cittadina dopo che nella grande metropoli industriale c'è
poca differenza, nella nuova società, spogliata di ogni ornamento
umanitario, 'Io stare insieme sembra non avere altra ragione d'essere
che il produrre e il consumare ( ... ) e tutto ciò che resta fuori
da questa visuale non sembra avere alcuna visibilità generale".
(P. Barcellona). Liberati i rapporti tra gli individui da ogni vincolo
di solidarietà di natura storica o culturale, in gabbiate
anche l'affettività dentro lo stesso ordine di ragioni, non resta
che un ultimo legame, lo scambio di cose e di
Scordia
come numerose altre piccole e medie realtà meridionali, nel corso
dell'ultimo decennio è stata protagonista di una rapida crescita
economica, che insieme ad una ricchezza e un benessere diffusi, ha prodotto
profonde trasformazioni nella cultura e nei comportamenti quotidiani dei
suoi attori. Allo sviluppo disordinato e spesso gonfiato" delle attività
economiche trainate dalla favorevole congiuntura del mercato degli agrumi,
anello portante della sua economia, ha comisposto la diffusione di modelli
di consumo, di stili di vita, di canoni estetici, di forme di relazione
sociale assai povere di retroterra nel tradizionale tessuto culturale
delle comunità. Più
delle naturali differenze e tensioni tra una generazione e l'altra, ha
prevalso il carattere accelerato dei mutamenti nella struttura socio-economica
che ha piegato la cultura dei tradizionali istituti (famiglia, scuola,
chiesa e organismi politici) alle nuove regole dei consumo di massa. La
quantità e qualità dei beni acquistati ha rappresentato
infatti il misuratore, il più attendibile empiricamente, della
progressione del processo di emancipazione dalla miseria e dagli stenti,
che hanno segnato secoli della storia di questa comunità contadina,
alla agognata sufficienza, celebrata con successo in una esplosione di
consumi senza precedenti. Che
un tale passaggio non sia stato indolore a denunciarlo è la cronaca
che in più occasioni ha dovuto registrare fatti criminali di rilevante
dimensione, e
la diffusione di forme estreme e dolorose di disagio sciale, insieme ad
assai meno marginali espressioni di comportamenti giovanili micro-devianti
in parte riconducibili allo stereotipo psico sociologico dei protagonisti
del celebre cult-movie Gioventù bruciata. La
constatazione di una così contraddittoria realtà seppur
acquisita dal senso comune come un fatto trasparente, non penetra oltre
la superficie la coscienza collettiva, nè suscita più seri
interrogativi circa il carattere radicale dei mutamenti che hanno investito
la società.
Nella piccola cittadina dopo che nella grande metropoli industriale c'è
poca differenza, nella nuova società, spogliata di ogni ornamento
umanitario, 'Io stare insieme sembra non avere altra ragione d'essere
che il produrre e il consumare ( ... ) e tutto ciò che resta fuori
da questa visuale non sembra avere alcuna visibilità generale".
(P. Barcellona). Liberati i rapporti tra gli individui da ogni vincolo
di solidarietà di natura storica o culturale, in gabbiate
anche l'affettività dentro lo stesso ordine di ragioni, non resta
che un ultimo legame, lo scambio di cose e di  apparenze,
l'esigenza delle quali ha cessato ogni dipendenza dal bisogno per rispondere
quasi esclusivamente ad un'istanza di tipo estetico. L'estrema
facilità con cui è stata scissa e negata qualsiasi relazione
di continuità, sono stati cancellati nell'indifferenza, nell'arco
di pochi anni, capitoli essenziali della storia passata, come mai esistiti,
opere d'arte, tecniche e mestieri, tradizioni e personaggi, architetture
e documenti, è uno degli aspetti non secondari che dà forma
anch'esso a quel nuovo modello umano che pare incarnarsi nell'atto stesso
della dimenticanza. Massa
di parvenus arroganti, si è preteso che i simboli di plastica e
cartapesta della nuova ricchezza si sostituissero stabilmente ai contenuti
sostanziali della ricchezza di ogni comunità storica: alla laboriosità,
all'intelligenza, all'intraprendenza, allo spirito di sacrificio, alla
cultura, alla civiltà sedimentata nelle opere le più minute,
testimonianza di queste qualità. L'attuale
crisi smaschera la debolezza strutturale di una società e della
sua economia che non possono più riparare dietro l'attesa di altre
congiunture favorevoli, senza il recupero nella prassi e nei valori morali
di quei presupposti culturali la dignità dei quali non è
venuta meno neanche di fronte all'ingiustizia che ha dominato per secoli
i rapporti sociali. L'assenza
di qualsiasi forma di programmazione socio economica, il carattere clientelare
e distorto di tanta spesa pubblica, la dipendenza vitale di numerose attività
produttive da finanziamenti di natura assistenziale, la mancanza di un
ceto di imprenditori cosciente della propria funzione sociale, il ridimensionamento
del ruolo conflittuale del sindacato soppiantato dalla costante pratica
contrattuale, per quanto sembrino questioni che attengono all'organizzazione
economica di una moderna società, nella particolarità della
dimensione locale si intrecciano alla trasformazione di un'identità
collettiva che ha smarrito ogni codice di Riferimeto oltre all'anarchico
sovrapporsi degli interessi individuali. Dovremmo
rassegnarci all'omologazione culturale, così come la marcia trionfante
della società impone? Dare per scontato lo smarrimento nostro nei
gorghi della modernità? Ma quando uno solo dei suoi meccanismi
si inceppa come adesso, non c'è appello al progresso, capace di
offrire risposte alle domande che inevitabilmente nascono dal vuoto di
futuro che si prospetta innanzi. Quanti
hanno avuto la lucidità di pensare che la magnifica festa dell'ultimo
decennio sarebbe prima o poi finita, non sappiamo. Di certo senza una
assunzione di responsabilità decisa e coraggiosa da parte dei nuovi
gruppi dirigenti nessun automatismo potrà salvare dalla decadenza
le economie e l'identità
storico-culturale di società come quelle meridionali, la cui recente
prosperità si è sorretta su gambe di cartone. Alla
politica, che dovrà scacciare dal suo orizzonte l'ombra del potere
partitico e malavitoso sulla cosa pubblica, e alla cultura cui tocca trovare
le ragioni e gli interlocutori per un ritorno ad una progettualità
sociale, credo spetti di tracciare con fantasia e spirito d'avventura
percorsi assai diversi dal passato. E'
doveroso per tutti, prima che sia troppo tardi, cominciare a riflettere
sulla praticabilità di un modello di sviluppo che abbia nelle risorse
naturali, storiche, intellettuali e umane del territorio il suo
apparenze,
l'esigenza delle quali ha cessato ogni dipendenza dal bisogno per rispondere
quasi esclusivamente ad un'istanza di tipo estetico. L'estrema
facilità con cui è stata scissa e negata qualsiasi relazione
di continuità, sono stati cancellati nell'indifferenza, nell'arco
di pochi anni, capitoli essenziali della storia passata, come mai esistiti,
opere d'arte, tecniche e mestieri, tradizioni e personaggi, architetture
e documenti, è uno degli aspetti non secondari che dà forma
anch'esso a quel nuovo modello umano che pare incarnarsi nell'atto stesso
della dimenticanza. Massa
di parvenus arroganti, si è preteso che i simboli di plastica e
cartapesta della nuova ricchezza si sostituissero stabilmente ai contenuti
sostanziali della ricchezza di ogni comunità storica: alla laboriosità,
all'intelligenza, all'intraprendenza, allo spirito di sacrificio, alla
cultura, alla civiltà sedimentata nelle opere le più minute,
testimonianza di queste qualità. L'attuale
crisi smaschera la debolezza strutturale di una società e della
sua economia che non possono più riparare dietro l'attesa di altre
congiunture favorevoli, senza il recupero nella prassi e nei valori morali
di quei presupposti culturali la dignità dei quali non è
venuta meno neanche di fronte all'ingiustizia che ha dominato per secoli
i rapporti sociali. L'assenza
di qualsiasi forma di programmazione socio economica, il carattere clientelare
e distorto di tanta spesa pubblica, la dipendenza vitale di numerose attività
produttive da finanziamenti di natura assistenziale, la mancanza di un
ceto di imprenditori cosciente della propria funzione sociale, il ridimensionamento
del ruolo conflittuale del sindacato soppiantato dalla costante pratica
contrattuale, per quanto sembrino questioni che attengono all'organizzazione
economica di una moderna società, nella particolarità della
dimensione locale si intrecciano alla trasformazione di un'identità
collettiva che ha smarrito ogni codice di Riferimeto oltre all'anarchico
sovrapporsi degli interessi individuali. Dovremmo
rassegnarci all'omologazione culturale, così come la marcia trionfante
della società impone? Dare per scontato lo smarrimento nostro nei
gorghi della modernità? Ma quando uno solo dei suoi meccanismi
si inceppa come adesso, non c'è appello al progresso, capace di
offrire risposte alle domande che inevitabilmente nascono dal vuoto di
futuro che si prospetta innanzi. Quanti
hanno avuto la lucidità di pensare che la magnifica festa dell'ultimo
decennio sarebbe prima o poi finita, non sappiamo. Di certo senza una
assunzione di responsabilità decisa e coraggiosa da parte dei nuovi
gruppi dirigenti nessun automatismo potrà salvare dalla decadenza
le economie e l'identità
storico-culturale di società come quelle meridionali, la cui recente
prosperità si è sorretta su gambe di cartone. Alla
politica, che dovrà scacciare dal suo orizzonte l'ombra del potere
partitico e malavitoso sulla cosa pubblica, e alla cultura cui tocca trovare
le ragioni e gli interlocutori per un ritorno ad una progettualità
sociale, credo spetti di tracciare con fantasia e spirito d'avventura
percorsi assai diversi dal passato. E'
doveroso per tutti, prima che sia troppo tardi, cominciare a riflettere
sulla praticabilità di un modello di sviluppo che abbia nelle risorse
naturali, storiche, intellettuali e umane del territorio il suo  vero
serbatoio di potenzialità e di ricchezza, ponendo al centro di
un rinnovato sforzo di elaborazione collettiva la memoria di luoghi, di
sapori, di manualità, di produzioni, di tecniche, cancellate dalla
realtà troppo in fretta, inseguendo il falso miraggio di un industrialismo
che, fragile e privo di una coerente cultura, ha comportato costi altissimi
per l'integrità di un ambiente provato negli ultimi anni da una
barbarica devastazione. Una controrivoluzione culturale può opporsi
per questa via alla crisi attuale e trasformarsi in un grande progetto
democratico insieme politico ed economico, solo che ci si assuma la responsabilità
e il rischio dell'impresa.
vero
serbatoio di potenzialità e di ricchezza, ponendo al centro di
un rinnovato sforzo di elaborazione collettiva la memoria di luoghi, di
sapori, di manualità, di produzioni, di tecniche, cancellate dalla
realtà troppo in fretta, inseguendo il falso miraggio di un industrialismo
che, fragile e privo di una coerente cultura, ha comportato costi altissimi
per l'integrità di un ambiente provato negli ultimi anni da una
barbarica devastazione. Una controrivoluzione culturale può opporsi
per questa via alla crisi attuale e trasformarsi in un grande progetto
democratico insieme politico ed economico, solo che ci si assuma la responsabilità
e il rischio dell'impresa.
Tra storie e antropologia
 Scordìa
sorge sul costone di una valle naturale simile alle tante altre che nella
zona degli Iblei sono state incise nella roccia calcarea dalla corrente
impetuosa dei corsi d'acqua a regime torrentizio. Anche a Scordia tale
valle viene denominata Cava, e lo stesso nome designava il torrente che
un tempo la solcava, da Urgu tintu (località a nordovest, dove
sorgeva) scorrendo verso sud-est, in direzione del Biviere, nell'estremo
limito meridionale della Piana di Catania, nei campi leontini, ídentificati
con i campi le strigonil della mitologia. Come il vicino Colle di S. Basilio,
che però appartiene al territorio di Lentini, già in età
preistorica e protostorica anche il territorio sul quale si è sviluppato
il paese di Scordia ospitava insediamenti umani, come è attestato
dalle grotte artificiali ancora visibili nella Cava propriamente detta,
a est del centro abitato, e nel tratto in cui la valle assume il nome
di Grotta del Drago, a nord-ovest, in prossimità di Urgu tintu.
Fonti letterarie e archeologiche, poi, documentano la presenza, nello
stesso territorio, di popolazionì sìcule, greche, romane,
bìzantine, arabe e normanne. E al periodo normanno risalgono i
primi documenti scritti finora conosciuti ai quali ricorre il toponimo
Scordia. Si tratta di due diplomi (uno del 1131 e l'altro del 1151) in
cui viene sancita la donazione di alcuni possedimenti, peraltro ancora
non esattamente localizzabili con criteri scientifici, ai Cavalieri del
Tempio. Un altro documento dell' età medievale ci informa che nel
1255 il Casale di Scordia Suttana viene donato dal Papa Alessandro IV
ad un tale Nicolò di Sandùcia, nobile guelfo di Lentini.
Apprendiamo così che in quella data il territorio dell'odierna
Scordia era un feudo con un piccolo nucleo urbano localizzabile, appunto,
sul costone occidentale della Cava, attorno a quella che oggi viene indicata
come Casa Cancellieri, dai più identificata come l'antica casa
baronale. Fu Antonio Branciforte che, dopo avere "nobilitato"
il feudo portatogli in dote dalla moglie Giuseppina Canipulo, nel 1628
ottenne da Filippo IV di Spagna la licentia populandi cioè il diritto,
dietro il pagamento di 400 once,
Scordìa
sorge sul costone di una valle naturale simile alle tante altre che nella
zona degli Iblei sono state incise nella roccia calcarea dalla corrente
impetuosa dei corsi d'acqua a regime torrentizio. Anche a Scordia tale
valle viene denominata Cava, e lo stesso nome designava il torrente che
un tempo la solcava, da Urgu tintu (località a nordovest, dove
sorgeva) scorrendo verso sud-est, in direzione del Biviere, nell'estremo
limito meridionale della Piana di Catania, nei campi leontini, ídentificati
con i campi le strigonil della mitologia. Come il vicino Colle di S. Basilio,
che però appartiene al territorio di Lentini, già in età
preistorica e protostorica anche il territorio sul quale si è sviluppato
il paese di Scordia ospitava insediamenti umani, come è attestato
dalle grotte artificiali ancora visibili nella Cava propriamente detta,
a est del centro abitato, e nel tratto in cui la valle assume il nome
di Grotta del Drago, a nord-ovest, in prossimità di Urgu tintu.
Fonti letterarie e archeologiche, poi, documentano la presenza, nello
stesso territorio, di popolazionì sìcule, greche, romane,
bìzantine, arabe e normanne. E al periodo normanno risalgono i
primi documenti scritti finora conosciuti ai quali ricorre il toponimo
Scordia. Si tratta di due diplomi (uno del 1131 e l'altro del 1151) in
cui viene sancita la donazione di alcuni possedimenti, peraltro ancora
non esattamente localizzabili con criteri scientifici, ai Cavalieri del
Tempio. Un altro documento dell' età medievale ci informa che nel
1255 il Casale di Scordia Suttana viene donato dal Papa Alessandro IV
ad un tale Nicolò di Sandùcia, nobile guelfo di Lentini.
Apprendiamo così che in quella data il territorio dell'odierna
Scordia era un feudo con un piccolo nucleo urbano localizzabile, appunto,
sul costone occidentale della Cava, attorno a quella che oggi viene indicata
come Casa Cancellieri, dai più identificata come l'antica casa
baronale. Fu Antonio Branciforte che, dopo avere "nobilitato"
il feudo portatogli in dote dalla moglie Giuseppina Canipulo, nel 1628
ottenne da Filippo IV di Spagna la licentia populandi cioè il diritto,
dietro il pagamento di 400 once, di rifondare il paese e di divenirne il primo Principe. A lui si deve
l'avvio di uno sviluppo urbanistico che, orientandosi lungo le direttrici
est-ovest e nord-sud, ha assunto il caratteristico impianto a scacchiera
che mantiene ancora oggi. Anche se non vi si notano la cura e l'attenzione
che meriterebbero i monumenti più rappresentativi del centro storico,
cioè il Palazzo Branciforte (1628), la Chiesa Madre di San Rocco
(1628), l'ex convento dei Frati Riformati di San Francesco con l'annessa
chiesa di Sant'Antonio (1644), la chiesa del Purgatorio (164 8 circa),
nonché le caratteristiche case contadine. Queste ultime sono un chiaro
esempio di sapiente organizzazione dello spazio in una società
povera fondata sulla cerealicoltura quale era quella scordiense di non
molti decenni fa. In netto contrasto con i poco armoniosi palazzi, solitamente
abusivi, derivanti dal successo economico legato allo sviluppo dell'agrumicoltura,
le case contadine ancora esistenti sorgono piccole e basse a piano terra,
e, nei loro colori semplici ed elementari, presentano un prospetto segnato
da una porta e da una finestra laterale (che in qualche caso può
anche mancare); mentre l'interno è costituito da un relativamente
ampio soggiorno con in fondo due aperture che immettono rispettivamente
nell'alcova e nella stalle, spesso comunicanti tra loro; sfruttando la
di rifondare il paese e di divenirne il primo Principe. A lui si deve
l'avvio di uno sviluppo urbanistico che, orientandosi lungo le direttrici
est-ovest e nord-sud, ha assunto il caratteristico impianto a scacchiera
che mantiene ancora oggi. Anche se non vi si notano la cura e l'attenzione
che meriterebbero i monumenti più rappresentativi del centro storico,
cioè il Palazzo Branciforte (1628), la Chiesa Madre di San Rocco
(1628), l'ex convento dei Frati Riformati di San Francesco con l'annessa
chiesa di Sant'Antonio (1644), la chiesa del Purgatorio (164 8 circa),
nonché le caratteristiche case contadine. Queste ultime sono un chiaro
esempio di sapiente organizzazione dello spazio in una società
povera fondata sulla cerealicoltura quale era quella scordiense di non
molti decenni fa. In netto contrasto con i poco armoniosi palazzi, solitamente
abusivi, derivanti dal successo economico legato allo sviluppo dell'agrumicoltura,
le case contadine ancora esistenti sorgono piccole e basse a piano terra,
e, nei loro colori semplici ed elementari, presentano un prospetto segnato
da una porta e da una finestra laterale (che in qualche caso può
anche mancare); mentre l'interno è costituito da un relativamente
ampio soggiorno con in fondo due aperture che immettono rispettivamente
nell'alcova e nella stalle, spesso comunicanti tra loro; sfruttando la
 pendenza del
tetto (costituito da travi e da canne su cui poggiano coppi d'argilla),
solitamente sopra l'alcova e la stalla, è ricavato un altro ambiente,
destinato a dormitorio e/o a ripostiglio di paglia e strumenti vari, attraverso
un ammezzato di assi connesse tra loro raggiungibile con una scala a pioli.
Frequenti sono, poi, le nicchie scavate nello spessore dei muri in sostituzione
di armadi e credenze. A questi vuoti, un tempo, d'estate, in posizione
dominante in qualche parte della casa, si contrapponeva il cannizzu, il
grande recipiente cilindrico di canne intrecciate che conteneva il frumento
raccolto. Poche di queste case sono ancora integre e resistono al degrado
ed alla speculazione, grazie anche al fatto che sono
abitate da persone anziane non perfettamente integrate nella nuova società
nata dalla coltivazione intensiva degli agrumi. Alla
fine del XVIII sec. risale l'introduzione nel territorio di Scordia dell'agrumicoltura,
divenuta gradualmente il settore trainante dell'economia del paese, con
conseguente arretramento della produzione cerealicola, fino ad alcuni
decenni fa prevalente e tale da determinare usi e costumi al giorno d'oggi
non più riscontrabili. Ne rimane qualche sopravvivenza nel cerimoniale
delle feste popolari più sentite, come il
Natale, il Carnevale e la Pasqua; ma pochi sono orinai coloro che riescono
a cogliervi i legami con i riti di eliminazione e di propiziazione precristiani
che accompagnavano o precedevano le varie stagioni dell'anno in una società
contadina basata essenzialmente sulla produzione del grano. Pochi
sono coloro che riescono a leggere il valore rituale della identificazione
del grano con Dio nell'indovinello che segue, diffùso tra gli anziani
di Scordia: Amienzu
di linzola e-ccùtri cc'è ntrusciati lu Ddivinu Patri. Tanti
pila ccí A nta l'utru tanti cci-nn'è nto'sticchiu i tamatri.
(U siminatu) Valore
propiziatorio che è accentuato dalla risata oscena che questo particolare
genere poetico popolare, al quale originariamente era riconosciuta una
destinazione esclusivamente carnevalesca, suscita per favorire l'abbondanza
delle messi per simpatia nell'appellarsi esplicitamente alla fertilità
del sesso femminile, mentre anche a quello maschile
pendenza del
tetto (costituito da travi e da canne su cui poggiano coppi d'argilla),
solitamente sopra l'alcova e la stalla, è ricavato un altro ambiente,
destinato a dormitorio e/o a ripostiglio di paglia e strumenti vari, attraverso
un ammezzato di assi connesse tra loro raggiungibile con una scala a pioli.
Frequenti sono, poi, le nicchie scavate nello spessore dei muri in sostituzione
di armadi e credenze. A questi vuoti, un tempo, d'estate, in posizione
dominante in qualche parte della casa, si contrapponeva il cannizzu, il
grande recipiente cilindrico di canne intrecciate che conteneva il frumento
raccolto. Poche di queste case sono ancora integre e resistono al degrado
ed alla speculazione, grazie anche al fatto che sono
abitate da persone anziane non perfettamente integrate nella nuova società
nata dalla coltivazione intensiva degli agrumi. Alla
fine del XVIII sec. risale l'introduzione nel territorio di Scordia dell'agrumicoltura,
divenuta gradualmente il settore trainante dell'economia del paese, con
conseguente arretramento della produzione cerealicola, fino ad alcuni
decenni fa prevalente e tale da determinare usi e costumi al giorno d'oggi
non più riscontrabili. Ne rimane qualche sopravvivenza nel cerimoniale
delle feste popolari più sentite, come il
Natale, il Carnevale e la Pasqua; ma pochi sono orinai coloro che riescono
a cogliervi i legami con i riti di eliminazione e di propiziazione precristiani
che accompagnavano o precedevano le varie stagioni dell'anno in una società
contadina basata essenzialmente sulla produzione del grano. Pochi
sono coloro che riescono a leggere il valore rituale della identificazione
del grano con Dio nell'indovinello che segue, diffùso tra gli anziani
di Scordia: Amienzu
di linzola e-ccùtri cc'è ntrusciati lu Ddivinu Patri. Tanti
pila ccí A nta l'utru tanti cci-nn'è nto'sticchiu i tamatri.
(U siminatu) Valore
propiziatorio che è accentuato dalla risata oscena che questo particolare
genere poetico popolare, al quale originariamente era riconosciuta una
destinazione esclusivamente carnevalesca, suscita per favorire l'abbondanza
delle messi per simpatia nell'appellarsi esplicitamente alla fertilità
del sesso femminile, mentre anche a quello maschile si allude nella complessa metafora iniziale. E
i principi della magia simpatica vengono applicati alla identificazione
di Cristo con "il dio della vegetazione che muore e rinasce"
(il grano) nella processione del Giovedì Santo, quando i confrati
di Maria SS. Immacolata accendono il pagghiaru che deve ridare vigore
(per simpatia, appunto) a Cristo, Luce che si spegne nella Passione. Perché
possa risuscitare. E gli esempi potrebbero continuare.
si allude nella complessa metafora iniziale. E
i principi della magia simpatica vengono applicati alla identificazione
di Cristo con "il dio della vegetazione che muore e rinasce"
(il grano) nella processione del Giovedì Santo, quando i confrati
di Maria SS. Immacolata accendono il pagghiaru che deve ridare vigore
(per simpatia, appunto) a Cristo, Luce che si spegne nella Passione. Perché
possa risuscitare. E gli esempi potrebbero continuare.
Monumenti arte e religione
 Nel
1626 Antonio Branciforte fu nominato da Filippo IV re di Spagna, primo
principe di Scordia. A questa data e a questo evento si fa solitamente
risalire la fondazione del paese. In realtà le radici storiche
di Scordia risalgono a tempi ben più lontani, anche se nessuno
si è ancora occupato attentamente di questo importante aspetto.
Qualche studioso di storia locale ha infatti solamente accennato nei propri
lavori alle tracce di insediamento di civiltà, rinvenute anche
in tempi non troppo lontani, nei nostri luoghi, risalenti in qualche caso
al periodo precristiano. (Cfr. A Vecchio, "Scordia tra storia e leggenda"
Catania 1975 e V. Salvo Basso, "Reliquiae seu de iis quae superunt",
Scordia 1924). Da fonti accreditate apprendiamo, poi, che nel territorio
di Scordia, alla venuta del principe, erano già presenti degli
edifici religiosi, almeno tre chiese ed un convento di frati e, supponiamo
noi, anche abitazioni civili, case contadine che, soppure non attestano
inconfutabilmente che la convivenza degli abitanti delle terre di Scordia
fosse già disciplinata secondo precisi codici, sottintende però
come almeno alcune fondamentali funzioni della vita sociale e di culto
fossero già garantite. Il principe volle però riorganizzare
il suo feudo ridisegnandone l'assetto urbano e creando i servizi necessari
al vivere civile, in considerazione anche del rapido aumento della popolazione
che si registrò nel giro di pochi decenni, grazie alla concessione
nel 1628 da parte del re al Branciforte della "licentia populandi",
il permesso di poter popolare il proprio feudo richiamando dalle zone
circonvicine persone che avessero in animo di coltivare e far produrre
le terre che venivano assegnate loro. Le prime opere architettoniche subito
innalzate furono il palazzo principesco, la chiesa di San Rocco e la chiesa
di Sant'Antonio da Padova con l'annesso convento dei frati riformati.
Questi edifici furono dislocati sul territorio secondo uno schema triangolare
avente due ampie piazze tra la chiesa di San Rocco ed il palazzo e tra
questo e la chiesa di Sant'Antonio e, ancora, una strada costeggiante
un declivio calcareo (la Cava) congiungendo le due chiese. A nord-ovest
del palazzo fu costruita (o, forse solamente restaurata; non si hanno
notizie precise al riguardo) la chiesa dedicata a San Gregorio Magno.
In questo periodo furono anche istituite, per ognuna delle chiese su menzionate,
delle confraternite o compagnie che si occupavano dell'organizzazione
delle funzioni religiose in particolari periodi dell'anno (Cfr. M. De
Mauro, "Notizie storiche sopra Scordia inferiore" Catania 1868).
I lavori di costruzione della chiesa di Sant'Antonio e del convento furono
iniziati nel 1644 e già nel 1649 erano ultimati per metà.
Sul prospetto della chiesa furono collocati la statua del vescovo Ottavio
Branciforte (che insieme al fratello, il principe Antonio e la di lui
moglie Giuseppa Campulo, ne volle l'edificazione) e più in alto
lo stemma della famiglia. Nella chiesa di San Rocco le prime persone cominciarono
ad essere seppellite nel 1629; tre anni dopo si ha notizia del primo matrimonio
celebrato in essa. La chiesa probabilmente fu rasa al suolo dal terremoto
del 1693 che investì la Sicilia sud-orientale. Seri danni subirono
anche le altre chiese del paese e, sulla parete di levante, il palazzo
del principe. La nuova chiesa di San Rocco, l'attuale, fu edificata nei
primi anni del 700 su progetto di frate Michele da Ferla (un architetto
che ritroviamo nello stesso periodo operante pure per le chiese di Buccheri);
nel contempo funzionò da matrice la chiesa di San Gregorio Magno.
Si ha notizia del primo matrimonio celebrato nella nuova chiesa da Don
Lucio Cittadino nel 1712. Nella seconda metà del 700 furono iniziati
i lavori di ampliamento della piccola chiesa di Santa Maria Maggiore.
La chiesa, voluta da Don Matteo Imperia, un'oscura figura che ricoprì,
fra l'altro la carica di presidente del Tribunale della Santa Inquisizione,
fu inaugurata nel 1680 dal cardinale Antonio Colonna Branciforte. E' questo,
inoltre, il periodo nel quale le famiglie che hanno acquisito patente
di nobiltà innalzano maestosi edifici alcuni dei quali tutt'oggi
è possibile osservare in paese; il palazzo Modica di piazza Umberto
1, e sull'attuale via Vittorio Emanuele, i palazzi De Cristofaro e Vecchio.
Nel 1825 si iniziò la costruzione della chiesa di San Giuseppe,
che pur funzionante già qualche decennio dopo, ebbe però
il definitivo, attuale aspetto solamente nei primi anni di questo secolo.
Nel 1903 fu completata la chiesa di Santa Liberata. Fra le opere di valore
custodite nelle chiese del paese, segnaliamo, a San Rocco le tele ad olio
della Vergine del Rosario, molto rovinata, riecheggiante la pittura del
Caravaggio, e quella della Vergine coi Bambino, Sant'Anna e San Giovannino
di notevole qualità, di scuola raffaelliana, e poi la statua di
San Rocco posta all'interno di una nicchia del transetto costruito alla
metà dell'800 sotto il parrocato di Mario De Cristofaro. Nella
chiesa di Sant'Antonio ricordiamo lo splendido crocifisso attribuito dal
Maganuco a fra' Umile da Petralia e le tele di Sant'Anna e dell'Assunta,
quest'ultima assegnata a Pietro Paolo Vasta, nonché la statua dell'Ecce
Homo e quella di Sant'Anna eseguita alla fine del 700 da Gaetano Franzese.
Il chiostro del convento annesso alla chiesa, vero e proprio gioiello
di architettura, presenta sulle pareti delle pitture risalenti alla metà
del 700, eseguite con una certa approssimazione ma dall'innegabile fascino,
narranti episodi della vita di martiri dell'Ordine Francescano. La chiesa
di San Gregorio Magno si segnala oltre che per le statue del Cristo alla
bara e dei tre santi, per la preziosa incisione a bulino, probabile fine
600, raffigurante il cammino della cristianità, elaborata su un
disegno di Cristiano. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore, è esposta,
sopra l'altare maggiore una pittura su tavola raffigurante la Vergine
tra i Santi datata 1589. Due tele, Sacro Cuore di Gesù e di Maria,
e Sant'Agata, San Michele Arcangelo e Sant'Apollonia, rispettivamente
del 1782 e del 1789, sono firmate da un pittore originario di Siena, Marcello
Vieri, autore anche di un'altra opera del 1791, conservata a San Rocco,
la Vergine del Rosario e San Simone Stock. Si conservano inoltre in sacrestia,
tre bozzetti su tela di notevole valore documentario riproducenti gli
affreschi sulla volta della chiesa; quello centrale è perduto,
e un altro versa in precario stato di conservazione. Nella chiesa di San
Giuseppe, osserviamo sul secondo altare a destra la tela ad olio della
Madonna Degli Ammalati, del 1902, del pittore originario di Scordia, Giuseppe
Bacchitta, artista di notevole abilità che verso il 1912 emigrò
in Sud America. Nella chiesa di Santa Liberata merita particolare attenzione
la statua della Santa; pare che in origine questa rappresentasse Santa
Cecilia e che poi in seguito, fine 800, sia stata adattata per raffigurare
Santa Liberata; e la caratteristica grotta in pietra lavica inaugurata
nel 1914. Infine vanno ricordate la statua di San Rocco eseguita in pietra
calcarea nel 1813 da N, Bagnasco, il monumento ai caduti (193 2) di Salvatore
Pappalardo, nella villa comunale, e soprattutto la colonna con sopra la
statua della Vergine col Bambino che più volte caduta per eventi
naturali é sempre stata ricostruita; quella attuale è del
1911 e può essere considerata il vero simbolo di Scordia.
Nel
1626 Antonio Branciforte fu nominato da Filippo IV re di Spagna, primo
principe di Scordia. A questa data e a questo evento si fa solitamente
risalire la fondazione del paese. In realtà le radici storiche
di Scordia risalgono a tempi ben più lontani, anche se nessuno
si è ancora occupato attentamente di questo importante aspetto.
Qualche studioso di storia locale ha infatti solamente accennato nei propri
lavori alle tracce di insediamento di civiltà, rinvenute anche
in tempi non troppo lontani, nei nostri luoghi, risalenti in qualche caso
al periodo precristiano. (Cfr. A Vecchio, "Scordia tra storia e leggenda"
Catania 1975 e V. Salvo Basso, "Reliquiae seu de iis quae superunt",
Scordia 1924). Da fonti accreditate apprendiamo, poi, che nel territorio
di Scordia, alla venuta del principe, erano già presenti degli
edifici religiosi, almeno tre chiese ed un convento di frati e, supponiamo
noi, anche abitazioni civili, case contadine che, soppure non attestano
inconfutabilmente che la convivenza degli abitanti delle terre di Scordia
fosse già disciplinata secondo precisi codici, sottintende però
come almeno alcune fondamentali funzioni della vita sociale e di culto
fossero già garantite. Il principe volle però riorganizzare
il suo feudo ridisegnandone l'assetto urbano e creando i servizi necessari
al vivere civile, in considerazione anche del rapido aumento della popolazione
che si registrò nel giro di pochi decenni, grazie alla concessione
nel 1628 da parte del re al Branciforte della "licentia populandi",
il permesso di poter popolare il proprio feudo richiamando dalle zone
circonvicine persone che avessero in animo di coltivare e far produrre
le terre che venivano assegnate loro. Le prime opere architettoniche subito
innalzate furono il palazzo principesco, la chiesa di San Rocco e la chiesa
di Sant'Antonio da Padova con l'annesso convento dei frati riformati.
Questi edifici furono dislocati sul territorio secondo uno schema triangolare
avente due ampie piazze tra la chiesa di San Rocco ed il palazzo e tra
questo e la chiesa di Sant'Antonio e, ancora, una strada costeggiante
un declivio calcareo (la Cava) congiungendo le due chiese. A nord-ovest
del palazzo fu costruita (o, forse solamente restaurata; non si hanno
notizie precise al riguardo) la chiesa dedicata a San Gregorio Magno.
In questo periodo furono anche istituite, per ognuna delle chiese su menzionate,
delle confraternite o compagnie che si occupavano dell'organizzazione
delle funzioni religiose in particolari periodi dell'anno (Cfr. M. De
Mauro, "Notizie storiche sopra Scordia inferiore" Catania 1868).
I lavori di costruzione della chiesa di Sant'Antonio e del convento furono
iniziati nel 1644 e già nel 1649 erano ultimati per metà.
Sul prospetto della chiesa furono collocati la statua del vescovo Ottavio
Branciforte (che insieme al fratello, il principe Antonio e la di lui
moglie Giuseppa Campulo, ne volle l'edificazione) e più in alto
lo stemma della famiglia. Nella chiesa di San Rocco le prime persone cominciarono
ad essere seppellite nel 1629; tre anni dopo si ha notizia del primo matrimonio
celebrato in essa. La chiesa probabilmente fu rasa al suolo dal terremoto
del 1693 che investì la Sicilia sud-orientale. Seri danni subirono
anche le altre chiese del paese e, sulla parete di levante, il palazzo
del principe. La nuova chiesa di San Rocco, l'attuale, fu edificata nei
primi anni del 700 su progetto di frate Michele da Ferla (un architetto
che ritroviamo nello stesso periodo operante pure per le chiese di Buccheri);
nel contempo funzionò da matrice la chiesa di San Gregorio Magno.
Si ha notizia del primo matrimonio celebrato nella nuova chiesa da Don
Lucio Cittadino nel 1712. Nella seconda metà del 700 furono iniziati
i lavori di ampliamento della piccola chiesa di Santa Maria Maggiore.
La chiesa, voluta da Don Matteo Imperia, un'oscura figura che ricoprì,
fra l'altro la carica di presidente del Tribunale della Santa Inquisizione,
fu inaugurata nel 1680 dal cardinale Antonio Colonna Branciforte. E' questo,
inoltre, il periodo nel quale le famiglie che hanno acquisito patente
di nobiltà innalzano maestosi edifici alcuni dei quali tutt'oggi
è possibile osservare in paese; il palazzo Modica di piazza Umberto
1, e sull'attuale via Vittorio Emanuele, i palazzi De Cristofaro e Vecchio.
Nel 1825 si iniziò la costruzione della chiesa di San Giuseppe,
che pur funzionante già qualche decennio dopo, ebbe però
il definitivo, attuale aspetto solamente nei primi anni di questo secolo.
Nel 1903 fu completata la chiesa di Santa Liberata. Fra le opere di valore
custodite nelle chiese del paese, segnaliamo, a San Rocco le tele ad olio
della Vergine del Rosario, molto rovinata, riecheggiante la pittura del
Caravaggio, e quella della Vergine coi Bambino, Sant'Anna e San Giovannino
di notevole qualità, di scuola raffaelliana, e poi la statua di
San Rocco posta all'interno di una nicchia del transetto costruito alla
metà dell'800 sotto il parrocato di Mario De Cristofaro. Nella
chiesa di Sant'Antonio ricordiamo lo splendido crocifisso attribuito dal
Maganuco a fra' Umile da Petralia e le tele di Sant'Anna e dell'Assunta,
quest'ultima assegnata a Pietro Paolo Vasta, nonché la statua dell'Ecce
Homo e quella di Sant'Anna eseguita alla fine del 700 da Gaetano Franzese.
Il chiostro del convento annesso alla chiesa, vero e proprio gioiello
di architettura, presenta sulle pareti delle pitture risalenti alla metà
del 700, eseguite con una certa approssimazione ma dall'innegabile fascino,
narranti episodi della vita di martiri dell'Ordine Francescano. La chiesa
di San Gregorio Magno si segnala oltre che per le statue del Cristo alla
bara e dei tre santi, per la preziosa incisione a bulino, probabile fine
600, raffigurante il cammino della cristianità, elaborata su un
disegno di Cristiano. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore, è esposta,
sopra l'altare maggiore una pittura su tavola raffigurante la Vergine
tra i Santi datata 1589. Due tele, Sacro Cuore di Gesù e di Maria,
e Sant'Agata, San Michele Arcangelo e Sant'Apollonia, rispettivamente
del 1782 e del 1789, sono firmate da un pittore originario di Siena, Marcello
Vieri, autore anche di un'altra opera del 1791, conservata a San Rocco,
la Vergine del Rosario e San Simone Stock. Si conservano inoltre in sacrestia,
tre bozzetti su tela di notevole valore documentario riproducenti gli
affreschi sulla volta della chiesa; quello centrale è perduto,
e un altro versa in precario stato di conservazione. Nella chiesa di San
Giuseppe, osserviamo sul secondo altare a destra la tela ad olio della
Madonna Degli Ammalati, del 1902, del pittore originario di Scordia, Giuseppe
Bacchitta, artista di notevole abilità che verso il 1912 emigrò
in Sud America. Nella chiesa di Santa Liberata merita particolare attenzione
la statua della Santa; pare che in origine questa rappresentasse Santa
Cecilia e che poi in seguito, fine 800, sia stata adattata per raffigurare
Santa Liberata; e la caratteristica grotta in pietra lavica inaugurata
nel 1914. Infine vanno ricordate la statua di San Rocco eseguita in pietra
calcarea nel 1813 da N, Bagnasco, il monumento ai caduti (193 2) di Salvatore
Pappalardo, nella villa comunale, e soprattutto la colonna con sopra la
statua della Vergine col Bambino che più volte caduta per eventi
naturali é sempre stata ricostruita; quella attuale è del
1911 e può essere considerata il vero simbolo di Scordia.
Un "immersione" a Scordia
 Entrando
in metafora mi vedo nel mio rapporto con Scordia alla stregua di un nuotatore.
Per dar vita al coordinamento razionale dei suoi gesti egli deve necessariamente
non farsi completamente ricoprire dalle acque, di tanto in tanto volgere
in alto il volto per riempire d'aria i polmoni e proseguire. Per dar vita
a questo mio scritto entro invece in uno scafandro da palombaro e scendendo
giù, abbandono rassicurante galleggiamento natatorio. Sembra esser
tutt'uno con le più antiche pietre di Scordia impastato e fuso
con esse, il detto "Scordia scordati la via". Quasi che per
prima, nelle fondamenta d'essa, che agli inizi era poco più che
un borgo, c'abbiano scaraventata dentro una imperitura volontà
collettiva di oblianza di chi quel borgo già abitava e di chi ci
avrebbe abitato. Ho tra le mani un testo risalente al 1716. Trattasi di
un registro stampato a Palermo, nei bei caratteri marcati dell'epoca,
e pressochè intatto. E' una specie di censimento, a fini esattoriali
suppongo, compiuto negli anni 1714 e 1715, del Regno di Sicilia. Gli estensori:
i "deputati" deI regno, tra cui figura nel frontespizio il "nostro"
Don Giuseppe Branciforte, Principe di Scordia. Ma che cosina piccola era
questa Scordia pur avendo tanto di principe sui frontespizi delle regali
stampe! A pag. 17 della parte relativa alla "Descrizione generale"
risulta, alla voce "somma delle anime" essere composta di n.
1.932 delle suddette. Vizzini ne contava 9.129; Militello 6.416; Lentini
4.509. A far compagnia ai nostri antenati v'erano allora anche 80 cavalli,
59 giumente, 86 bovi e 106 vacche da aratro. Altri tempi, altre storie.
Voglio però appuntare l'attenzione sulla terminologia usata dall'estensore
settecentesco. Usa "anime" per indicare il nostro moderno -
ma quanto più freddo e incolore - persone, e "fuochi"
per famiglie, nuclei familiari. Si noti: fuochi e anime, come a dire che
allora si poteva, anche stilando un ragìonieristicocensimento,
sognare di un borgo abitato da anime, spiriti benigni, spirituali fuochi,
per non dire dei rimandi filosofici sottesi all'uso di certi vocaboli.
Scomparsi quei nostri avi di tre secoli addietro; scomparsi bovi, cavalli,
giumente; scomparso anche il mondo contadino da millenni uguale a se stesso.
Scordia possiede del suo passato pallide tracce, tutte meticolosamente
occultate, quando non cancellate. Si respira una tensione convulsa e irrefrenabile
all'oblio, all'annullamento della propria e altrui, quindi comune, memoria
storica. Un ricordo: c'era una volta un abbeveratoio in uno degli ingressi
del paese. Ero bambino e rivedo nei fotogrammi strappati alla mia memoria
gli ultimi muli, asini, cavalli al tramonto, dipinti da una luce serotina.
Era un omaggio al viandante; un ristoro meritato al lavoratore stanco
che poteva così dignitosamente ricompors1 prìma di rincasare;
un prezioso rinfresco per l'animale. Un omaggio gentile, e civile, di
antica civiltà. Vedrete,
nei comuni vicìni, conservare, nonostante la valanga cementizia,
questo vessillo urbano. A Scordia no, è sparito. Ritrovo, questa
corsa al seppellimento del proprio passato, nel cappio d'asfalto che soffoca
la fontana della "Cava" monumento alle ninfe' millenarie cacciate
da uno dei più bei luoghi di Scordia. La ritrovo nella trivialità
architettonica dello stile delle nuove abitazioni (qualcuno, mi pare Zevi,
lo ha definito " stile geometra", e non me ne vogliano gli interessati)
spuntate come funghi in tutto il territorio urbano e non. Guardandole,
queste monumentali case, si avverte una fireddezza glaciale: impersonali
e sìlenti. Che senso avrebbe adesso vedere appesi in quelle balconate
immense - simili a corone di vile metallo su ancor meno nobili teste "raste"
di basilico e corone di peperoncini rossi e bucce d'arancia ad essiccare
al sole? Tutte "cose" che avevano un senso quando all'interno
si contavano i "fuochi" e a parlarsi erano le "anime".
Scordia obliosa
del passato, ma moderna. Mi trastullo coi termini per dire cosa? Che ciò
che c'è di buono, in questo paese non va cercato nell'orgoglio
della propria identità, del proprio passato, della memoria storica.
Nessuno piange
per un arco di pietra tagliato per ricavarne un "funzionale"
garage. Nata per dimenticare e dimenticarsi, questa comunità trova
in ciò la sua principale virtù, in questa sorta d'anarchia
che dìventa inevitabilmente tolleranza, la coscienza che può
esserci posto per tutti. Non ti sì chiede delle tue radici, del
tuo passato; ti
si offre una carta bianca su cui poter scrivere. La naturale gentilezza
della gente è ciò che colpisce il viandante frettoloso o
il visitatore più o meno convinto. Certi mali non sono endemici,
piuttosto frutto delle contingenze storiche. La
mafia, ad esempio, non si sapeva che fosse. C'erano malavitosi, questo
si, ma tutto sommato di rubagalline si è trattato, sino a che...
sino a che sono arrivati gli "anni 80", e con essi il grande
traffico di droga, l'arricchimetno facile e improvviso, il pizzo in grande
scala, e anche il bossettino locale, oggi pentito. Ma vennero anche i
morti ammazzati. Cosa inaudita fino alla fine degli anni 70 in questo
paese. E la
gente, questa gente laboriosa, silenziosa, "anarchica", ha fatto
finta di piegarsi, di tacere omertosamente. In realtà alla violenza
organizzata ha concesso il minimo indispensabile. Aspettava che lo Stato
si svegliasse dal lungo sonno. E quando è stata chiamata a manifestare
collettivamente lo ha fatto. Folte e compatte le manifestazioni di piazza
contro gli analfabeti armati dì mitra. E accanto alla folla, anonima
e materna (perchè portatrice delle ragioni della vita e della sua
prosecuzione) alcuni,
organizzati in associazioni o partiti, che hanno saputo dire una coraggiosa
parola in più. E
c'è chi con la vita ha pagato la sua dignità di uomo: il
dottor Nicola D'Antrassi, unico illuminato esponente di una classe imprenditoriale
locale, i commercianti di agrumi, che non ha mai, nemmeno lontanamente,
capito quale funzione sociale, civile e culturale potrebbe avere. La
campagna grassa e ammantata dei sempre verdi di agrumeti e la solarità
dei luoghi la ritrovi tutta nel largo sorriso dei bambini di Scordia.
A loro tutto viene perdonato. E fra parentesi, sono loro a Scordia i veri
dominatori della strada. A due marmocchi che giocano, incuranti
del traffico, quasi a sfidarlo, nessuno fa premure e si aspetta con pazienza
che tirino il calcio risolutore al pallone, o l'ultimo divincolarsi dalla
ressa. L'automobilista cittadino che per caso o necessità capiti
da queste parti si metterà le mani ai capelli con velocità
urbane, con o senza traffico, che raramente superano i venti all'ora.
E i giovani, i coccolati, sbandierati, enfatizzati, giovani? In massima
parte concentrati presso il "grande occhio", la Villa comunale,
piccolo recinto verde nato nei primi decenni del secolo presente, dove
si radunano per "vedere"
e farsi vedere, e nient'altro. Al punto che il forestiero rimane smarrito
dinanzi a tanta confusione, soprattutto serale. Non trovando spiegazione
alcuna a tanto assembrarsi, alla fine avrà la sensazione di avere
assistito 'ad una superba, perchè spontanea, rappresentazione teatrale
fondata sul perfetto bluff che il teatro incarna nel suo magico gioco
di finzione.
Entrando
in metafora mi vedo nel mio rapporto con Scordia alla stregua di un nuotatore.
Per dar vita al coordinamento razionale dei suoi gesti egli deve necessariamente
non farsi completamente ricoprire dalle acque, di tanto in tanto volgere
in alto il volto per riempire d'aria i polmoni e proseguire. Per dar vita
a questo mio scritto entro invece in uno scafandro da palombaro e scendendo
giù, abbandono rassicurante galleggiamento natatorio. Sembra esser
tutt'uno con le più antiche pietre di Scordia impastato e fuso
con esse, il detto "Scordia scordati la via". Quasi che per
prima, nelle fondamenta d'essa, che agli inizi era poco più che
un borgo, c'abbiano scaraventata dentro una imperitura volontà
collettiva di oblianza di chi quel borgo già abitava e di chi ci
avrebbe abitato. Ho tra le mani un testo risalente al 1716. Trattasi di
un registro stampato a Palermo, nei bei caratteri marcati dell'epoca,
e pressochè intatto. E' una specie di censimento, a fini esattoriali
suppongo, compiuto negli anni 1714 e 1715, del Regno di Sicilia. Gli estensori:
i "deputati" deI regno, tra cui figura nel frontespizio il "nostro"
Don Giuseppe Branciforte, Principe di Scordia. Ma che cosina piccola era
questa Scordia pur avendo tanto di principe sui frontespizi delle regali
stampe! A pag. 17 della parte relativa alla "Descrizione generale"
risulta, alla voce "somma delle anime" essere composta di n.
1.932 delle suddette. Vizzini ne contava 9.129; Militello 6.416; Lentini
4.509. A far compagnia ai nostri antenati v'erano allora anche 80 cavalli,
59 giumente, 86 bovi e 106 vacche da aratro. Altri tempi, altre storie.
Voglio però appuntare l'attenzione sulla terminologia usata dall'estensore
settecentesco. Usa "anime" per indicare il nostro moderno -
ma quanto più freddo e incolore - persone, e "fuochi"
per famiglie, nuclei familiari. Si noti: fuochi e anime, come a dire che
allora si poteva, anche stilando un ragìonieristicocensimento,
sognare di un borgo abitato da anime, spiriti benigni, spirituali fuochi,
per non dire dei rimandi filosofici sottesi all'uso di certi vocaboli.
Scomparsi quei nostri avi di tre secoli addietro; scomparsi bovi, cavalli,
giumente; scomparso anche il mondo contadino da millenni uguale a se stesso.
Scordia possiede del suo passato pallide tracce, tutte meticolosamente
occultate, quando non cancellate. Si respira una tensione convulsa e irrefrenabile
all'oblio, all'annullamento della propria e altrui, quindi comune, memoria
storica. Un ricordo: c'era una volta un abbeveratoio in uno degli ingressi
del paese. Ero bambino e rivedo nei fotogrammi strappati alla mia memoria
gli ultimi muli, asini, cavalli al tramonto, dipinti da una luce serotina.
Era un omaggio al viandante; un ristoro meritato al lavoratore stanco
che poteva così dignitosamente ricompors1 prìma di rincasare;
un prezioso rinfresco per l'animale. Un omaggio gentile, e civile, di
antica civiltà. Vedrete,
nei comuni vicìni, conservare, nonostante la valanga cementizia,
questo vessillo urbano. A Scordia no, è sparito. Ritrovo, questa
corsa al seppellimento del proprio passato, nel cappio d'asfalto che soffoca
la fontana della "Cava" monumento alle ninfe' millenarie cacciate
da uno dei più bei luoghi di Scordia. La ritrovo nella trivialità
architettonica dello stile delle nuove abitazioni (qualcuno, mi pare Zevi,
lo ha definito " stile geometra", e non me ne vogliano gli interessati)
spuntate come funghi in tutto il territorio urbano e non. Guardandole,
queste monumentali case, si avverte una fireddezza glaciale: impersonali
e sìlenti. Che senso avrebbe adesso vedere appesi in quelle balconate
immense - simili a corone di vile metallo su ancor meno nobili teste "raste"
di basilico e corone di peperoncini rossi e bucce d'arancia ad essiccare
al sole? Tutte "cose" che avevano un senso quando all'interno
si contavano i "fuochi" e a parlarsi erano le "anime".
Scordia obliosa
del passato, ma moderna. Mi trastullo coi termini per dire cosa? Che ciò
che c'è di buono, in questo paese non va cercato nell'orgoglio
della propria identità, del proprio passato, della memoria storica.
Nessuno piange
per un arco di pietra tagliato per ricavarne un "funzionale"
garage. Nata per dimenticare e dimenticarsi, questa comunità trova
in ciò la sua principale virtù, in questa sorta d'anarchia
che dìventa inevitabilmente tolleranza, la coscienza che può
esserci posto per tutti. Non ti sì chiede delle tue radici, del
tuo passato; ti
si offre una carta bianca su cui poter scrivere. La naturale gentilezza
della gente è ciò che colpisce il viandante frettoloso o
il visitatore più o meno convinto. Certi mali non sono endemici,
piuttosto frutto delle contingenze storiche. La
mafia, ad esempio, non si sapeva che fosse. C'erano malavitosi, questo
si, ma tutto sommato di rubagalline si è trattato, sino a che...
sino a che sono arrivati gli "anni 80", e con essi il grande
traffico di droga, l'arricchimetno facile e improvviso, il pizzo in grande
scala, e anche il bossettino locale, oggi pentito. Ma vennero anche i
morti ammazzati. Cosa inaudita fino alla fine degli anni 70 in questo
paese. E la
gente, questa gente laboriosa, silenziosa, "anarchica", ha fatto
finta di piegarsi, di tacere omertosamente. In realtà alla violenza
organizzata ha concesso il minimo indispensabile. Aspettava che lo Stato
si svegliasse dal lungo sonno. E quando è stata chiamata a manifestare
collettivamente lo ha fatto. Folte e compatte le manifestazioni di piazza
contro gli analfabeti armati dì mitra. E accanto alla folla, anonima
e materna (perchè portatrice delle ragioni della vita e della sua
prosecuzione) alcuni,
organizzati in associazioni o partiti, che hanno saputo dire una coraggiosa
parola in più. E
c'è chi con la vita ha pagato la sua dignità di uomo: il
dottor Nicola D'Antrassi, unico illuminato esponente di una classe imprenditoriale
locale, i commercianti di agrumi, che non ha mai, nemmeno lontanamente,
capito quale funzione sociale, civile e culturale potrebbe avere. La
campagna grassa e ammantata dei sempre verdi di agrumeti e la solarità
dei luoghi la ritrovi tutta nel largo sorriso dei bambini di Scordia.
A loro tutto viene perdonato. E fra parentesi, sono loro a Scordia i veri
dominatori della strada. A due marmocchi che giocano, incuranti
del traffico, quasi a sfidarlo, nessuno fa premure e si aspetta con pazienza
che tirino il calcio risolutore al pallone, o l'ultimo divincolarsi dalla
ressa. L'automobilista cittadino che per caso o necessità capiti
da queste parti si metterà le mani ai capelli con velocità
urbane, con o senza traffico, che raramente superano i venti all'ora.
E i giovani, i coccolati, sbandierati, enfatizzati, giovani? In massima
parte concentrati presso il "grande occhio", la Villa comunale,
piccolo recinto verde nato nei primi decenni del secolo presente, dove
si radunano per "vedere"
e farsi vedere, e nient'altro. Al punto che il forestiero rimane smarrito
dinanzi a tanta confusione, soprattutto serale. Non trovando spiegazione
alcuna a tanto assembrarsi, alla fine avrà la sensazione di avere
assistito 'ad una superba, perchè spontanea, rappresentazione teatrale
fondata sul perfetto bluff che il teatro incarna nel suo magico gioco
di finzione. Fingono questi giovani una vita che non c'è, un ruolo che non hanno.
Ma, si badi,
che non sognano nemmeno d'avere. Un lamento monodico querulo, questo è
il loro essere giovani. Voglia di fare: nessuna, in realtà. Le
associazioni, i singoli, che hanno prodotto, negli ultimi dieci, quindici
anni, una mole, imponente per Scordia, di iniziative (concerti, mostre,
cineforum, conferenze, teatro, libri addirittura) per il giovane del "grande
occhio" non sono mai esistite, non esistono. E
mai esisteranno. Si vuol vivere così a Scordia, in pace con se
stessi e col mondo, immemori di tutto, protesi soltanto a godersi il sole
e un'eterna primavera. Scordia così magnificamente anarchica e
tollerante, pacifica e sorniona, e tragicamente smemorata. Forse per questo
così assolutamente e irrimediabilmente
siciliana.
Fingono questi giovani una vita che non c'è, un ruolo che non hanno.
Ma, si badi,
che non sognano nemmeno d'avere. Un lamento monodico querulo, questo è
il loro essere giovani. Voglia di fare: nessuna, in realtà. Le
associazioni, i singoli, che hanno prodotto, negli ultimi dieci, quindici
anni, una mole, imponente per Scordia, di iniziative (concerti, mostre,
cineforum, conferenze, teatro, libri addirittura) per il giovane del "grande
occhio" non sono mai esistite, non esistono. E
mai esisteranno. Si vuol vivere così a Scordia, in pace con se
stessi e col mondo, immemori di tutto, protesi soltanto a godersi il sole
e un'eterna primavera. Scordia così magnificamente anarchica e
tollerante, pacifica e sorniona, e tragicamente smemorata. Forse per questo
così assolutamente e irrimediabilmente
siciliana.
Un allievo di Raffaello nella chiesa
Nella parte sinistra del transetto della chiesa di S. Rocco a Scordia, posta in alto sulla parete di fronte la porta che immette in sacrestia, si conserva all'interno di una semplice cornice a stucco, una tela ad olio che raffigura, a destra, la Vergine con sulle ginocchia il Bambino che benedice S. Giovannino posto più in basso a sinistra, al centro S. Elisabetta e, 'Infine, sullo sfondo, in alto a sinistra, S. Giuseppe. La tela è di qualità indubbia, e ha più volte destato l'interesse e l'ammirazione di molti osservatori, alcuni dei quali esperti dei settore. L'impostazione e lo stile riccheggiano inconfutabilmente i canoni della pittura raffaelliana. Si veda ad esempio la posizione rialzata del ginocchio destro della Vergine su cui si appoggia il Bambino, come ad una spalliera, che richiama l'opera di Raffaello la " Madonna della seggiola". Le prime notizie sull'opera risalgono a circa il 1943, quando molto impolverata e priva di adeguato supporto era collocata, insieme ad un'altro dipinto, su una parete della chiesa, al buio, vicino alla porticina che dà accesso alla scala per il campanile. A quel tempo la tela interessò alcuni militari inglesi ed americani presenti nel paese, che sì offrirono, pure, di acquistarla. Il parroco dei periodo, S. Failla, deducendo da tale richiesta l'importanza e il valore dell'opera, pensò, invece, di farla opportunamente pulíre dalla polvere e, forse, dopo averla fatta sottoporre ad un intervento di restauro, di darle una sede più idonea facendola sottoporre ad un intervento di restauro, di darle una sede più idonea facendola collocare su una parete della cappella del Sacramento, dalla quale, neì primi anni SO, fu spostata nel luogo ove si trova oggi, all'interno di una cornice a stucco fatta eseguire per la circostanza. Di recente, abbiamo avuto modo dì osservare un dipinto che ricalca in modo identico (se si esclude per alcune lievissime differenze di posizione delle figure) il soggetto raffigurato sulla tela di S. Rocco, esposto nella grande cattedrale di S. Giovanni, sopra un'arcata della cappella di Francia, alla Valletta a Malta. Nell'archivio del museo di S. Giovanni, annesso alla cattedrale, che il personale ci ha gentilmente messo a disposizione, abbiamo potuto appurare che il dipinto, secondo quanto trascritto sui registri, è attribuito a Giovan Francesco Penni detto il Fattore (Firenze 1488 c.a. Napoli 1528) allievo di Raffaello. Dal confronto delle due opere si osserva, però, che quella di Scordia è leggermente meno larga (ha dimensioni rettangolari e non quadrate come il dipinto di Valletta), ma sappiamo anche che questa, dopo essere stata prelevata dalla sede originaria, nel 1943, fu tagliata ai bordi ,laterali completamente marci (di più a destra) dove, in ogni caso, non vi era rappresentato nulla di importante (delle zone al buio del caseggiato in cui si svolge la scena). Pertanto le due tele, in origine, dovevano essere identiche non solo per il soggetto raffiggurato, ma, probabilmente, anche perle dimensioni, Oltre a ciò, notiamo che l'opera di Valletta, sicuramente restaurata, evidenzia dei colori più accesi e una maggiore accentuazione dei contrasti chiaroscurali rispetto a quella di Scordia che, peraltro, versa in precario stato di conservazione. A prescindere da queste considerazioni si può, comunque, a mio avviso, affermare che la fattura della nostra opera è per nulla inferiore a quella di Valletta, anzi, per certi versi, nel dipinto della chiesa di S. Rocco, dalle tonalità più imbrunite, si realizza molto meglio la lezione di Raffaello nel delicato sfumato con cui è trattata la figura del S. Giovannino. Il Penni oltre ad essere fedele allievo di Raffaello ne fu, anche, prezioso collabratore, intervenendo, tra l'altro, nella esecuzione dell'ultima grande paia dell'urbinate; la "Trasfigurazione". li fattore seguì presto Raffaello a Roma, e alla morte del Maestro (1520), divenuto coerede dei suoi beni, insieme a Giulio Romano, si trasferì a Mantova e, poi, dopo un breve ritorno a Roma, a Napoli dove morì nel 1528. Da ciò che ci risulta nella vita di questo artista non vi è traccia di una sua permanenza a Malta odi commissìoní ricevute da quel luogo, nè, a dire il vero, di contatti con la Sicilia. Ma se il dipinto di Valietta è stato eseguito dal Penni, e nonostante quanto prima affermato non vi è nessuna ragione per non crederlo, data la magnificenza con la quale i Gran Maestri dell'Ordine dei Cavalieri di Malta amavano arricchire il patrimonio d'arte dell'isola con opere di valore provenienti in spe modo dalle botteghe italiane (oltre, naturalmente, invitando gli artisti ad operare direttamente nell' isola), si devo pur considerare che quella di S. Rocco per la fattura tecnica e le qualità espressive potrebbe essere, a mio avviso, opera di un artista motto vicino al Penni, con il quale aveva soggetti in comune da dipingere, e quindi alla scuola di Raffaello. Tale ignoto artista potrebbe essere uno fra i tantissimi pittori che si ispirano all'arte dell'urbinate, o, magari, un allìevo dello stesso Penni; evito di fare nomi poichè siamo pur sempre nel campo delle pure ipotesi. Non è, poi completamente da escludere una ulteriore possibilità, cioè che il dipinto di Malta e quello di S. Rocco siano entrambi opere dei Penni; quest'ultimo, magari, eseguito a Napoli e poi in Sicilia, possibìlmente per merito dei principi Branciforte. Credo comunque, al di là di queste mio riflessioni fondate in massima parte su delle intuizioni che necessitano, ovviamente, di essere sostenute e comprovate da ulteriori analisi e verifiche, che fosse il caso di dare giusto risalto ad una fra le opere di pittura più importanti appartenenti al nostro patrimonio artistiCO.
Dalla disgregazione sociale e culturale allo sviluppo : Che fare?
La crisi economica l'avverti subito appena arrivi in paese. L'avverti ancora di più appena scambi due parole con le nuove leve politiche locali, le quali, come in un consulto medico, la radiografano in tutti i suoi risvolti sociali e culturali. Con l'aggravante di non avere strumenti per curare il loro malato. Perchè lo Stato nonostante i conclamati programmi di intervento a favore dello sviluppo socio-economico, riduce le disponibilità operative degli Enti Locali? Anni di identificazione tra amministrazione della cosa pubblica e potere sono difficili da smaltire, il loro retaggio è ancora pesantemente presente nella realtà locale. Ciò nonostante le nuove leve politiche non demordono più di tanto. Con forza chiedono allo Stato una maggiore consapevolezza della crisi economica in atto, programmando e realizzando interventi non più episodici ma sostanziali, in primo luogo incentivando l'industria di trasformazione, commercializzazione e conserviera e intervenendo per rilanciare l'agricoltura. Con forza cercano di affrontare il vero dramma della cittadina, la disgregazione sociale e culturale. E a tal fine sono orientati tutti i loro sforzi. Con sorprendente sintonia tutte puntano alla realizzazione di centri di aggregazione dove i giovani possano riscoprire il gusto della buona musica, del teatro, dell'arte, le proprie radici; iniziando a lavorare con le scuole, dalle materne alle superiori, fiancheggiando le problematiche giovanili in tutte le loro evoluzioni, riavviando le attività produttive dall'edilizia, all'agricoltura, all'artigianato. Il tutto al fine di elaborare una piattaforma unitaria da proporre al ministro per l'agricoltura ; promuovendo strutture consortili, creando i presupposti per una loro sempre più spinta aggregazione; rafforzando le strutture di servizio per un ruolo di rilancio dell'agricoltura. Stato e Regione permettendo.