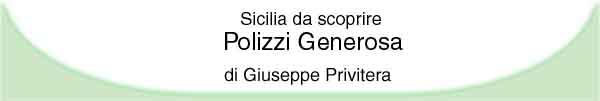Una giornata a Polizzi Generosa
Il territorio e le risorse ambientali
Chiese palazzi ed opere d'arte
Agosto Madonita Il ballo della Cordella
Un passato da Rinascimento
"Lassù nelle Madonie, che è il nome degli Appennini di Sicilia, dove non sono tornato ancora, il paese dei mieí primi anni ha spazio. In tutto il gran scenario - oleandri lungo la valle classica, olivi di greppo in greppo, vette chiare calanti a schiera dagli acropoli del centro al mare, infine il mare di Imera, tagliato a spicchi dietro l'ultima quinta - non si vede altra città o villaggio. Polizzi Generosa drappeggiata nel suo superbo epiteto, torreggia sola. "
 Chi
parla così dei suoi luoghi d'infanzia è lo scrittore polizzano
Giuseppe Antonio Borgese. Il "gran scenario" è quello
appunto di Polizzi Generosa,una delle antiche città demaniali della
Sicilia, distesa su un colle alto 917 metri dal quale lo sguardo si posa
su un ampio e intenso paesaggio formato dai contrafforti delle Madonie
e da vallate dominate dal verde dei noccioleti. Per questa sua incantevole
posizione geografica è certamente la base di partenza ideale per
la visita al parco delle Madonie e per le stazioni sciistiche invernali
di Piano Battaglia. Di questa località,talmente ricca di natura,storia,cultura
e arte da meritare una visita non frettolosa,cercheremo di restituirvi
con questo servizio le sensazioni di curiosità e gradevolezza che
ha provocato in noi, visitandola. Durante gli sbancamenti per la costruzione
di un edificio scolastico, in contrada S. Pietro, in una località
detta "puputuni",
Chi
parla così dei suoi luoghi d'infanzia è lo scrittore polizzano
Giuseppe Antonio Borgese. Il "gran scenario" è quello
appunto di Polizzi Generosa,una delle antiche città demaniali della
Sicilia, distesa su un colle alto 917 metri dal quale lo sguardo si posa
su un ampio e intenso paesaggio formato dai contrafforti delle Madonie
e da vallate dominate dal verde dei noccioleti. Per questa sua incantevole
posizione geografica è certamente la base di partenza ideale per
la visita al parco delle Madonie e per le stazioni sciistiche invernali
di Piano Battaglia. Di questa località,talmente ricca di natura,storia,cultura
e arte da meritare una visita non frettolosa,cercheremo di restituirvi
con questo servizio le sensazioni di curiosità e gradevolezza che
ha provocato in noi, visitandola. Durante gli sbancamenti per la costruzione
di un edificio scolastico, in contrada S. Pietro, in una località
detta "puputuni", è venuta alla luce una necropoli ellenistica. Data l'importanza
storico archeologica del ritrovamento, la soprintendenza ai beni culturali
di Palermo ha affidato al prof. Amedeo Tullio ed alla sua équipe
l'esecuzione di una serie di saggi di verifica, i cui risultati sono ben
documentati in una piccola mostra grafica e fotografica allestita nella
chiesa bizantina di S. Pancrazio. La scoperta di queste testimonianze
concrete delle più antiche forme di vita organizzata nel territorio,
permette di "rileggere" la controversa storia delle origini
della cittadina. Già rinvenimentì casuali di materiali ceramici
e numismatici (databili tra il quarto ed il terzo sec. a.C.), nonché
il ritrovamento della statua della cosiddetta "Iside", avevano fornito delle ipotesi e riflessioni sull'origine e sull'esistenza
di una frequentazione greco-cartaginese del sito. Sono stati effettuati
nove saggi archeologici con l'esplorazione di venticinque sepolture; i
manufatti recuperati, costituiti quasi esclusivamente da vasi di importazione,
sono riconoscibili in topologie note e diffuse in tutta la Sicilia ellenizzata.
Come scrive il prof. Tullio nella sua relazione: "Cìò
potrebbe forse dimostrare a
è venuta alla luce una necropoli ellenistica. Data l'importanza
storico archeologica del ritrovamento, la soprintendenza ai beni culturali
di Palermo ha affidato al prof. Amedeo Tullio ed alla sua équipe
l'esecuzione di una serie di saggi di verifica, i cui risultati sono ben
documentati in una piccola mostra grafica e fotografica allestita nella
chiesa bizantina di S. Pancrazio. La scoperta di queste testimonianze
concrete delle più antiche forme di vita organizzata nel territorio,
permette di "rileggere" la controversa storia delle origini
della cittadina. Già rinvenimentì casuali di materiali ceramici
e numismatici (databili tra il quarto ed il terzo sec. a.C.), nonché
il ritrovamento della statua della cosiddetta "Iside", avevano fornito delle ipotesi e riflessioni sull'origine e sull'esistenza
di una frequentazione greco-cartaginese del sito. Sono stati effettuati
nove saggi archeologici con l'esplorazione di venticinque sepolture; i
manufatti recuperati, costituiti quasi esclusivamente da vasi di importazione,
sono riconoscibili in topologie note e diffuse in tutta la Sicilia ellenizzata.
Come scrive il prof. Tullio nella sua relazione: "Cìò
potrebbe forse dimostrare a  Polizzi
da un lato la presenza di una comunità non sufficientemente numerosa
da giustificare una produzione locale e dall'altro una maggiore disponibilità
economica ed un gusto raffinato. In ogni caso le tipologie ceramiche dimostrano
l'intensità dei contatti e degli scambi con le popolazioni viciniori
in relazione alla posizione stessa del centro lungo la via di penetrazione
verso l'entroterra a partire dalle città costiere". La
datazione del sito va dalla metà del IV al 111 sec. a C. Tra ì
reperti notevole è una grande anfora cineraria decorata a figure
rosse con una scena figurata
su ciascun lato (Herakles e il leone Nemeo e scena di gineceo) che 4 4
si segnala per la qualità del disegno, la sobrietà delle
figurazioni che... riteniamo essere opera di un artigiano colto e sensibile
che si ricollega alla più pura tradizione attica ". Questa
prima fase di scavi ha già delineato l'importanza della necropoli
documentando l'esistenza di un antico anonimo centro da individuare al
di sotto dell'attuale Polizzi e segna certamente l'inizio di un nuovo
capitolo della sua storia che confermerebbe un suo "continuum"
storico,già ben documentato per i periodi successivi, di importante
nodo di traffico e punto di confluenza delle vie mercantili che univano
Palermo a Messina ed alle altre città siciliane. Polizzi infatti
fin dal periodo medievale ha costituito una via di comunicazione obbligata
tra il versante nord e sud dell'isola ed era attraversata da due "trazzere"
regie, l'una detta "Messina montagne" che collegava appunto
Palermo con Messina,
Polizzi
da un lato la presenza di una comunità non sufficientemente numerosa
da giustificare una produzione locale e dall'altro una maggiore disponibilità
economica ed un gusto raffinato. In ogni caso le tipologie ceramiche dimostrano
l'intensità dei contatti e degli scambi con le popolazioni viciniori
in relazione alla posizione stessa del centro lungo la via di penetrazione
verso l'entroterra a partire dalle città costiere". La
datazione del sito va dalla metà del IV al 111 sec. a C. Tra ì
reperti notevole è una grande anfora cineraria decorata a figure
rosse con una scena figurata
su ciascun lato (Herakles e il leone Nemeo e scena di gineceo) che 4 4
si segnala per la qualità del disegno, la sobrietà delle
figurazioni che... riteniamo essere opera di un artigiano colto e sensibile
che si ricollega alla più pura tradizione attica ". Questa
prima fase di scavi ha già delineato l'importanza della necropoli
documentando l'esistenza di un antico anonimo centro da individuare al
di sotto dell'attuale Polizzi e segna certamente l'inizio di un nuovo
capitolo della sua storia che confermerebbe un suo "continuum"
storico,già ben documentato per i periodi successivi, di importante
nodo di traffico e punto di confluenza delle vie mercantili che univano
Palermo a Messina ed alle altre città siciliane. Polizzi infatti
fin dal periodo medievale ha costituito una via di comunicazione obbligata
tra il versante nord e sud dell'isola ed era attraversata da due "trazzere"
regie, l'una detta "Messina montagne" che collegava appunto
Palermo con Messina, e l'altra detta "Montagna-marine" che collegava Palermo con
Licata. E ancora, a Polizzi confluivano altre due importanti arterie che
la mettevano in comunicazione con Catania e Caltagirone. Come scrive Vincenzo
Abbate (Inventario Polizzano, Palermo, 1992): ''Polizzi veniva a costituire
il nodo principale di un sistema viario... centro attivo di transito di
mercati, considerando che per queste vie passavano i re, i vicerè
e la loro corte, trasmigravano greggi, passavano il grano, le mercanzie,
i mercanti, i bordonari che a dorso di mulo portavano da Palermo nei paesi
dell'entroterra sculture, polittici, stendardi e gonfaloni dipinti destinati
a chiese e confraternite". Di conseguenza la sua storia si sposa
in generale con quella dell'isola. Fu centro militare dei bizantini, i
quali avrebbero costruito una fortificazione sulla roccia (Basilea-polis)
da cui secondo alcuni avrebbe origine il nome. Dalla fine del IX sec.,
nonostante la conquista musulmana, continuò ad esistere un quartiere
bizantino attorno alla chiesa di S. Pancrazio, una delle più antiche
del paese e luogo di culto greco fino al XVI sec. Recentemente restaurata
è sede storica della omonima confraternita che la gestisce, la
quale in passato s'era assunta l'obbligo di seppellire tutti i poveri
della città. Notevole nell'altare maggiore la paia di Giuseppe
Salerno detto "lo zoppo di Gangi". A partire dall'undicesimo
secolo la storia di Polizzi si intreccia con quella della conquista e
della dominazione normanna. Il conte Ruggero, conquistato il paese intorno
al 1071, lo trasformò da modesto casale in un'importante insediamento
fortificato che ebbe il suo maggior punto di forza nel "Castellazzo".
Nella vallata sottostante ebbe luogo uno scontro tra milizie normanne
e arabe che portò alla disfatta di queste ultime. Da allora, secondo
alcuni storici, questo
e l'altra detta "Montagna-marine" che collegava Palermo con
Licata. E ancora, a Polizzi confluivano altre due importanti arterie che
la mettevano in comunicazione con Catania e Caltagirone. Come scrive Vincenzo
Abbate (Inventario Polizzano, Palermo, 1992): ''Polizzi veniva a costituire
il nodo principale di un sistema viario... centro attivo di transito di
mercati, considerando che per queste vie passavano i re, i vicerè
e la loro corte, trasmigravano greggi, passavano il grano, le mercanzie,
i mercanti, i bordonari che a dorso di mulo portavano da Palermo nei paesi
dell'entroterra sculture, polittici, stendardi e gonfaloni dipinti destinati
a chiese e confraternite". Di conseguenza la sua storia si sposa
in generale con quella dell'isola. Fu centro militare dei bizantini, i
quali avrebbero costruito una fortificazione sulla roccia (Basilea-polis)
da cui secondo alcuni avrebbe origine il nome. Dalla fine del IX sec.,
nonostante la conquista musulmana, continuò ad esistere un quartiere
bizantino attorno alla chiesa di S. Pancrazio, una delle più antiche
del paese e luogo di culto greco fino al XVI sec. Recentemente restaurata
è sede storica della omonima confraternita che la gestisce, la
quale in passato s'era assunta l'obbligo di seppellire tutti i poveri
della città. Notevole nell'altare maggiore la paia di Giuseppe
Salerno detto "lo zoppo di Gangi". A partire dall'undicesimo
secolo la storia di Polizzi si intreccia con quella della conquista e
della dominazione normanna. Il conte Ruggero, conquistato il paese intorno
al 1071, lo trasformò da modesto casale in un'importante insediamento
fortificato che ebbe il suo maggior punto di forza nel "Castellazzo".
Nella vallata sottostante ebbe luogo uno scontro tra milizie normanne
e arabe che portò alla disfatta di queste ultime. Da allora, secondo
alcuni storici, questo  luogo
prese il nome di "Piano della Battaglia". Dei castello, come
scrive M. G. Montalbano, "ne fa menzione Idrisi, storico arabo del
XII sec., che ne sottolinea la posizione eminente e il territorio ricco
di campi da seminare e fertili terreni". Esso costituì il
primo nucleo abitativo attorno al quale si costituì il borgo medievale.
Attualmente, nonostante il degrado in cui si trova, è ancora possibile
identificarne l'arca, sebbene sia stata in parte occupata dal Palazzo
Gagliardo. Di esso e dell'antico abitato di Polizzi ci si può fare
una idea più precisa osservando la tela dello "Zoppo di Gangi"
nella paia d'altare del "Collegio di Maria", raffigurante il
patrocinio di S.Gandolfo (1620). Il castello fu residenza della contessa
Adelasia, assegnataria del feudo di Polizzi, che diede un consistente
impulso allo sviluppo urbanistico della città legato alla crescita
della popolazione grazie anche alla venuta di famiglie dal nord. Il suo
rapido sviluppo la portò ad essere inclusa tra le città
demaniali della Sicilia, divenne cioè una città regia, centro
di prestigio rispetto all'agglomerato feudale, con privilegi e prerogative,
dominante su un vasto territorio (quello di Polizzi era di kmq. 134,33,
con solo 7300 abitanti). Come tutte le città demaniali essa si
fregiò di un'appellativo datole da un monarca per meriti speciali
(il patronomico " Generosa" fu concesso a Polizzi da Federico
Il nel 1234); possiede le reliquie dei santo patrono (S. Gandolfo) ed
un gran numero di chiese e conventi, oggi in gran parte spariti o in rovina,
come il monastero e la chiesa di S.Francesco, il più antico della
città. Polizzi città demaniale occupava il ventunesimo posto
nel Parlamento, aveva un proprio blasone formato da un campo aureo con
sette rose sormontate dall'aquila imperiale, rappresentanti i sette feudi
di cui era costituita la città. Fin dal 1337, aveva i suoi istituti,
ordinamenti e capitoli che ne sancivano l'autonomia. Nel XIV sec. Polizzi
è un luogo di rilevanza politico-economica con la presenza di un
ceto imprenditoriale vivace e dinamico che attraverso le colture granarie,
l'allevamento e le attività artigianali (ad esempio la produzione
di ceramica invetriata) ha raggiunto una certa agiatezza. Per questi motivi
4 'nella seconda metà del XIV sec. I Ventimiglia cercarono di assicurarsene
il controllo. Infatti nel 1354 tolsero ai Chiaromonte la terra di Polizzi
e la affidarono a Filippo Ventimiglia che divenne capitano e castellano.
Subito cacciato,
luogo
prese il nome di "Piano della Battaglia". Dei castello, come
scrive M. G. Montalbano, "ne fa menzione Idrisi, storico arabo del
XII sec., che ne sottolinea la posizione eminente e il territorio ricco
di campi da seminare e fertili terreni". Esso costituì il
primo nucleo abitativo attorno al quale si costituì il borgo medievale.
Attualmente, nonostante il degrado in cui si trova, è ancora possibile
identificarne l'arca, sebbene sia stata in parte occupata dal Palazzo
Gagliardo. Di esso e dell'antico abitato di Polizzi ci si può fare
una idea più precisa osservando la tela dello "Zoppo di Gangi"
nella paia d'altare del "Collegio di Maria", raffigurante il
patrocinio di S.Gandolfo (1620). Il castello fu residenza della contessa
Adelasia, assegnataria del feudo di Polizzi, che diede un consistente
impulso allo sviluppo urbanistico della città legato alla crescita
della popolazione grazie anche alla venuta di famiglie dal nord. Il suo
rapido sviluppo la portò ad essere inclusa tra le città
demaniali della Sicilia, divenne cioè una città regia, centro
di prestigio rispetto all'agglomerato feudale, con privilegi e prerogative,
dominante su un vasto territorio (quello di Polizzi era di kmq. 134,33,
con solo 7300 abitanti). Come tutte le città demaniali essa si
fregiò di un'appellativo datole da un monarca per meriti speciali
(il patronomico " Generosa" fu concesso a Polizzi da Federico
Il nel 1234); possiede le reliquie dei santo patrono (S. Gandolfo) ed
un gran numero di chiese e conventi, oggi in gran parte spariti o in rovina,
come il monastero e la chiesa di S.Francesco, il più antico della
città. Polizzi città demaniale occupava il ventunesimo posto
nel Parlamento, aveva un proprio blasone formato da un campo aureo con
sette rose sormontate dall'aquila imperiale, rappresentanti i sette feudi
di cui era costituita la città. Fin dal 1337, aveva i suoi istituti,
ordinamenti e capitoli che ne sancivano l'autonomia. Nel XIV sec. Polizzi
è un luogo di rilevanza politico-economica con la presenza di un
ceto imprenditoriale vivace e dinamico che attraverso le colture granarie,
l'allevamento e le attività artigianali (ad esempio la produzione
di ceramica invetriata) ha raggiunto una certa agiatezza. Per questi motivi
4 'nella seconda metà del XIV sec. I Ventimiglia cercarono di assicurarsene
il controllo. Infatti nel 1354 tolsero ai Chiaromonte la terra di Polizzi
e la affidarono a Filippo Ventimiglia che divenne capitano e castellano.
Subito cacciato, gli subentrò il conte Francesco Ventimiglia che usurpò di
fatto le prerogative regie sulla città demaniale, assicurandosene
il dominio per circa mezzo secolo" (Montalbano). Con l'avvento di
Martino di Montblanch, ridimensionato e regolamentato il potere dei Ventimiglia
"Signori delle Madonie", vi fu un riconsolidamento del potere
regio; da questo momento Polizzi difese strenuamente i suoi diritti demaniali
contro ogni tentativo di alienarglieli. Così anche nel corso del
XV sec. la città accrebbe il suo ruolo grazie alla formazione di
una nuova classe nobiliare che, ereditata una città malandata e
urbanisticamente decaduta per le vicende legate al dominio feudale, ne
iniziò un'opera di ricostruzione e di abbellimento. "Ricchi,
fregiati di propri stemmi, non solo pensarono di accaparrarsi i migliori
terreni, ma all'interno della città murata i siti migliori per
costruirvi la loro "domus magna", le chiese principali per erigervi
le loro cappelle funerarie e i loro sepolcri ... questi nuovi nobili tennero
in mano il potere, curarono gli interessi della città per garantire
i propri, ma fecero gli interessi della città" (Abbate, op.
cit.). Negli ultimi decenni del XV sec. ebbero inizio una serie di ricostruzioni
e di opere pubbliche (abbellimento della chiesa madre, costruzione dei
palazzo della Universitas, dell'acquedotto e soprattutto committenza di
opere d'arte sacra) che avviarono un vero e proprio "rinascimento
artistico e culturale". La disponibilità finanziaria di questa
nuova nobiltà ( I Barresi, Notarbatolo, La Farina ecc.) che lentamente
si sostituiva a quella tradizionalmente più blasonata ha permesso
di costituire un notevole patrimonio d'arte ancora oggi considerevole,
nonostante le distruzioni e le spoliazioni avvenute nel corso del tempo."
Giuristi, economi, procuratori, rettori di confraternite, nobili baroni
e cavalieri furono i committenti più consueti d'opere d'arte e
poiché Polizzi culturalmente orbitava nell'area di influenza palermitana,
nel capoluogo furono reperiti gli artisti più in voga e i nomi
più famosi cui affidare l'esecuzione di codeste opere" (Abbate).
Lavorarono per Polizzi scultori come i Gagini,Giorgio da Milano,il Mancino,
il Berrettaro e i Di Battista; pittori come Antonello Crescenzio detto
il Panormita, i Graffeo, lo spagnolo Joannes De Matta (che opererà
con bottega direttamente a Polizzi); argentieri come Andrea di Leu, Nibilio
Gagini ed altri. La maggior parte dei prodotti artistici avevano come
destinazione la Chiesa
gli subentrò il conte Francesco Ventimiglia che usurpò di
fatto le prerogative regie sulla città demaniale, assicurandosene
il dominio per circa mezzo secolo" (Montalbano). Con l'avvento di
Martino di Montblanch, ridimensionato e regolamentato il potere dei Ventimiglia
"Signori delle Madonie", vi fu un riconsolidamento del potere
regio; da questo momento Polizzi difese strenuamente i suoi diritti demaniali
contro ogni tentativo di alienarglieli. Così anche nel corso del
XV sec. la città accrebbe il suo ruolo grazie alla formazione di
una nuova classe nobiliare che, ereditata una città malandata e
urbanisticamente decaduta per le vicende legate al dominio feudale, ne
iniziò un'opera di ricostruzione e di abbellimento. "Ricchi,
fregiati di propri stemmi, non solo pensarono di accaparrarsi i migliori
terreni, ma all'interno della città murata i siti migliori per
costruirvi la loro "domus magna", le chiese principali per erigervi
le loro cappelle funerarie e i loro sepolcri ... questi nuovi nobili tennero
in mano il potere, curarono gli interessi della città per garantire
i propri, ma fecero gli interessi della città" (Abbate, op.
cit.). Negli ultimi decenni del XV sec. ebbero inizio una serie di ricostruzioni
e di opere pubbliche (abbellimento della chiesa madre, costruzione dei
palazzo della Universitas, dell'acquedotto e soprattutto committenza di
opere d'arte sacra) che avviarono un vero e proprio "rinascimento
artistico e culturale". La disponibilità finanziaria di questa
nuova nobiltà ( I Barresi, Notarbatolo, La Farina ecc.) che lentamente
si sostituiva a quella tradizionalmente più blasonata ha permesso
di costituire un notevole patrimonio d'arte ancora oggi considerevole,
nonostante le distruzioni e le spoliazioni avvenute nel corso del tempo."
Giuristi, economi, procuratori, rettori di confraternite, nobili baroni
e cavalieri furono i committenti più consueti d'opere d'arte e
poiché Polizzi culturalmente orbitava nell'area di influenza palermitana,
nel capoluogo furono reperiti gli artisti più in voga e i nomi
più famosi cui affidare l'esecuzione di codeste opere" (Abbate).
Lavorarono per Polizzi scultori come i Gagini,Giorgio da Milano,il Mancino,
il Berrettaro e i Di Battista; pittori come Antonello Crescenzio detto
il Panormita, i Graffeo, lo spagnolo Joannes De Matta (che opererà
con bottega direttamente a Polizzi); argentieri come Andrea di Leu, Nibilio
Gagini ed altri. La maggior parte dei prodotti artistici avevano come
destinazione la Chiesa  Madre. Importante
altresì il ruolo delle confraternite ciascuna delle quali curava
direttamente una propria chiesa o cappella per le quali commissionava
arredi sacri, gonfaloni, stendardi, politicì e "vare"
necessari alla pomposità dei loro riti processionali. Nella seconda
metà del '500 Polizzi è ancora una cìttà ricca
e vivace con strutture in grado di ospitare l'imperatore Carlo V, il vicerè
Vega ed illustri personaggi. Dopo questo "secolo d'oro", comincerà
una fase di lenta decadenza. Lo stesso Carlo V, pur confermandole l'appellativo
"generosa", decise di vendere la città e separarla dal
Real Patrimonio per far fronte alle spese della guerra contro i Turchi.
Il pericolo fu scongiurato e il "privilegio" confermato solo
in cambio della non indifferente cifra di 4000 scudi. Tassazioni, peste,
siccità determinarono una progressiva crisi economica che portò
ad un massiccio spopolamento con il conseguente decadimento delle strutture
urbanistiche, tanto che, nella prima metà del '600, attraverso
privilegi e facilitazioni per chi venisse lamento indispensabile per continuare
a mantenere le caratteristiche di città demaniale. Dopo il Concilio
di Trento, la città viene inserita nel piano di creazione di strutture
eclesiastico-conventuali da parte dei nuovi ordini religiosi usciti dalla
Controriforma: gesuiti, cappuccini, fatebenefratelli fondano e gestiscono
conventi, ospedali e strutture assistenziali per l'aumentato numero di
poveri ed indigenti, nonché in linea con la loro ideologia di difesa
della fede attraverso un'intensa azione educativa, scuole e "collegi";
danno impulso alle confraternite per l'organizzazione e il controllo delle
espressioni collettive di devozionalità, incentivando la
scenografia delle processioni e arricchendo le manifestazioni esteriori
del culto. Queste strutture proseguirono nella loro funzione fino alla
seconda metà dell'800 (quando lo Stato unitario ne decreterà
l'acquisizione dei beni), arricchendo sempre più i loro patrimoni
Madre. Importante
altresì il ruolo delle confraternite ciascuna delle quali curava
direttamente una propria chiesa o cappella per le quali commissionava
arredi sacri, gonfaloni, stendardi, politicì e "vare"
necessari alla pomposità dei loro riti processionali. Nella seconda
metà del '500 Polizzi è ancora una cìttà ricca
e vivace con strutture in grado di ospitare l'imperatore Carlo V, il vicerè
Vega ed illustri personaggi. Dopo questo "secolo d'oro", comincerà
una fase di lenta decadenza. Lo stesso Carlo V, pur confermandole l'appellativo
"generosa", decise di vendere la città e separarla dal
Real Patrimonio per far fronte alle spese della guerra contro i Turchi.
Il pericolo fu scongiurato e il "privilegio" confermato solo
in cambio della non indifferente cifra di 4000 scudi. Tassazioni, peste,
siccità determinarono una progressiva crisi economica che portò
ad un massiccio spopolamento con il conseguente decadimento delle strutture
urbanistiche, tanto che, nella prima metà del '600, attraverso
privilegi e facilitazioni per chi venisse lamento indispensabile per continuare
a mantenere le caratteristiche di città demaniale. Dopo il Concilio
di Trento, la città viene inserita nel piano di creazione di strutture
eclesiastico-conventuali da parte dei nuovi ordini religiosi usciti dalla
Controriforma: gesuiti, cappuccini, fatebenefratelli fondano e gestiscono
conventi, ospedali e strutture assistenziali per l'aumentato numero di
poveri ed indigenti, nonché in linea con la loro ideologia di difesa
della fede attraverso un'intensa azione educativa, scuole e "collegi";
danno impulso alle confraternite per l'organizzazione e il controllo delle
espressioni collettive di devozionalità, incentivando la
scenografia delle processioni e arricchendo le manifestazioni esteriori
del culto. Queste strutture proseguirono nella loro funzione fino alla
seconda metà dell'800 (quando lo Stato unitario ne decreterà
l'acquisizione dei beni), arricchendo sempre più i loro patrimoni
 con lasciti
e donazioni. Nei periodi successivi fino ad oggi, Polizzi ha partecipato
alle vicende più significative della storia siciliana, scontrandosi
con tutti i problemi tipici della realtà meridionale (riforma agraria,
emigrazione, occupazione), alla ricerca di una sua via di sviluppo che
non potendosi più fondare soltanto sulle sue risorse tradizionali
(in particolare cave e produzione di nocciole) oggi in crisi, per sfuggire
alla logica prevalentemente assistenzialistica, deve cercare altre vie
che attraverso nuove forme di imprendìtorialità mettano
al primo posto la realizzazione delle sue potenzialità nel settore
turistico attraverso un sano programma di salvaguardia delle sue condizioni
ambientali e dei suoi tesori d'arte.
con lasciti
e donazioni. Nei periodi successivi fino ad oggi, Polizzi ha partecipato
alle vicende più significative della storia siciliana, scontrandosi
con tutti i problemi tipici della realtà meridionale (riforma agraria,
emigrazione, occupazione), alla ricerca di una sua via di sviluppo che
non potendosi più fondare soltanto sulle sue risorse tradizionali
(in particolare cave e produzione di nocciole) oggi in crisi, per sfuggire
alla logica prevalentemente assistenzialistica, deve cercare altre vie
che attraverso nuove forme di imprendìtorialità mettano
al primo posto la realizzazione delle sue potenzialità nel settore
turistico attraverso un sano programma di salvaguardia delle sue condizioni
ambientali e dei suoi tesori d'arte.
Una giornata a Polizzi Generosa
"A capanna d'u zíu Totò"
 Immersa
nel Parco delle Madonie, su un colle alto poco più di 900 metri,
fa bella mostra di sè POLIZZI GENEROSA. Vi giungiamo in mattinata
e, nonostante la stagione estiva non ancora conclusa, l'aria fresca e
pulita ci porta gli odori tipici di un paese ancora incontaminato. Da
scoprire. La gente è indaffarata, sono tutti in fermento per la
Sagra delle nocciole, già sono pronte le "baracchette"
coperte dai rami di ginestra, tutte uguali all'apparenza, ma da ciascuna
di esse si affacciano volti diversi fra loro, giovani e vecchi, allegri
e pensierosi, tutti, comunque hanno qualcosa da farti assaggiare e da
comprare e non puoi non fermarti, anche solo per unire i fazzoletti rossi
annodati intorno al collo, i capelli, le gonne svolazzanti delle ragazze
che fanno corona attorno ad un carretto variopinto su cui troneggia una
bimba che non ha neppure tre anni e già si pavoneggia nel suo vestito
bianco e rosso da campagnola. Proseguendo per questa strada, Via
Matteotti, si arriva al centro del paese. Anche qui sono tutti in movimento,
Scorgiamo alcuni ragazzi con una fascia blu al braccio. Sono le guide
che oggi, ma non solo, accompagnano gli ospiti del paese lungo un percorso
storico ed artistico che conoscono molto bene. Ci fermiamo a prendere
un caffè e, mentre lo sorseggiamo pigramente, i nostri occhi non
possono staccarsi dalla vetrinetta che espone dei dolcetti niente male.
Li assaggiamo e decidiamo di comprarne tanti (con la scusa di portarli
alla mamma): ci sono i dolcetti al cocco, gli amaretti, le arancine, i
quaresimali, i nocatolì e i "brutti ma buoni" a base di nocciole,
tanto per restare in tema. Ora possiamo proseguire il nostro giro di perlustrazione
e visitiamo la Chiesa Madre, all'interno della quale si trova un trittico
fiammingo. Angela, la nostra guida, ci parla di una leggenda legata a
questo quadro: nell'anno 1496, approdò nel porto di Palermo un
veliero da cui scese un uomo dal volto sofferente. Era il capitano Luca
Gardini.
Immersa
nel Parco delle Madonie, su un colle alto poco più di 900 metri,
fa bella mostra di sè POLIZZI GENEROSA. Vi giungiamo in mattinata
e, nonostante la stagione estiva non ancora conclusa, l'aria fresca e
pulita ci porta gli odori tipici di un paese ancora incontaminato. Da
scoprire. La gente è indaffarata, sono tutti in fermento per la
Sagra delle nocciole, già sono pronte le "baracchette"
coperte dai rami di ginestra, tutte uguali all'apparenza, ma da ciascuna
di esse si affacciano volti diversi fra loro, giovani e vecchi, allegri
e pensierosi, tutti, comunque hanno qualcosa da farti assaggiare e da
comprare e non puoi non fermarti, anche solo per unire i fazzoletti rossi
annodati intorno al collo, i capelli, le gonne svolazzanti delle ragazze
che fanno corona attorno ad un carretto variopinto su cui troneggia una
bimba che non ha neppure tre anni e già si pavoneggia nel suo vestito
bianco e rosso da campagnola. Proseguendo per questa strada, Via
Matteotti, si arriva al centro del paese. Anche qui sono tutti in movimento,
Scorgiamo alcuni ragazzi con una fascia blu al braccio. Sono le guide
che oggi, ma non solo, accompagnano gli ospiti del paese lungo un percorso
storico ed artistico che conoscono molto bene. Ci fermiamo a prendere
un caffè e, mentre lo sorseggiamo pigramente, i nostri occhi non
possono staccarsi dalla vetrinetta che espone dei dolcetti niente male.
Li assaggiamo e decidiamo di comprarne tanti (con la scusa di portarli
alla mamma): ci sono i dolcetti al cocco, gli amaretti, le arancine, i
quaresimali, i nocatolì e i "brutti ma buoni" a base di nocciole,
tanto per restare in tema. Ora possiamo proseguire il nostro giro di perlustrazione
e visitiamo la Chiesa Madre, all'interno della quale si trova un trittico
fiammingo. Angela, la nostra guida, ci parla di una leggenda legata a
questo quadro: nell'anno 1496, approdò nel porto di Palermo un
veliero da cui scese un uomo dal volto sofferente. Era il capitano Luca
Gardini. Egli si recò in una chiesa vicina al porto e chiese a un padre
francescano di essere confessato. Durante la confessione, disse di essere
stato vittima, con i suoi uomini, di una tempesta e di aver perso tutte
le merci che trasportava, ad eccezione di un quadro pregevolissimo che
egli avrebbe donato ad una chiesa povera e in costruzione. H padre francescano
si fece allora consegnare il quadro che decise di destinare alla Chiesa
di S. Maria di Polizzi, allora in costruzione. Lo spedì, assieme
aduna lettera, a Polizzi, con un vetturino che arrivò a destinazione
senza il quadro. Disse che gli era stato rubato, lungo il cammino, dalle
guardie del Conte di Collesano. Il frate, allora, andò dal conte
per farsi restituire il trittico ma il conte confessò di averlo
già regalato a "Madarna" la Contessa di Petralia. Intanto
gli abitanti di Polizzi organizzarono una rivolta per ottenere il quadro,
ma, prima che si muovessero, il trittico fu loro prontamente restituito.
Continuando il nostro giro, visitiamo la chiesa di S. Pancrazio, nell'antico,
quartiere bizantino,da cui si scorge un panorama veramente suggestivo.
All'interno della chiesa una Madonna, di autore ignoto, fatta restaurare
dall'Associazione "Naftolia". Poi, proseguendo la visita, Palazzo
Gagliardo, Palazzo Carpinello.... vale proprio la pena di scarpinare un
pò, ma bisogna fermarsi per mangiare qualcosa. Chiediamo un pò
in giro l'indirizzo di un buon ristorante. Ed eccoci allora a tavola,
pronti ad onorare la cucina locale: gustosi antipasti a base di melanzane
arrosto, pomodori secchi, olive, salumi e formaggi tipici, " panelle",
"stigghiola", gli asparagi con le uova, peperonata e la deliziosa
ricotta fritta. Poi i tradizionali piatti, a base di salsiccia e costolette
di castrato. E, se ancora ce la fate, vi consigliamo lo " sfoglio",
un dolce tipico a base di formaggio. Dopo esserci rifocillati (ma il
Egli si recò in una chiesa vicina al porto e chiese a un padre
francescano di essere confessato. Durante la confessione, disse di essere
stato vittima, con i suoi uomini, di una tempesta e di aver perso tutte
le merci che trasportava, ad eccezione di un quadro pregevolissimo che
egli avrebbe donato ad una chiesa povera e in costruzione. H padre francescano
si fece allora consegnare il quadro che decise di destinare alla Chiesa
di S. Maria di Polizzi, allora in costruzione. Lo spedì, assieme
aduna lettera, a Polizzi, con un vetturino che arrivò a destinazione
senza il quadro. Disse che gli era stato rubato, lungo il cammino, dalle
guardie del Conte di Collesano. Il frate, allora, andò dal conte
per farsi restituire il trittico ma il conte confessò di averlo
già regalato a "Madarna" la Contessa di Petralia. Intanto
gli abitanti di Polizzi organizzarono una rivolta per ottenere il quadro,
ma, prima che si muovessero, il trittico fu loro prontamente restituito.
Continuando il nostro giro, visitiamo la chiesa di S. Pancrazio, nell'antico,
quartiere bizantino,da cui si scorge un panorama veramente suggestivo.
All'interno della chiesa una Madonna, di autore ignoto, fatta restaurare
dall'Associazione "Naftolia". Poi, proseguendo la visita, Palazzo
Gagliardo, Palazzo Carpinello.... vale proprio la pena di scarpinare un
pò, ma bisogna fermarsi per mangiare qualcosa. Chiediamo un pò
in giro l'indirizzo di un buon ristorante. Ed eccoci allora a tavola,
pronti ad onorare la cucina locale: gustosi antipasti a base di melanzane
arrosto, pomodori secchi, olive, salumi e formaggi tipici, " panelle",
"stigghiola", gli asparagi con le uova, peperonata e la deliziosa
ricotta fritta. Poi i tradizionali piatti, a base di salsiccia e costolette
di castrato. E, se ancora ce la fate, vi consigliamo lo " sfoglio",
un dolce tipico a base di formaggio. Dopo esserci rifocillati (ma il  termine
è riduttivo), ci avviamo verso il Museo Ambientale delle Madonie
che si trova all'interno dell'antico Palazzo Notarbartolo. Qui
è stato ricostruito l'ambiente naturale del Parco delle Madonie
che ha ospitato ed ospita diverse specie di animali, in particolare uccelli
rapaci. Passando da una stanza all'altra, attraverso scale antiche e ripidissime,
i nostri occhi incontrano decine di altri occhi, ormai immobili per sempre
e ci chiediamo, divertiti (ma non troppo) cosa accadrebbe se si risvegliassero
proprio in mezzo a noi. Lasciato il Museo, ci dirigiamo nuovamente verso
Via Matteotti e le sue "baracchette". E' quasi l'ora della sfilata.
Fra poco passeranno da qui gruppi folkoristici, gli uomini di Petralia
Soprana con gli stendardi rossi e verdi e poi ancora i carretti siciliani
moderatissimi e, infine, il gruppo delle "cordelle". Alcune
ragazze in costume tipico ci sorridono. "Cosa fate? " "domandiamo".
Aiutiamo a cucinare, balliamo, cantiamo. Per stare un pò insieme
- dice una di loro - non sono molti i momenti di aggregazione per noi
giovani", e un'altra interviene: "si, è vero, sopratutto
durante l'inverno, se escludiamo la piazza e, ogni tanto, la discoteca.
Non c'è neanche il cinema! lo andrò all'università
a Palermo, poi troverò un lavoro". "Qui a Polizzi?"
"domandiamo". No, spero proprio di no! ". Più avanti,
sulla strada, da una "baracchetta" spunta la faccia rubiconda
di un bambino, poi altri, tutti insieme. Chiediamo il nome del loro "stand".
"A capanna d'u ziu Totò" risponde uno, con l'aria di
aver inventato il nome adesso "ma oggi non abbiamo guadagnato molto.
A proposito, li volete due peperoni arrostiti?" Siamo ormai quasi
al termine del nostro giro. L'aria è più fresca, ma con
un maglione si sta benissimo. La nostra ultima tappa
termine
è riduttivo), ci avviamo verso il Museo Ambientale delle Madonie
che si trova all'interno dell'antico Palazzo Notarbartolo. Qui
è stato ricostruito l'ambiente naturale del Parco delle Madonie
che ha ospitato ed ospita diverse specie di animali, in particolare uccelli
rapaci. Passando da una stanza all'altra, attraverso scale antiche e ripidissime,
i nostri occhi incontrano decine di altri occhi, ormai immobili per sempre
e ci chiediamo, divertiti (ma non troppo) cosa accadrebbe se si risvegliassero
proprio in mezzo a noi. Lasciato il Museo, ci dirigiamo nuovamente verso
Via Matteotti e le sue "baracchette". E' quasi l'ora della sfilata.
Fra poco passeranno da qui gruppi folkoristici, gli uomini di Petralia
Soprana con gli stendardi rossi e verdi e poi ancora i carretti siciliani
moderatissimi e, infine, il gruppo delle "cordelle". Alcune
ragazze in costume tipico ci sorridono. "Cosa fate? " "domandiamo".
Aiutiamo a cucinare, balliamo, cantiamo. Per stare un pò insieme
- dice una di loro - non sono molti i momenti di aggregazione per noi
giovani", e un'altra interviene: "si, è vero, sopratutto
durante l'inverno, se escludiamo la piazza e, ogni tanto, la discoteca.
Non c'è neanche il cinema! lo andrò all'università
a Palermo, poi troverò un lavoro". "Qui a Polizzi?"
"domandiamo". No, spero proprio di no! ". Più avanti,
sulla strada, da una "baracchetta" spunta la faccia rubiconda
di un bambino, poi altri, tutti insieme. Chiediamo il nome del loro "stand".
"A capanna d'u ziu Totò" risponde uno, con l'aria di
aver inventato il nome adesso "ma oggi non abbiamo guadagnato molto.
A proposito, li volete due peperoni arrostiti?" Siamo ormai quasi
al termine del nostro giro. L'aria è più fresca, ma con
un maglione si sta benissimo. La nostra ultima tappa
è l'Associazione Culturale" Naftolia", di cui hanno parlato in molti, qui in paese. E a ben ragione, visto che da quasi
dieci anni, Naftolia si è fatta portatrice di iniziative
artistiche e culturali, valorizzando il patrimonio di una Polizzi così
ancora più "generosa". "Noi vogliamo essere una
forza trainante per la gente dei paese" - afferma Carlo Borgese,
vicepresidente dell'associazione - " sopratutto" per i giovani.
Abbiamo molti associati, gente colta e "vivace", ma vorremmo
che un sostegno importante arrivasse anche all'amministrazione comunale".
Restiamo a chiacchierare a lungo, in una stanza piena di quadri e di libri.
Forse, la ragazza incontrata alle "baracchette", quella che
da grande vuole andare via, ci potrebbe ripensare. Chi sà!!!
hanno parlato in molti, qui in paese. E a ben ragione, visto che da quasi
dieci anni, Naftolia si è fatta portatrice di iniziative
artistiche e culturali, valorizzando il patrimonio di una Polizzi così
ancora più "generosa". "Noi vogliamo essere una
forza trainante per la gente dei paese" - afferma Carlo Borgese,
vicepresidente dell'associazione - " sopratutto" per i giovani.
Abbiamo molti associati, gente colta e "vivace", ma vorremmo
che un sostegno importante arrivasse anche all'amministrazione comunale".
Restiamo a chiacchierare a lungo, in una stanza piena di quadri e di libri.
Forse, la ragazza incontrata alle "baracchette", quella che
da grande vuole andare via, ci potrebbe ripensare. Chi sà!!!
Il territorio e le risorse ambientali
Il territorio di Polizzi Generosa ricade in gran parte nel parco delle Madonie e in esso è istituita la "Riserva Quacella" I monti, che fanno da corona al pianoro della riserva, sono fra i più antichi della Sicilia e sono ricchi di endemismi, di piante e di fiori rarissimì in tutta l'area dei Mediterraneo. Nel Vallone Madonna degli Angeli è possibile ammirare 1 "abiesnebrodensis "(o abete bianco), scomparso in Italia dall'era dell'ultima glaciazione. Con il suo portamento colonnare, le sue fronde natalizie, il profumo di resina, l'abete può sembrare del tutto fuori posto in un ambiente a soli 30 km dal mare. Eppure in tempi nemmeno lontanissimi, gli abeti bianchi erano comuni nei monti dell'isola e fornivano travature alle case e antenne alle navi delle flotte puniche, greche, romane, arabe. Grazie alla sua maggiore lavorabilità e alla sua leggerezza l'abete bianco è stato oggetto di radicali disboscamenti fino a sparire dai monti dell'isola, ma non completamente. Nel Vallone Madonna degli -Angeli, a nord del Monte Scalone presso la strada che da Polizzi Generosa porta a Piano Battaglia, in una vegetazione di faggio ridotta a mal partito per taglio e pascolo vivono gli ultimi abeti della Sicilia. E' uno strano abete, dall'aspetto tozzo e compatto, adattato a vivere in ambienti caldi e aridi; si tratta di pochi esemplari (da 20 a 40) salvati dall'estinzione grazie ad una recinzione di filo spinato. L'unico esemplare in età da produrre semi (l'età di fruttificazione inizia dai 40 ai 60 anni) si trova nel giardino della villa del barone Casale in Polizzi. Boschi ancora estesi e compatti di querce, di lecci, di agrifogli e di faggi ammantano il pianoro di Monte Cervi, dove notevole appare il fenomeno carsico, che presenta talora cavità molto profonde, come quelle del "manico della padella ". Tutto il massiccio montuoso, da Monte Cervi al San Salvatore, è formato prevalentemente da calcari mesozoici, che costituiscono il bacino imbrifero che alimenta a valle numerose e ricche sorgenti che permettono di irrigare i giardini di noccioleto e gli orti e che alimentavano i vecchi molini ad acqua (alcuni risalenti all'epoca dei saraceni). Tutta la zona intorno al paese è ancora, nonostante le devastazioni degli ultimi anni, un autentico scrigno vegetali, un piccolo paradiso per i botanici che possono venire a contatto con piante altrove sconosciute. Per avere un'idea della ricchezza della fauna di questo ambiente si può visitare il MAM (Museo Ambíentalistico Madonita) che ha sede nel palazzo Notarbartolo. che raccoglie, in una scenografica ricostruzione dell'habitat naturale, anche gli esemplari più rari.
Chiese palazzi ed opere d'arte
 La
Chiesa Madre, S. Maria Maggiore, risalente all'epoca della contessa Adelasia
e ingrandita sotto il dominio dei Ventimiglia nella seconda metà
del sec. XIV assunse una configurazione architettonica e spaziale che durò
quasi intatta sino al 1764, amo in cui venne completamente diroccata e
rifatta con grandi perdite delle antiche strutture e di parte dei tesori
d'arte cinquecenteschi (pale d'altare e decorazioni) considerati ormai
superati, Sotto il cinquecentesco portico laterale sono riconoscibili,
nella finestra lunga e stretta dell'antico portale, gli originali caratteri
normanni. All'intemo, sull'altare maggiore, una statua della Vergine di
Giuliano Mancino (1508). A sinístra, una cappella con notevoli
monumenti funebri in stile barocco, tra cui quello dello storico polizzano
G. B. Caruso. In una cappella della navata sinistra, un monumentale reliquiario
con Crocifisso del XVIII secolo e alcune statue attribuite al Quattrocchi.
Di fronte, sul transetto destro, la cappella di S. Gandolfo contenente
il sarcofago in marmo del Santo, opera di Domenico Gagini (1482), le statue
di S. Pietro e S. Giacomo, opere di Giorgio da Milano, e un trittico marmoreo
raffigurante la Vergine tra S, Francesco e S. Antonio, opera degli scultori
Berrettaro e Francesco del Maestro. L'opera di evidente ispirazione gaginesca,
è pregevole per l'armonia della composizione e per l'espressività
delle figure. Il quadro più importante della Chiesa è un
Trittico fiammingo giunto fortunosamente a Polizzi, collocato in alto a
destra dell'altare maggiore. Gli studiosi, che hanno sempre sottolineato
la dolcezza delle espressioni e l'estrema raffinatezza dei particolari,
hanno attribuito questo capolavoro dell'arte fiamminga a Van Eych, a Van der Weiden e al Memling: oggi si pensa che sia della scuola del Memling.
Di fronte un polittico dei 1519 attribuito a J. De Matta, pregevole per
la fusione dell'influenza antonelliana e di quella fiamminga, con un ricordo,
anche, di Piero della Francesca. Il tesoro della Chiesa comprende, oltre a
preziosi calici, uno stupendo Ostensorio d'argento a più piani
ornato di figure,opera di Nibilio Cagini el'arca d'argento massiccio di
S. Gandolfo, del 1549, opera dell'orefice Andrea Di Leo. Notevole, nella
Chiesa, anche l'artistico organo settecentesco. Altri quadri sono di J.
De Matta, pittore che tenne bottega a Polizzí. Tra le altre chiese
bisogna citare: S. Maria Delle Grazie, con una "custodia" barocca
di legno intarsiato e dorato, opera dei valente artigiano polizzano Pietro
Bencivirmì (1697); S. Margherita, con un'artistica cancellata in
ferro battuto, il quadro di San Benedetto dello Zoppo di Gangi e statue
di scuola gaginesca; La Chiesa di S. Francesco, di epoca trecentesca,
restaurata con un audace tetto moderno di legno a spiovente; la Chiesa
dei Carmine, con un Crocifisso straordinariamente espressivo, opera di
Francesco Gallusca, allievo di Frate Umile; S. Nicolò de Franchis,
deliziosa nella sua rustica semplicità risalente al 1167; S. Pancrazio,
nell'antico quartiere bizantino, in posizione panoramica, con all'intemo,
un quadro dello Zoppo di Gangi e una Madonna Immacolata di Antonino da
Conversano (XVII sec.) e quadri e statue dello Zoppo di Gangi e del Quattrocchi;
la Chiesa di S. Antonio abate, che era in origine una moschea, come dimostrano
le linee architettoniche dell'attuale campanile, l'antico minareto; S.
Maria Lo Piano in cui si riuniva il Senato polizzano: all'interno, è
possibile vedere interessanti pitture sulla volta di legno, riproducenti
piccoli mostri e animali, e quadri dello Zoppo di Gangi. In posizione
isolata, fuori dal paese, i pittoreschi ruderi della Commenda dell'Ordine
gerosolimitano, vicino alla quale sorgeva la Curia dei Cavalieri di Malta.
Tra gli edifici dei passato, Palazzo Gagliardo dei Baroni di Carpinello
è notevole per i suoi caratteri stilistici appartenenti al tardo
manierismo, per le decorazioni in bugnato agli angoli e per il solenne,
maestoso portale. Palazzo Carpinello, che sorge su una piazza sopraelevata,
si distingue per la sua lunga facciata e per le due antiche caratteristiche
meridiane. In questo palazzo aveva sede la Regìa Secrezia. Il Collegio
dei Gesuiti, l'unico delle Madonie, imponente per le dimensioni e per
l'austera, monumentale architettura, ancora in fase di restauro, è
oggi sede dei Comune, della Pretura e della Biblioteca Comunale con l'attigua
chiesa di S. Gerolamo dalla facciata molto movimentata in stile barocco
e dalla pianta ellittica, opera dell'architetto fra' Angelo Italia. Oggi
restaurata e riaperta al culto. Dell'antico castello, che aveva ospitato
tanti re e regine, rimangono solo pittoreschi ruderi. Molte case private
del XVIII e XIX sec. conservano ancora pregevoli volte affrescate e sovrapporte
dipinte, opere di valenti artigiani locali. La
Biblioteca Comunale Lancia di Brolo, forse la più ricca biblioteca
di paese della Sicilia, fu fondata nel 1893 in seguito ad una donazione
del duca Lancia di Brolo, che era stato eletto dai polizzani come loro
rappresentante nel Parlamento siciliano. Alla biblioteca del Duca, comprendente
circa 13.000 volumi, si sono poi aggiunte le numerose opere provenienti
dagli antichi conventi soppressi di Polizzi. Numerose
altre chiese contenenti pregevoli opere d'arte, strutture conventuali
dei principali ordini religiosi, esistenti in città non sono
state risparmiate dall'incurie del tempo (in piccola parte) e degli uomini
(in massima parte). Se ne può ricostruire una topografia immaginaria
consultando il volume di Vincenzo Abate, Inventario polizzano. Arte e
società in un centro demaniale del cinquecento, Palermo 1992, edito
a cura dell'associazione culturale Naftolia.
La
Chiesa Madre, S. Maria Maggiore, risalente all'epoca della contessa Adelasia
e ingrandita sotto il dominio dei Ventimiglia nella seconda metà
del sec. XIV assunse una configurazione architettonica e spaziale che durò
quasi intatta sino al 1764, amo in cui venne completamente diroccata e
rifatta con grandi perdite delle antiche strutture e di parte dei tesori
d'arte cinquecenteschi (pale d'altare e decorazioni) considerati ormai
superati, Sotto il cinquecentesco portico laterale sono riconoscibili,
nella finestra lunga e stretta dell'antico portale, gli originali caratteri
normanni. All'intemo, sull'altare maggiore, una statua della Vergine di
Giuliano Mancino (1508). A sinístra, una cappella con notevoli
monumenti funebri in stile barocco, tra cui quello dello storico polizzano
G. B. Caruso. In una cappella della navata sinistra, un monumentale reliquiario
con Crocifisso del XVIII secolo e alcune statue attribuite al Quattrocchi.
Di fronte, sul transetto destro, la cappella di S. Gandolfo contenente
il sarcofago in marmo del Santo, opera di Domenico Gagini (1482), le statue
di S. Pietro e S. Giacomo, opere di Giorgio da Milano, e un trittico marmoreo
raffigurante la Vergine tra S, Francesco e S. Antonio, opera degli scultori
Berrettaro e Francesco del Maestro. L'opera di evidente ispirazione gaginesca,
è pregevole per l'armonia della composizione e per l'espressività
delle figure. Il quadro più importante della Chiesa è un
Trittico fiammingo giunto fortunosamente a Polizzi, collocato in alto a
destra dell'altare maggiore. Gli studiosi, che hanno sempre sottolineato
la dolcezza delle espressioni e l'estrema raffinatezza dei particolari,
hanno attribuito questo capolavoro dell'arte fiamminga a Van Eych, a Van der Weiden e al Memling: oggi si pensa che sia della scuola del Memling.
Di fronte un polittico dei 1519 attribuito a J. De Matta, pregevole per
la fusione dell'influenza antonelliana e di quella fiamminga, con un ricordo,
anche, di Piero della Francesca. Il tesoro della Chiesa comprende, oltre a
preziosi calici, uno stupendo Ostensorio d'argento a più piani
ornato di figure,opera di Nibilio Cagini el'arca d'argento massiccio di
S. Gandolfo, del 1549, opera dell'orefice Andrea Di Leo. Notevole, nella
Chiesa, anche l'artistico organo settecentesco. Altri quadri sono di J.
De Matta, pittore che tenne bottega a Polizzí. Tra le altre chiese
bisogna citare: S. Maria Delle Grazie, con una "custodia" barocca
di legno intarsiato e dorato, opera dei valente artigiano polizzano Pietro
Bencivirmì (1697); S. Margherita, con un'artistica cancellata in
ferro battuto, il quadro di San Benedetto dello Zoppo di Gangi e statue
di scuola gaginesca; La Chiesa di S. Francesco, di epoca trecentesca,
restaurata con un audace tetto moderno di legno a spiovente; la Chiesa
dei Carmine, con un Crocifisso straordinariamente espressivo, opera di
Francesco Gallusca, allievo di Frate Umile; S. Nicolò de Franchis,
deliziosa nella sua rustica semplicità risalente al 1167; S. Pancrazio,
nell'antico quartiere bizantino, in posizione panoramica, con all'intemo,
un quadro dello Zoppo di Gangi e una Madonna Immacolata di Antonino da
Conversano (XVII sec.) e quadri e statue dello Zoppo di Gangi e del Quattrocchi;
la Chiesa di S. Antonio abate, che era in origine una moschea, come dimostrano
le linee architettoniche dell'attuale campanile, l'antico minareto; S.
Maria Lo Piano in cui si riuniva il Senato polizzano: all'interno, è
possibile vedere interessanti pitture sulla volta di legno, riproducenti
piccoli mostri e animali, e quadri dello Zoppo di Gangi. In posizione
isolata, fuori dal paese, i pittoreschi ruderi della Commenda dell'Ordine
gerosolimitano, vicino alla quale sorgeva la Curia dei Cavalieri di Malta.
Tra gli edifici dei passato, Palazzo Gagliardo dei Baroni di Carpinello
è notevole per i suoi caratteri stilistici appartenenti al tardo
manierismo, per le decorazioni in bugnato agli angoli e per il solenne,
maestoso portale. Palazzo Carpinello, che sorge su una piazza sopraelevata,
si distingue per la sua lunga facciata e per le due antiche caratteristiche
meridiane. In questo palazzo aveva sede la Regìa Secrezia. Il Collegio
dei Gesuiti, l'unico delle Madonie, imponente per le dimensioni e per
l'austera, monumentale architettura, ancora in fase di restauro, è
oggi sede dei Comune, della Pretura e della Biblioteca Comunale con l'attigua
chiesa di S. Gerolamo dalla facciata molto movimentata in stile barocco
e dalla pianta ellittica, opera dell'architetto fra' Angelo Italia. Oggi
restaurata e riaperta al culto. Dell'antico castello, che aveva ospitato
tanti re e regine, rimangono solo pittoreschi ruderi. Molte case private
del XVIII e XIX sec. conservano ancora pregevoli volte affrescate e sovrapporte
dipinte, opere di valenti artigiani locali. La
Biblioteca Comunale Lancia di Brolo, forse la più ricca biblioteca
di paese della Sicilia, fu fondata nel 1893 in seguito ad una donazione
del duca Lancia di Brolo, che era stato eletto dai polizzani come loro
rappresentante nel Parlamento siciliano. Alla biblioteca del Duca, comprendente
circa 13.000 volumi, si sono poi aggiunte le numerose opere provenienti
dagli antichi conventi soppressi di Polizzi. Numerose
altre chiese contenenti pregevoli opere d'arte, strutture conventuali
dei principali ordini religiosi, esistenti in città non sono
state risparmiate dall'incurie del tempo (in piccola parte) e degli uomini
(in massima parte). Se ne può ricostruire una topografia immaginaria
consultando il volume di Vincenzo Abate, Inventario polizzano. Arte e
società in un centro demaniale del cinquecento, Palermo 1992, edito
a cura dell'associazione culturale Naftolia.
Agosto Madonita
Il ballo della Cordella
Il ballo della cordella
ha radici profonde nel tempo e nell'animo dei contadini madoniti. Durante
le "Cerealia", feste in onore di Cerere, dea delle messi, le
sacerdotesse iniziavano ai misteri dell'alcova le giovani coppie di sposi.
Successivamente le feste ebbero il ruolo di ringraziamento per l'abbondante
raccolto e per il trionfo della vita e dell'amore. Oggi,
la danza della cordella, oltre ad essere l'espressione di una genuina
tradizione popolare, contiene un lato spettacolare in grado di affascinare
e coinvolgere lo spettatore. suon di tamburelli, chitarra, zufolo, fisarmonica
e scacciapensieri "u bastunieri" invita alle danze: "Fimmini
e masculi di sta quadrigghia" "ca suddu n'aiuta la midudda"
"avimu antrizzari a curdedda" "fimminia
dritta masculi a manca","facimuun
giru ca nuddu si stanca"
"primana coppia puì duì e pui tri", "e
la curdedda s'intrizza accussì ". Quindi,
24 ballerini disposti in cerchio, reggono variopinte cordelle pendenti
da un'alta pertica coronata da spighe, simbolo di Cerere. Il ballo consiste
nell'intrecciare i coloratissimi nastriní in 4 differentì
figure che rappresentano nella sequenza: l'aratura, la semina, il germogliare
e la raccolta. E'
lo stesso "bastunieri" che invita le 12 coppie che rappresentano
i 12 mesi dell'anno e le costellazioni, a danzare al contrario per snodare
le cordelle. Il
ballo unico nel suo genere símbolizza con suoni, colori ed allegria
i perenni sacrifici che caratterizzano la vita dei contadíni. E'
una manifestazione da non perdere.
Per un museo della memoria
La
non più esistente statua di Iside triforme (o Ecate) tricorporea
che può aver dato il nome alla città
 Verso la metà
del XVII secolo era stata trovata, in un pozzo, una statua triforme, con
corpo di donna e con tre facce, una di donna, una di vecchio e una di
bambino. La statua era inoltre adorna di simboli misteriosi: in fronte
aveva un triangolo con dentro un fiore, con una mano reggeva due serpenti,
con l'altra un oggetto sferico. Il simulacro era stato collocato nella
chiesa madre, come sostegno della pila per l'acqua benedetta. Nel 1764,
fu rimossa a causa di alcuni lavori di ristrutturazione dell'edificio.
Al momento di ricollocarla al suo posto, il vescovo Castelli, che si trovava
in quei giorni a Polizzi, ritenendo una profanazione la presenza in chiesa
di una statua pagana, ordinò che fosse fatta a pezzi. I Giurati
e i notabili del paese si riunirono per sottoscrivere una solenne protesta
e per tramandare ai posteri, attraverso una minuziosa e fedele descrizione,
il ricordo della statua. E' proprio grazie a questo documento e grazie
anche a un dottissimo studio, ancora inedito, dello storico polizzano
Francesco Caluso, che possiamo conoscere l'ìmportanza e il significato
della statua triforme. Il Caruso presentò il suo lavoro a Palermo
all'Accademia del Buon Gusto in casa del Principe di S. Flavia, sostenendo,
"a bue di molte citazioni e di molti riferimenti, l'identificazione
della statua con Iside, e, di conseguenza l'etimologia di Polizzi come
Polis Isidis, città di Iside. Tra le altre spiegazioni degne di nota,
si può ricordare quella di Baldassarre Romano, per il quale si
trattava dì uno ieremblema appartenente al Collegio Eleusino che
aveva sede nel vicino Piano della Battaglia e che era dedito al culto
isiaco; o l'opinione di Emanuele Starabba, il quale, illustrando
ai Soci della Storia Patria il discorso del Caruso, avanzava l'ipotesi
che si trattasse di un termine, cioè di una di quelle immagini
poste a custodia delle vie e dei trivii. L'ipotesi è in un certo
senso confermata da un grande studioso, il Roscher, per il quale si trattava
probabilmente di Ecate, posta di solito nei trivii e negli incroci:
l'interpretazione può essere motivata dalla posizione di Polizzi,
posta nel punto di convergenza delle tre valli in cui era divisa la Sicilia.
Dalla "introduzione" alla ristampa anastatica dell'opuscolo
edito a Palermo nel 1880, a cura dell'Associazione Culturale Naftolia
che si propone come erede degli ideali dei loro concittadini del XVIII
secolo.
Verso la metà
del XVII secolo era stata trovata, in un pozzo, una statua triforme, con
corpo di donna e con tre facce, una di donna, una di vecchio e una di
bambino. La statua era inoltre adorna di simboli misteriosi: in fronte
aveva un triangolo con dentro un fiore, con una mano reggeva due serpenti,
con l'altra un oggetto sferico. Il simulacro era stato collocato nella
chiesa madre, come sostegno della pila per l'acqua benedetta. Nel 1764,
fu rimossa a causa di alcuni lavori di ristrutturazione dell'edificio.
Al momento di ricollocarla al suo posto, il vescovo Castelli, che si trovava
in quei giorni a Polizzi, ritenendo una profanazione la presenza in chiesa
di una statua pagana, ordinò che fosse fatta a pezzi. I Giurati
e i notabili del paese si riunirono per sottoscrivere una solenne protesta
e per tramandare ai posteri, attraverso una minuziosa e fedele descrizione,
il ricordo della statua. E' proprio grazie a questo documento e grazie
anche a un dottissimo studio, ancora inedito, dello storico polizzano
Francesco Caluso, che possiamo conoscere l'ìmportanza e il significato
della statua triforme. Il Caruso presentò il suo lavoro a Palermo
all'Accademia del Buon Gusto in casa del Principe di S. Flavia, sostenendo,
"a bue di molte citazioni e di molti riferimenti, l'identificazione
della statua con Iside, e, di conseguenza l'etimologia di Polizzi come
Polis Isidis, città di Iside. Tra le altre spiegazioni degne di nota,
si può ricordare quella di Baldassarre Romano, per il quale si
trattava dì uno ieremblema appartenente al Collegio Eleusino che
aveva sede nel vicino Piano della Battaglia e che era dedito al culto
isiaco; o l'opinione di Emanuele Starabba, il quale, illustrando
ai Soci della Storia Patria il discorso del Caruso, avanzava l'ipotesi
che si trattasse di un termine, cioè di una di quelle immagini
poste a custodia delle vie e dei trivii. L'ipotesi è in un certo
senso confermata da un grande studioso, il Roscher, per il quale si trattava
probabilmente di Ecate, posta di solito nei trivii e negli incroci:
l'interpretazione può essere motivata dalla posizione di Polizzi,
posta nel punto di convergenza delle tre valli in cui era divisa la Sicilia.
Dalla "introduzione" alla ristampa anastatica dell'opuscolo
edito a Palermo nel 1880, a cura dell'Associazione Culturale Naftolia
che si propone come erede degli ideali dei loro concittadini del XVIII
secolo.