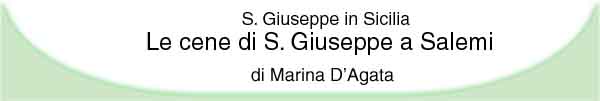
Le feste celebrate per il santo il cui culto divenne di particolare rilevanza alla fine del XV secolo, si svolgono in diversi centri della Sicilia con riti che variano da paese in paese e che si concretizzano in banchetti o "cene" per i poveri del luogo.
Le Cene di S.Giuseppe a Salemi
 Un
processo di riappropriazione della nostra terra non può prescindere
da una lettura della storia siciliana vista anche attraverso le tradizioni
popolari che costituiscono, ancora oggi, un forte elemento di arricchimento
culturale. Di tali tradizioni, che rappresentano, innazitutto, momenti
di aggregazione popolare non disgiunti da una notevole carica di sentimenti,
fanno parte un gran numero di feste, riti, cerimonie, in cui motivi pagani
si mescolano a quelli religiosi. Fra le manifestazioni che ancor oggi
hanno luogo nell'isola, un posto di sicuro rilievo è occupato dalle
cerimonie in onore di S. Giuseppe. Secondo il Pitrè " ...
l'uso del banchetto detto di S. Giuseppe e di altri usi popolari nel giorno
19 marzo... può esser nato... dalla sua particolar prerogativa...
diessere il Santo tutelare dei poveri, degli orfani, di chi volge in grandi
strettezze di vita... Il banchetto si fa da tutti i Siciliani con più
o meno pompe, con maggior o minor lautezza e profusione di vivande". A
Salemi, importante centro agricolo nella valle del Belice, antica Alcidia
degli Elimi e Salem, "luogo di delizie", degli Arabi, che la
conquistarono intorno ai primi decenni del nono secolo, si svolgono, da
tempo immemorabile, "Cene" di S.Giuseppe estremamente suggestive
e coinvolgenti, sia per gli "apparatiscenici" che fanno da sfondo
al banchetti, che per il cerimoniale, costituito da suoni, da preghiere,
da spari, da poesie. Il rito, che si poneva alle origini come rito pagano
con carattere propiziatorio, fu adattato nel tempo a culto cristiano.
Esso segnava l'inizio di un nuovo ciclo stagionale e del risveglio della
natura (equinozio di primavera); dedicandolo a S.Giuseppe, divenne, in
conseguenza, esaltazione della famiglia e del lavoro. Le "Cene",ancor
oggi "sentite" e vissute dalla popolazione di Salemi consistono
in banchetti offerti da alcune farniglie del luogo, per voto e/o devozione,
a gruppi di bambini poveri (in numero di tre) rappresentanti la Sacra
Famiglia. Talvolta i devoti possono estendere l'invito anche ad altri
"Santi" o "Virgineddi"(così vengono chiamati
comunemente tutti i personaggi) che impersonano in particolare S. Anna
e S. Gioacchino. I preparativi della festa, che culmina nei riti del 19
marzo, si protraggono per diversi giorni. Alle donne, riunite nelle case
ove avranno luogo le "Cene",è affidata la preparazione
dei pani, elementi fondamentali del rito, modellati con speciali arnesi
e straordinaria maestria. Tali piccoli capolavori presentano una notevole
varietà di forme, nelle quali sono individuati temi pagani e cristiani,
arricchitisi nel tempo con gli apporti della fantasia popolare. I pani
rappresentano soggetti legati al mondo contadino quali fiori, cestinelli
ricolmi di frutta, grappoli d'uva, baccelli di fava; animali quali farfalle,
uccelli, cavalli, pavoni. "E da datare all'ascesa al trono di Sicilia
di Carlo V d'Asburgo, ("Un'ipotesi sull'origine e sul significato
delle "Cene"di S. Giuseppe" di A. Planeta Catalíotti).
Le forme cosi modellate evidenziano una predominanza di elementi pagani,
mentre la presenza di pani con immagini di pesci, agnelli, gigli, rose,
angeli, o quelli inerenti all'attività di falegname del Santo,
quali martello, sega, tenaglie testimoniano la valenza religiosa del rito.
Alle donne delle case ospitanti ed alle foro vicine è demandato
il compito di estrinsecare in tali manufatti la loro fantasia, con l'osservanza
di una tradizione ben determinata, mentre è affidata agli uomini
la costruzione della "cappelletta'' e dell'altare sottostante, in
un ambiente dell'alloggío in cui si svolgerà la cena. La
struttura portante di tale piccola "chiesa" viene rivestita
interamente con rami di mirto e di alloro, "simboli agresti con significato
propiziatorio" e decorata con arance, limoni e pani, tanto da dar
forma a festoni di gusto rinascimentale. Al centro dell'altare, in alto,
si pone un'immagine raffigurante la Sacra Famiglia e sul ripiano più
basso vengono collegati i grandi pani, che corrispondono generalmente
al numero dei "santi" invitati. Al centro della stanza si dispone
la tavola del banchetto. Nei giorni antecedenti la festa si preparano
le pietanze che verranno consumate il giorno 19 e dalle quali viene esclusa
la carne poiché la cerimonia si svolge in un periodo di Quaresima.
Il pranzo è il momento più importante della festa: i pani
e l'altare vengono benedetti da un sacerdote, mentre i padroni di casa
accompagnano i "Santi" a tavola, dopo aver loro lavato e baciato
le mani; quindi, servono le pietanze che vengono divise anche con coloro
che sono presenti al banchetto, perchè tutti possano ottenere,
con questo rito propiziatorio, delle grazie ed assicurarsi bene ed abbondanza.
L'ingresso di ciascuna pietanza nella stanza viene salutato da un rullo
di tamburo (in passato veniva evidenziato da uno sparo di fucile), mentre
la padrona di casa spiega il significato delle singole portate. Una componente
importante della festa è rappresentata dalle cosidette
Un
processo di riappropriazione della nostra terra non può prescindere
da una lettura della storia siciliana vista anche attraverso le tradizioni
popolari che costituiscono, ancora oggi, un forte elemento di arricchimento
culturale. Di tali tradizioni, che rappresentano, innazitutto, momenti
di aggregazione popolare non disgiunti da una notevole carica di sentimenti,
fanno parte un gran numero di feste, riti, cerimonie, in cui motivi pagani
si mescolano a quelli religiosi. Fra le manifestazioni che ancor oggi
hanno luogo nell'isola, un posto di sicuro rilievo è occupato dalle
cerimonie in onore di S. Giuseppe. Secondo il Pitrè " ...
l'uso del banchetto detto di S. Giuseppe e di altri usi popolari nel giorno
19 marzo... può esser nato... dalla sua particolar prerogativa...
diessere il Santo tutelare dei poveri, degli orfani, di chi volge in grandi
strettezze di vita... Il banchetto si fa da tutti i Siciliani con più
o meno pompe, con maggior o minor lautezza e profusione di vivande". A
Salemi, importante centro agricolo nella valle del Belice, antica Alcidia
degli Elimi e Salem, "luogo di delizie", degli Arabi, che la
conquistarono intorno ai primi decenni del nono secolo, si svolgono, da
tempo immemorabile, "Cene" di S.Giuseppe estremamente suggestive
e coinvolgenti, sia per gli "apparatiscenici" che fanno da sfondo
al banchetti, che per il cerimoniale, costituito da suoni, da preghiere,
da spari, da poesie. Il rito, che si poneva alle origini come rito pagano
con carattere propiziatorio, fu adattato nel tempo a culto cristiano.
Esso segnava l'inizio di un nuovo ciclo stagionale e del risveglio della
natura (equinozio di primavera); dedicandolo a S.Giuseppe, divenne, in
conseguenza, esaltazione della famiglia e del lavoro. Le "Cene",ancor
oggi "sentite" e vissute dalla popolazione di Salemi consistono
in banchetti offerti da alcune farniglie del luogo, per voto e/o devozione,
a gruppi di bambini poveri (in numero di tre) rappresentanti la Sacra
Famiglia. Talvolta i devoti possono estendere l'invito anche ad altri
"Santi" o "Virgineddi"(così vengono chiamati
comunemente tutti i personaggi) che impersonano in particolare S. Anna
e S. Gioacchino. I preparativi della festa, che culmina nei riti del 19
marzo, si protraggono per diversi giorni. Alle donne, riunite nelle case
ove avranno luogo le "Cene",è affidata la preparazione
dei pani, elementi fondamentali del rito, modellati con speciali arnesi
e straordinaria maestria. Tali piccoli capolavori presentano una notevole
varietà di forme, nelle quali sono individuati temi pagani e cristiani,
arricchitisi nel tempo con gli apporti della fantasia popolare. I pani
rappresentano soggetti legati al mondo contadino quali fiori, cestinelli
ricolmi di frutta, grappoli d'uva, baccelli di fava; animali quali farfalle,
uccelli, cavalli, pavoni. "E da datare all'ascesa al trono di Sicilia
di Carlo V d'Asburgo, ("Un'ipotesi sull'origine e sul significato
delle "Cene"di S. Giuseppe" di A. Planeta Catalíotti).
Le forme cosi modellate evidenziano una predominanza di elementi pagani,
mentre la presenza di pani con immagini di pesci, agnelli, gigli, rose,
angeli, o quelli inerenti all'attività di falegname del Santo,
quali martello, sega, tenaglie testimoniano la valenza religiosa del rito.
Alle donne delle case ospitanti ed alle foro vicine è demandato
il compito di estrinsecare in tali manufatti la loro fantasia, con l'osservanza
di una tradizione ben determinata, mentre è affidata agli uomini
la costruzione della "cappelletta'' e dell'altare sottostante, in
un ambiente dell'alloggío in cui si svolgerà la cena. La
struttura portante di tale piccola "chiesa" viene rivestita
interamente con rami di mirto e di alloro, "simboli agresti con significato
propiziatorio" e decorata con arance, limoni e pani, tanto da dar
forma a festoni di gusto rinascimentale. Al centro dell'altare, in alto,
si pone un'immagine raffigurante la Sacra Famiglia e sul ripiano più
basso vengono collegati i grandi pani, che corrispondono generalmente
al numero dei "santi" invitati. Al centro della stanza si dispone
la tavola del banchetto. Nei giorni antecedenti la festa si preparano
le pietanze che verranno consumate il giorno 19 e dalle quali viene esclusa
la carne poiché la cerimonia si svolge in un periodo di Quaresima.
Il pranzo è il momento più importante della festa: i pani
e l'altare vengono benedetti da un sacerdote, mentre i padroni di casa
accompagnano i "Santi" a tavola, dopo aver loro lavato e baciato
le mani; quindi, servono le pietanze che vengono divise anche con coloro
che sono presenti al banchetto, perchè tutti possano ottenere,
con questo rito propiziatorio, delle grazie ed assicurarsi bene ed abbondanza.
L'ingresso di ciascuna pietanza nella stanza viene salutato da un rullo
di tamburo (in passato veniva evidenziato da uno sparo di fucile), mentre
la padrona di casa spiega il significato delle singole portate. Una componente
importante della festa è rappresentata dalle cosidette "parti" di San Giuseppe, composizioni poetiche popolari che
vengono tramandate oralmente di generazione in generazione e che, in forma
spesso molto ingenua, esaltano le virtù dei "Santi" della
Sacra Famiglia. Le invocazioni erano, in passato, di esclusiva pertinenza
di "poeti",i quali, visitando le case ove si svolgevano i banchetti,
recitavano in dialetto. Col
trascorrere del tempo, tale consuetudine è andata purtroppo, scomparendo
quasi dei tutto.
"parti" di San Giuseppe, composizioni poetiche popolari che
vengono tramandate oralmente di generazione in generazione e che, in forma
spesso molto ingenua, esaltano le virtù dei "Santi" della
Sacra Famiglia. Le invocazioni erano, in passato, di esclusiva pertinenza
di "poeti",i quali, visitando le case ove si svolgevano i banchetti,
recitavano in dialetto. Col
trascorrere del tempo, tale consuetudine è andata purtroppo, scomparendo
quasi dei tutto.