
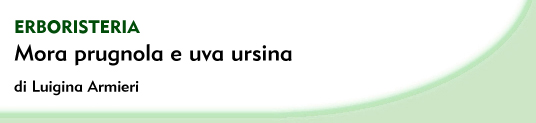
 Noi tutti
mangiamo volentieri il frutto di questa pianta, ma gli antichi lo
apprezzavano forse più di noi; sembra infatti che le antiche popolazioni
si cibassero abbondantemente di "more di rovo"e ne conoscessero
le proprietà astringenti. Sono il
frutto autunnale preferito dagli uccelli, dalle arvicole e dalle volpi. Si
possono mangiare in molti modi: crude o cotte con le mele in marmellata o
gelatina. Si può fare con esse un
buon vino o un eccellente sciroppo per il gelato. I fiori della mora
prugnola o rovo sono raccolti in rami e hanno forma di roselline; possono
essere bianchi o rosei secondo la varietà. I rami lunghi e cadenti
producono i notissimi frutti colore blu scuro, quasi nero. Per
quanto riguarda le proprietà, i frutti, che sono i più usati nella
medicina popolare, contengono zucchero, acidi organici diversi, ecc. Le
foglie contengono una discreta quantità di acido tannico. I frutti hanno
azione astringente, forse per merito dei loro acidi organici, sono perciò
impiegati anche contro l’infiammazione della gola e della bocca sotto
forma di gargarismi. Mangiati in grande quantità irritano le vie
digerenti e producono diarrea. Le foglie e i nuovi getti hanno proprietà
leggermente astringenti e diuretiche. Si impiegano in infuso contro la
diarrea cronica, la dissenteria, l’idropisia, le tonsilliti e i mal di
gola. I frutti, se presi maturi,
costituiscono un alimento sano e gustoso oltrechè rinfrescante. Un tè
molto aromatico si ottiene da un infuso di foglie di rovo mescolate con
quelle di lampone. Il decotto, oltre ad essere un efficace astringente, si
può usare anche come lozione rinfrescante per il viso. Comunque tutte le
preparazioni devono essere accuratamente filtrate. Il rovo si presenta
sotto molteplici forme botaniche e sol
Noi tutti
mangiamo volentieri il frutto di questa pianta, ma gli antichi lo
apprezzavano forse più di noi; sembra infatti che le antiche popolazioni
si cibassero abbondantemente di "more di rovo"e ne conoscessero
le proprietà astringenti. Sono il
frutto autunnale preferito dagli uccelli, dalle arvicole e dalle volpi. Si
possono mangiare in molti modi: crude o cotte con le mele in marmellata o
gelatina. Si può fare con esse un
buon vino o un eccellente sciroppo per il gelato. I fiori della mora
prugnola o rovo sono raccolti in rami e hanno forma di roselline; possono
essere bianchi o rosei secondo la varietà. I rami lunghi e cadenti
producono i notissimi frutti colore blu scuro, quasi nero. Per
quanto riguarda le proprietà, i frutti, che sono i più usati nella
medicina popolare, contengono zucchero, acidi organici diversi, ecc. Le
foglie contengono una discreta quantità di acido tannico. I frutti hanno
azione astringente, forse per merito dei loro acidi organici, sono perciò
impiegati anche contro l’infiammazione della gola e della bocca sotto
forma di gargarismi. Mangiati in grande quantità irritano le vie
digerenti e producono diarrea. Le foglie e i nuovi getti hanno proprietà
leggermente astringenti e diuretiche. Si impiegano in infuso contro la
diarrea cronica, la dissenteria, l’idropisia, le tonsilliti e i mal di
gola. I frutti, se presi maturi,
costituiscono un alimento sano e gustoso oltrechè rinfrescante. Un tè
molto aromatico si ottiene da un infuso di foglie di rovo mescolate con
quelle di lampone. Il decotto, oltre ad essere un efficace astringente, si
può usare anche come lozione rinfrescante per il viso. Comunque tutte le
preparazioni devono essere accuratamente filtrate. Il rovo si presenta
sotto molteplici forme botaniche e sol tanto gli specialisti sono in grado
di distinguerle l’una dall’altra.Questa
pianta, non notissima ai profani, ha un fusto strisciante e legnoso,
foglie persistenti ovali, fiori a grappoli a forma di sonagli, bacche
rosse quando giungono a maturazione, e cresce nei luoghi pietrosi e lungo
i pascoli sulle Alpi e sugli Appennini. L’uva
ursina (nome botanico Arctostaphylos uva ursi) prende nome da una leggenda
dell’Anno Mille: un monaco eremita, inseguito da un orso affamato,
trovò rifugio in una grotta, davanti alla quale si stendeva un tappeto di
quelle piante in piena maturazione, dalle bacche rosse e assai invitanti. L’orso
fu attratto dalle bacche e si dimenticò del monaco che potè così
tornare sano e salvo al suo eremo. La leggenda dice ancora che da allora l’orso
divenne mansueto e domestico. Una
pianta miracolosa, quindi, l’uva ursina. E un po’ lo è davvero
perchè le sue foglie, come sostennero dei dotti inglesi nel Medioevo,
alleviano le infiammazioni dell’apparato genito-urinario e in
particolare le uretriti, le cistiti, la leucorrea, la ritenzione dell’urina
e anche l’enuresi (incontinenza involontaria di urina, specialmente
durante la notte). Per questa
ragione, per un lungo arco di tempo, decotti ed altri preparati di uva
ursina sono stati il rimedio popolare tradizionale per i piccoli, ma
noiosi e ricorrenti disturbi dell’apparato urinario. In
effetti l’uva ursina contiene arbutina che nell’organismo può
produrre sostanze che portano appunto rimedio a stati infiammatori e
morbosi dei reni e della vescica. Recenti
ricerche hanno messo in luce l’efficacia di questa pianta anche contro i
calcoli renali.
tanto gli specialisti sono in grado
di distinguerle l’una dall’altra.Questa
pianta, non notissima ai profani, ha un fusto strisciante e legnoso,
foglie persistenti ovali, fiori a grappoli a forma di sonagli, bacche
rosse quando giungono a maturazione, e cresce nei luoghi pietrosi e lungo
i pascoli sulle Alpi e sugli Appennini. L’uva
ursina (nome botanico Arctostaphylos uva ursi) prende nome da una leggenda
dell’Anno Mille: un monaco eremita, inseguito da un orso affamato,
trovò rifugio in una grotta, davanti alla quale si stendeva un tappeto di
quelle piante in piena maturazione, dalle bacche rosse e assai invitanti. L’orso
fu attratto dalle bacche e si dimenticò del monaco che potè così
tornare sano e salvo al suo eremo. La leggenda dice ancora che da allora l’orso
divenne mansueto e domestico. Una
pianta miracolosa, quindi, l’uva ursina. E un po’ lo è davvero
perchè le sue foglie, come sostennero dei dotti inglesi nel Medioevo,
alleviano le infiammazioni dell’apparato genito-urinario e in
particolare le uretriti, le cistiti, la leucorrea, la ritenzione dell’urina
e anche l’enuresi (incontinenza involontaria di urina, specialmente
durante la notte). Per questa
ragione, per un lungo arco di tempo, decotti ed altri preparati di uva
ursina sono stati il rimedio popolare tradizionale per i piccoli, ma
noiosi e ricorrenti disturbi dell’apparato urinario. In
effetti l’uva ursina contiene arbutina che nell’organismo può
produrre sostanze che portano appunto rimedio a stati infiammatori e
morbosi dei reni e della vescica. Recenti
ricerche hanno messo in luce l’efficacia di questa pianta anche contro i
calcoli renali.