|
|
|
||
|
Pubblicate nei romani "Quaderni di Novissima" nel 1933, le "Operette"di Nino Savarese, contengono quest'inno alla memoria degli alimenti semplici e vitali della "buona e sana tavola" dei contadini siciliani. Solo un testo poetico può restituirci le meraviglie della terra che abbiamo perduto “Abbiamo perduto la meraviglia della terra: abbiamo perduto ogni ritegno nel toccare i suoi frutti.
Quello dell'uomo primitivo, avvezzo a mangiare frutti sempre freschi, appena colti, non si è perduto nei millenni, tanto è vero che, ancora oggi, l'astuto mercante cerca di illuderlo in cento modi. E il pane, fatto dalle massaie col grano schietto, convince, ancora oggi, della sua eccellenza anche il raffinato che ha dimenticato il sano e buon odore. E tra le innumerevoli filiazioni, tra le più sottili esercitazioni degli enologi, riconosceremo sempre, con lieta soddisfazione, il vino fatto secondo le semplici ed oneste regole dell'antica esperienza, che, appena versato, spande un profumo quasi rude, agreste, ilare, come se vi gemesse dentro un alito vivo, rimastovi imprigionato dagli ultimi soli autunnali. La tavola alla quale ognuno vorrebbe sedere ha la tovaglia di tela bianchissima, che mostra la trama del suo tessuto con lieve evidenza, come le nervature delle foglie: il pane, nella sua forma tonda, rosa scuro, vi si stacca sopra come un grosso ciottolo, ma aperto, si scioglie in bionda tenerezza e in profumo. Il vino, portato dalla cantina in uno di quei boccali di terra stagnata che portano dipinto un ramoscello azzurro sul grigio, riempie la bottiglia tozza di cristallo con un vigore di intima allegria, che sale spumeggiando fino all'orlo e scompare. Se il bollito è di cappone o l'arrosto è di galletto, furono scannati ieri sera e passarono la notte sul davanzale della finestra, a tramontana, che dà sull'orto: hanno la carne bianca e la pelle fina e morbida dei polli di razza nostrana, non d'insueto colore come quelli di razze forestiere o incrociate, nè quell'aspetto imbalsamato che prendono nei lunghi soggiorni glaciali. Se invece si tratta di salsiccie, queste non provengono dagli allevamenti dove i maialacci si fanno enormi e flaccidi con le brode razionali, ma da un porcello di pelo nero e riccio che abitò fino a Natale il prossimo bosco, dove passò le giornate a cercare avventurosamente le ghiande o le radici del cipollaccio o quelle più fonde e più dolci che si trovano mescolate all'erba dei pascoli naturali. E direste che un pò di quell'odore di bosco è passato nella sua carne. L'ampolla, che col suo giallo d'oro fa un bell'accordo col rubino della bottiglia, è piena di olio di quest'anno: sa di oliva nella sua acre fragranza; il notturno lavoro del frantoio, nella sua accorta semplicità, non cancellò la chiara e naturale parentela col frutto prezioso.
Sulla tovaglia di lino o sulla nuda pietra aleggia un soffio armonioso, allorché il cibo è schietto e naturale, anche se frugale e misurato. La perizia dei chimici e la furbizia dei mercanti ingannano qualche volta il nostro palato, non mai il nostro spirito. La mensa artificiata e corrotta, anche sotto l'apparente opulenza e splendore, non è mai lieta e confortevole; vi sta sopra quasi un senso di peccato; il sospetto del falso. Il diletto della buona e sana tavola ha origini profonde e lontane. Appropriandosi dei suoi frutti e nutrendosene, l'uomo prende un contatto con la terra, troppo intimo: fino a mescolare le sue linfe col proprio sangue. E non solo il piacere fisico della soddisfazione di un bisogno gli viene da questa unione, ma anche da una specie di allegria naturale. Ma i prodotti della terra ed anche gli animali, che essa nutre, ci ritornano irriconoscibili dai recessi misteriosi delle fabbriche nelle quali scomparvero. L'opera dell'uomo si fa sempre più prepotente; il giuoco dei suoi commerci sempre più sottile. I mucchi crescono nei mercati e lungo le vie; le botteghe, dalle quali viene un odore nauseante, sono colme fino agli usci; le enormi ghiacciaie operano miracoli sul tempo ed i commercianti di primizie operano violente corruzioni sulle stagioni. E' naturale che, di tanto in tanto, ci prenda il desiderio di vedere l'uva calpestata dagli zoccoli del vignarolo, sentire l'odore del mosto, guardarlo da vicino nella vasca del palmento di pietra, dove un raggio di sole, che giunge dalla finestretta, accende una vampata di rubino o d'oro; oppure che ci prenda vaghezza di mangiare una scodella di ricotta ancora calda, dopo avere atteso che cagliasse, tra lo schioppettio delle frasche e dopo aver seguito la sicura maestria del casaro nel suo lavoro, accanto all'ovile, all'aria fresca del primo mattino; e magari che ci prenda desiderio di mangiare la carne cotta sulla brace o di andare vagando per cogliere l'erba spontanea da insalata, che cresce al tempo giusto, o le profumate fragole del bosco che maturano in armonia coi solstizii e sotto la guida del sole. Giacché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, ma rendere omaggio alla natura, apprezzarne i doni meravigliosi e gioirne e di questi ringraziare Dio. I contadini cominciano e finiscono i loro semplici e puliti pasti con una breve preghiera e, in qualche parte di Sicilia, la massaia, nel portar via il pane dalla tavola, dice che "l'angelo vola via e va a posarsi sopra un'altra tavola".
|
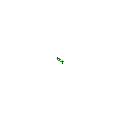

 In principio la
ripudiammo, nel suo più bel giardino, che era immagine del Paradiso. Perciò
sogneremo sempre un giardino. Ci rimane un'inconscia memoria, un richiamo
nostalgico in fondo al cuore, un amore della terra coltivata e feconda, che
si ridesta periodicamente come un rimorso. Solo in certi momenti gli alberi
carichi di frutti e le biade mature ci appaiono come doni meravigliosi che
quasi ci mortificano. Allorché, delusi di tutto quello che facciamo
violentemente sulla terra, sporgiamo il volto nella solitudine a contemplare
la terra stessa, che sostiene questo sogno dell'esistenza, ci basta poco per
sentire rinnovata la meraviglia di questa cosa non celeste che calpestiamo e
sulla quale poggiamo con tutto il nostro peso: un grappolo sul tralcio, un
animale sull'erba, un fiore alto su un crepaccio. Ma che cosa non abbiamo
fatto dei frutti della terra che la Provvidenza ci ha destinato per cibarci?
Abbiamo turbato tutte le fruttificazioni, abbiamo inquinato le industrie più
antiche e patriarcali, abbiamo arruffato tutti i commerci. Abbiamo preso
tutto l'utile che potevano darci, respingendone ogni diletto. Ma comunque
traditi, comunque mortificati, certi nostri gusti ci richiamano
continuamente ad una fedeltà eterna.
In principio la
ripudiammo, nel suo più bel giardino, che era immagine del Paradiso. Perciò
sogneremo sempre un giardino. Ci rimane un'inconscia memoria, un richiamo
nostalgico in fondo al cuore, un amore della terra coltivata e feconda, che
si ridesta periodicamente come un rimorso. Solo in certi momenti gli alberi
carichi di frutti e le biade mature ci appaiono come doni meravigliosi che
quasi ci mortificano. Allorché, delusi di tutto quello che facciamo
violentemente sulla terra, sporgiamo il volto nella solitudine a contemplare
la terra stessa, che sostiene questo sogno dell'esistenza, ci basta poco per
sentire rinnovata la meraviglia di questa cosa non celeste che calpestiamo e
sulla quale poggiamo con tutto il nostro peso: un grappolo sul tralcio, un
animale sull'erba, un fiore alto su un crepaccio. Ma che cosa non abbiamo
fatto dei frutti della terra che la Provvidenza ci ha destinato per cibarci?
Abbiamo turbato tutte le fruttificazioni, abbiamo inquinato le industrie più
antiche e patriarcali, abbiamo arruffato tutti i commerci. Abbiamo preso
tutto l'utile che potevano darci, respingendone ogni diletto. Ma comunque
traditi, comunque mortificati, certi nostri gusti ci richiamano
continuamente ad una fedeltà eterna. Ed ecco il formaggio
uscito dalle oneste mani del vecchio casaro, che si farebbe uno scrupolo di
peccato a macchiare, con l'arbitrio o con la frode, la purezza del latte e
smentire la pratica tradizionale del suo lavoro; ed ecco le olive conservate
col solo sale e la frutta colta di prima mattina, prima che il sole ne
afflosci la polpa; e alla fine, a un grido dalla finestra, qualcuno porterà
un piede di lattuga o un finocchio, con tra le foglie qualche petalo del
ciliegio che vi è fiorito sopra.
Ed ecco il formaggio
uscito dalle oneste mani del vecchio casaro, che si farebbe uno scrupolo di
peccato a macchiare, con l'arbitrio o con la frode, la purezza del latte e
smentire la pratica tradizionale del suo lavoro; ed ecco le olive conservate
col solo sale e la frutta colta di prima mattina, prima che il sole ne
afflosci la polpa; e alla fine, a un grido dalla finestra, qualcuno porterà
un piede di lattuga o un finocchio, con tra le foglie qualche petalo del
ciliegio che vi è fiorito sopra.