
Troina ha una storia dalle origine antichissime. Scavi recenti hanno individuato insediamenti umani risalenti al neolitico (una fattoria del 6000 a. c.) e la necropoli ancora visitabile e sita sul monte Muganà testimonia della vita preistorica della cittadina.
 Sicure tracce della forma dell'antica città d'età greca si riscontrano
nella cinta muraria a blocchi, del IV secolo a. C., che racchiudeva quello
che è stato sino a qualche decennio fa l'assetto del paese. Resti di terme
romane ci ricordano che il periodo che va dal I sec. a C. al II seTroina
ha una storia dalle origine antichissime. Scavi recenti hanno individuato
insediamenti umani risalenti al neolitico (una fattoria del 6000 a. c.)
e la necropoli ancora visitabile e sita sul monte Muganà testimonia
della vita preistorica della cittadina.c. a. C. fu discretamente florido
per Troina, che molto probabilmente in quei secoli aveva per nome Engyon,
almeno a dar ragione ai numerosi studi che partendo da un passo di Diodoro
Siculo, hanno identificato nel sito della celebre città delle Dee madri
e del famoso ed eccentrico culto che a queste era dedicato, l'attuale
Troina. Centro militare per eccellenza e via di comunicazione tra la Sicilia
occidentale e quella orientale, è stato sempre sito ambito dai popoli
che si stanziarono da conquistatori o da liberatori, nell'isola. La sua
parte alta non a caso consisteva in un enorme Castello (la cui estensione
andava dall'attuale Piazza Conte Ruggero alla Piazza Santa
Lucia) con quattro porte d'ingresso e numerose torri.I musulmani realizzarono
parte della sua struttura urbana del paese. Il suggestivo e labirintico
quartiere di Scalforio (in arabo fuori le mura) ne è ancora
preziosa rimanenza. I bizantini vi dominarono a lungo e da Troina, il
generale Maniace, preparò a battaglia contro gli arabi stanziati a Cerami.
Un'affascinante descrizione letteraria di quell'episodio che il turista
oggi può far rivivere muovendosi nei luoghi di allora che ancora sono
ben conservati, ce la dà nel suo romanzo, L'amante del paradiso (Mondadori),
Silvana la Spina: 'Laggiù sulla rocca è Troina. Una manciata di
case tra Nebrodi freddi, tra picchi e colline dall'erba gelida e la punta
dell'Etna laggiù che sempre fuma.Una cittadina antica dove da tempo abitano
accanto e in buon vicinato musulmani e cristiani, ognuno con le usanze
sue, gli uomini si prestano gli arnesi, le donne il cotone pel filato….Insomma
brava gente di montagna, dove il qadi va a far visita al prete, e insieme
parlano di Vangelo e di Corano, di Cristo e del diavolo tentatore; della
santa Anima che vomita rose e che pare diventata un cadavere a furia di
digiunare per Nostro Signore, o per Allah che è lo stesso. Gente appunto
che sa poco delle cose de4l mondo, dei fatti accaduti e di quelli che
accadranno, ma stamani ugualmente a Troina si è svegliata per il gran
rumore di cavalli e i ragazzi sono corsi per le strade ….Sale ora chi
può sulle case più alte, sul campanile del convento di San Michele o sul
minareto della moschea - Vardati là quanti surdati. Quelli là portano
il segno della croce, quelli là dirimpetto il vessillo del profeta. Ora
godemuni lu scannascanna'
I normanni vissero a Troina momenti
importanti della loro storia.
Sicure tracce della forma dell'antica città d'età greca si riscontrano
nella cinta muraria a blocchi, del IV secolo a. C., che racchiudeva quello
che è stato sino a qualche decennio fa l'assetto del paese. Resti di terme
romane ci ricordano che il periodo che va dal I sec. a C. al II seTroina
ha una storia dalle origine antichissime. Scavi recenti hanno individuato
insediamenti umani risalenti al neolitico (una fattoria del 6000 a. c.)
e la necropoli ancora visitabile e sita sul monte Muganà testimonia
della vita preistorica della cittadina.c. a. C. fu discretamente florido
per Troina, che molto probabilmente in quei secoli aveva per nome Engyon,
almeno a dar ragione ai numerosi studi che partendo da un passo di Diodoro
Siculo, hanno identificato nel sito della celebre città delle Dee madri
e del famoso ed eccentrico culto che a queste era dedicato, l'attuale
Troina. Centro militare per eccellenza e via di comunicazione tra la Sicilia
occidentale e quella orientale, è stato sempre sito ambito dai popoli
che si stanziarono da conquistatori o da liberatori, nell'isola. La sua
parte alta non a caso consisteva in un enorme Castello (la cui estensione
andava dall'attuale Piazza Conte Ruggero alla Piazza Santa
Lucia) con quattro porte d'ingresso e numerose torri.I musulmani realizzarono
parte della sua struttura urbana del paese. Il suggestivo e labirintico
quartiere di Scalforio (in arabo fuori le mura) ne è ancora
preziosa rimanenza. I bizantini vi dominarono a lungo e da Troina, il
generale Maniace, preparò a battaglia contro gli arabi stanziati a Cerami.
Un'affascinante descrizione letteraria di quell'episodio che il turista
oggi può far rivivere muovendosi nei luoghi di allora che ancora sono
ben conservati, ce la dà nel suo romanzo, L'amante del paradiso (Mondadori),
Silvana la Spina: 'Laggiù sulla rocca è Troina. Una manciata di
case tra Nebrodi freddi, tra picchi e colline dall'erba gelida e la punta
dell'Etna laggiù che sempre fuma.Una cittadina antica dove da tempo abitano
accanto e in buon vicinato musulmani e cristiani, ognuno con le usanze
sue, gli uomini si prestano gli arnesi, le donne il cotone pel filato….Insomma
brava gente di montagna, dove il qadi va a far visita al prete, e insieme
parlano di Vangelo e di Corano, di Cristo e del diavolo tentatore; della
santa Anima che vomita rose e che pare diventata un cadavere a furia di
digiunare per Nostro Signore, o per Allah che è lo stesso. Gente appunto
che sa poco delle cose de4l mondo, dei fatti accaduti e di quelli che
accadranno, ma stamani ugualmente a Troina si è svegliata per il gran
rumore di cavalli e i ragazzi sono corsi per le strade ….Sale ora chi
può sulle case più alte, sul campanile del convento di San Michele o sul
minareto della moschea - Vardati là quanti surdati. Quelli là portano
il segno della croce, quelli là dirimpetto il vessillo del profeta. Ora
godemuni lu scannascanna'
I normanni vissero a Troina momenti
importanti della loro storia.  Ruggero
scelse Troina come avamposto per la conquista dell'intera isola. Prese
il Castello nel 1061 e istituì un presidio che durò per più di trent'anni.
Furono anni di profonde trasformazioni del territorio della città: l'erezione
dei conventi di San Michele Arcangelo, di San'Elia di Ambola, di San Mercurio,
nonché della Cattedrale, diedero decoro architettonico alla città che
poté fregiarsi anche, nel 1082, del titolo di sede vescovile, sempre per
concessione del Gran Conte. La fondazione dei conventi basiliani a Troina
, oltre ché strumento di conquista dei sentimenti popolari locali, obbediva
ad una logica di potenziamento di quel collegamento viario che aveva visto
già Troina in età bizantina (e anche precedentemente) come punto di transito
montuoso lungo il percorso Taormina -Termini; con i normanni da
Troina, Capitale della Contea, si attiva una via regia che conduce a San
Marco, sito portuale strategico e sede, per un periodo, della Corte normanna.
Un itinerario di rilievo turistico odierno: partendo da Troina e attraversando
i Nebrodi, alla scoperta dei conventi basiliani; visitando i paesi sulla
traiettoria della via regia Troina - San Marco alla scoperta delle feste
sopravvissute da antichi riti paganeggianti e falloforici, nel periodo
primaverile (u ddauru a Troina, i muzzuni ad Alcara Li Fusi, la festa
dei giudei a San Fratello) Troina, prima capitale normanna dell'isola,
fu più volte teatro di rivolte fomentate dai saraceni, partecipate dalla
popolazione locale, sedate dai guerrieri del Conte. Nel 1088 vi
soggiornò papa Urbano II, che, nominato papa a Terracina, non era potuto
entrare a Roma, dove allora dominava l'antipapa Callisto III, sotto la
protezione dell'imperatore svevo Enrico IV. Papa Urbano II chiese ai Normanni
un aiuto militare per entrare a Roma e spodestare il rivale antipapa.
Urbano II compensò poi il favore dei Normanni con la speciale prerogativa
della "Apostolica Legazia", che dava facoltà ai re di Sicilia
di nominare direttamente i vescovi siciliani. Declinando il potere normanno,
spostata la sede vescovile a Messina, Troina perde centralità e prestigio,
ma resta città demaniale, occupa un posto nel parlamento siciliano, ha
un Regio castello, è difesa da milizie cittadine. Deve comunque difendersi
dalle mire di feudatari e baroni che aspirano a sottometterla. Nel 1300
viene addirittura venduta dal re Federico III d'Aragona ad un nobile,
Matteo Alagona; riconquistata la libertà, successivamente viene rivenduta
dal re Martino d'Aragona al barone Pietro Moncada. Riacquista i privilegi
di città demaniale, nel 1398, probabilmente grazie all'interessamento
presso il sovrano del nobile troinese Francesco di Napoli. I privilegi
di città libera continuano nei secoli a venire e vengono confermati ancora,
da Carlo V, nel 1535. Come visse la città gli avvenimenti del cinquecento
lo indica un quadretto dell'epoca che possiamo leggere in un testo dei
primi del '900 del medico e storico troinese, Salvatore Saitta :
'poco dovette pesare sul paese il tetro
gigante della preponderanza Spagnola e quantunque i Vicerè boriosi avessero
imposto esose gabelle e contribuzioni, non pertanto queste né le carastie
dovettero sgomentare le buoni popolazioni di Troina, fra le quali spirava
un'aura di benessere. La vita trascorreva calma, non turbata da contumelie
civili, i generi alimentari erano abbondanti e a buon mercato, i bilanci
comunali, scevri da preoccupazioni di lusso, s'impiegavano per contributi
erariali, per trasferte di Capitani d'arme e per feste, raramente si pagava
il boia per qualche spettacolosa esecuzione capitale e con molto poco:
con sei tarì'. A preoccupare
i troinesi del tempo vi fu sicuramente l'epidemia di peste che interessò
il paese nel 1575. Il morbo venne affrontato con suppliche e preghiere
al Santo patrono e con i rimedi medici allora conosciuti: l'isolamento
degli infermi e l'istituzione di cordoni sanitari. La peste lasciò numerose
vittime e il paese in condizioni precarie.
Ruggero
scelse Troina come avamposto per la conquista dell'intera isola. Prese
il Castello nel 1061 e istituì un presidio che durò per più di trent'anni.
Furono anni di profonde trasformazioni del territorio della città: l'erezione
dei conventi di San Michele Arcangelo, di San'Elia di Ambola, di San Mercurio,
nonché della Cattedrale, diedero decoro architettonico alla città che
poté fregiarsi anche, nel 1082, del titolo di sede vescovile, sempre per
concessione del Gran Conte. La fondazione dei conventi basiliani a Troina
, oltre ché strumento di conquista dei sentimenti popolari locali, obbediva
ad una logica di potenziamento di quel collegamento viario che aveva visto
già Troina in età bizantina (e anche precedentemente) come punto di transito
montuoso lungo il percorso Taormina -Termini; con i normanni da
Troina, Capitale della Contea, si attiva una via regia che conduce a San
Marco, sito portuale strategico e sede, per un periodo, della Corte normanna.
Un itinerario di rilievo turistico odierno: partendo da Troina e attraversando
i Nebrodi, alla scoperta dei conventi basiliani; visitando i paesi sulla
traiettoria della via regia Troina - San Marco alla scoperta delle feste
sopravvissute da antichi riti paganeggianti e falloforici, nel periodo
primaverile (u ddauru a Troina, i muzzuni ad Alcara Li Fusi, la festa
dei giudei a San Fratello) Troina, prima capitale normanna dell'isola,
fu più volte teatro di rivolte fomentate dai saraceni, partecipate dalla
popolazione locale, sedate dai guerrieri del Conte. Nel 1088 vi
soggiornò papa Urbano II, che, nominato papa a Terracina, non era potuto
entrare a Roma, dove allora dominava l'antipapa Callisto III, sotto la
protezione dell'imperatore svevo Enrico IV. Papa Urbano II chiese ai Normanni
un aiuto militare per entrare a Roma e spodestare il rivale antipapa.
Urbano II compensò poi il favore dei Normanni con la speciale prerogativa
della "Apostolica Legazia", che dava facoltà ai re di Sicilia
di nominare direttamente i vescovi siciliani. Declinando il potere normanno,
spostata la sede vescovile a Messina, Troina perde centralità e prestigio,
ma resta città demaniale, occupa un posto nel parlamento siciliano, ha
un Regio castello, è difesa da milizie cittadine. Deve comunque difendersi
dalle mire di feudatari e baroni che aspirano a sottometterla. Nel 1300
viene addirittura venduta dal re Federico III d'Aragona ad un nobile,
Matteo Alagona; riconquistata la libertà, successivamente viene rivenduta
dal re Martino d'Aragona al barone Pietro Moncada. Riacquista i privilegi
di città demaniale, nel 1398, probabilmente grazie all'interessamento
presso il sovrano del nobile troinese Francesco di Napoli. I privilegi
di città libera continuano nei secoli a venire e vengono confermati ancora,
da Carlo V, nel 1535. Come visse la città gli avvenimenti del cinquecento
lo indica un quadretto dell'epoca che possiamo leggere in un testo dei
primi del '900 del medico e storico troinese, Salvatore Saitta :
'poco dovette pesare sul paese il tetro
gigante della preponderanza Spagnola e quantunque i Vicerè boriosi avessero
imposto esose gabelle e contribuzioni, non pertanto queste né le carastie
dovettero sgomentare le buoni popolazioni di Troina, fra le quali spirava
un'aura di benessere. La vita trascorreva calma, non turbata da contumelie
civili, i generi alimentari erano abbondanti e a buon mercato, i bilanci
comunali, scevri da preoccupazioni di lusso, s'impiegavano per contributi
erariali, per trasferte di Capitani d'arme e per feste, raramente si pagava
il boia per qualche spettacolosa esecuzione capitale e con molto poco:
con sei tarì'. A preoccupare
i troinesi del tempo vi fu sicuramente l'epidemia di peste che interessò
il paese nel 1575. Il morbo venne affrontato con suppliche e preghiere
al Santo patrono e con i rimedi medici allora conosciuti: l'isolamento
degli infermi e l'istituzione di cordoni sanitari. La peste lasciò numerose
vittime e il paese in condizioni precarie. 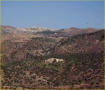 Altre
sciagure e distruzioni porteranno, il secolo successivo, i due terribili
terremoti del 1643 e del 1693. Fra questi eventi di calamità naturale,
non mancò un episodio di iattura politica: la città venne nuovamente venduta
dal re Filippo IV a Marco Antonio Scribani Genovese; fu riscattata ancora
una volta per volontà di un esponente della famiglia di Napoli, il vescovo
Vincenzo, che con propri denari la resa libera acquistandola dallo Scribani
Genovesi. Il settecento vede, a Troina, il perdurare delle condizioni
di vita che oscillavano tra normalità e periodiche crisi. Il ceto patrizio
che governa la città assieme al clero numeroso e prestigioso tenta di
far riguadagnare alla città, l'antico titolo di sede vescovile, intravedendo
in questa possibilità l'occasione per una rinascita economica e
per riconquistare potere nell'interno della Sicilia. Ma la sede vescovile,
contesa da Troina e da Nicosia, sarà a quest'ultima assegnata, determinando
probabilmente l'inizio di un lungo e lento declino degli enti religiosi
della città. Le prime avvisaglie di decadenza riguardano l'ordine basiliano,
quello più potente e storicamente più importante per Troina. In questo
periodo viene costruito il convento di san Michele Nuovo, (ancor
oggi maestoso seppur consistente in semplici resti) , più vicino al paese,
sito in luogo più comodo, con ambienti più sfarzosi e ampi rispetto
alle modeste ed essenziali stanze dell'altra e più antica residenza dei
monaci basiliani. Indicativo questo cambiamento della perdita dell'antico
vigore religioso che aveva caratterizzato la presenza dell'ordine
religioso a Troina, che rimane però ancora ragguardevole e incisiva. Invece,
tutt'altro che trascurabile è la presenza di spirito pubblico (e illuministico)
che anima la città nel secondo settecento: la fioritura di opere tecnico-scientifiche
ispirate da una vivace curiosità e da acume sperimentale è ragguardevole:
gli scritti di Fra Angelico Capizzi 'sull'arte di costruire gnonomi',
Altre
sciagure e distruzioni porteranno, il secolo successivo, i due terribili
terremoti del 1643 e del 1693. Fra questi eventi di calamità naturale,
non mancò un episodio di iattura politica: la città venne nuovamente venduta
dal re Filippo IV a Marco Antonio Scribani Genovese; fu riscattata ancora
una volta per volontà di un esponente della famiglia di Napoli, il vescovo
Vincenzo, che con propri denari la resa libera acquistandola dallo Scribani
Genovesi. Il settecento vede, a Troina, il perdurare delle condizioni
di vita che oscillavano tra normalità e periodiche crisi. Il ceto patrizio
che governa la città assieme al clero numeroso e prestigioso tenta di
far riguadagnare alla città, l'antico titolo di sede vescovile, intravedendo
in questa possibilità l'occasione per una rinascita economica e
per riconquistare potere nell'interno della Sicilia. Ma la sede vescovile,
contesa da Troina e da Nicosia, sarà a quest'ultima assegnata, determinando
probabilmente l'inizio di un lungo e lento declino degli enti religiosi
della città. Le prime avvisaglie di decadenza riguardano l'ordine basiliano,
quello più potente e storicamente più importante per Troina. In questo
periodo viene costruito il convento di san Michele Nuovo, (ancor
oggi maestoso seppur consistente in semplici resti) , più vicino al paese,
sito in luogo più comodo, con ambienti più sfarzosi e ampi rispetto
alle modeste ed essenziali stanze dell'altra e più antica residenza dei
monaci basiliani. Indicativo questo cambiamento della perdita dell'antico
vigore religioso che aveva caratterizzato la presenza dell'ordine
religioso a Troina, che rimane però ancora ragguardevole e incisiva. Invece,
tutt'altro che trascurabile è la presenza di spirito pubblico (e illuministico)
che anima la città nel secondo settecento: la fioritura di opere tecnico-scientifiche
ispirate da una vivace curiosità e da acume sperimentale è ragguardevole:
gli scritti di Fra Angelico Capizzi 'sull'arte di costruire gnonomi',
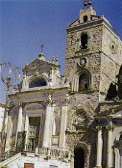 di
Silvestro Trecarichi 'sulle norme della mercatura' (per citarne
solo qualcuno) ne sono testimonianza e, oggi custodite nelle Biblioteche,
la Comunale e quella dei PP. Cappuccini, si prestano gradevolmente
alla consultazione in ambienti che per rilevanza storica e austere fatture,
valgono, al turista, una visita. La presenza del Marchese di Sorrentini
(collaboratore di Tommaso Natale nel lavoro voluto dal Caramanico di censuazione
e assegnazione dei terreni demaniali siciliani ai contadini, citato da
Sciascia, nel Consiglio d'Egitto, come simpatizzante della politica di
riforme del viceré Caracciolo), di Francesco Bonanno, storico e propagandista
della rinomanza di Troina, della sua dignità storica e dei pregi
architettonici della sua struttura, dello scienziato Ignazio Roberti,
favorisce certamente la strenua tutela di quell'impianto urbanistico che
ospita una teoria di conventi e chiese , con i loro campanili e loggiati,
che rendono lustro alla città. Viene seguita, dal patriziato, nelle campagne
a valle del paese, la moda della costruzione di splendide ville,
realizzandosi così un continuum con la struttura urbana. Si popola e si
trasforma in incantevole luogo di residenza estiva, di passeggiata in
campagna e di dilettevoli occupazioni , la contrada di Sotto Badia.
Ville, zone ombrose , fontane, ruderi di vecchi mulini, rendono
oggi questo luogo ideale per una camminata alla scoperta di dimore storiche,
di reperti di archeologia della tecnica disseminati in un angolo incantevole
della natura. Eppure in un contesto che appare aperto al nuovo, non mancarono
reazioni ai mutamenti e volontà di ritorno al passato, se è vero che anche
a Troina, scoppiò, come in tanti comuni della Sicilia, nel 1798, una rivolta
antigiacobina. La
storia ottocentesca di Troina è quella di una realtà rurale dominata da
una élite politica-religiosa. Le caratteristiche di questa élite sono
quelle di un ceto di possidenti ,baroni e borghesi delle professioni
di
Silvestro Trecarichi 'sulle norme della mercatura' (per citarne
solo qualcuno) ne sono testimonianza e, oggi custodite nelle Biblioteche,
la Comunale e quella dei PP. Cappuccini, si prestano gradevolmente
alla consultazione in ambienti che per rilevanza storica e austere fatture,
valgono, al turista, una visita. La presenza del Marchese di Sorrentini
(collaboratore di Tommaso Natale nel lavoro voluto dal Caramanico di censuazione
e assegnazione dei terreni demaniali siciliani ai contadini, citato da
Sciascia, nel Consiglio d'Egitto, come simpatizzante della politica di
riforme del viceré Caracciolo), di Francesco Bonanno, storico e propagandista
della rinomanza di Troina, della sua dignità storica e dei pregi
architettonici della sua struttura, dello scienziato Ignazio Roberti,
favorisce certamente la strenua tutela di quell'impianto urbanistico che
ospita una teoria di conventi e chiese , con i loro campanili e loggiati,
che rendono lustro alla città. Viene seguita, dal patriziato, nelle campagne
a valle del paese, la moda della costruzione di splendide ville,
realizzandosi così un continuum con la struttura urbana. Si popola e si
trasforma in incantevole luogo di residenza estiva, di passeggiata in
campagna e di dilettevoli occupazioni , la contrada di Sotto Badia.
Ville, zone ombrose , fontane, ruderi di vecchi mulini, rendono
oggi questo luogo ideale per una camminata alla scoperta di dimore storiche,
di reperti di archeologia della tecnica disseminati in un angolo incantevole
della natura. Eppure in un contesto che appare aperto al nuovo, non mancarono
reazioni ai mutamenti e volontà di ritorno al passato, se è vero che anche
a Troina, scoppiò, come in tanti comuni della Sicilia, nel 1798, una rivolta
antigiacobina. La
storia ottocentesca di Troina è quella di una realtà rurale dominata da
una élite politica-religiosa. Le caratteristiche di questa élite sono
quelle di un ceto di possidenti ,baroni e borghesi delle professioni  discendenti
da antichi casati patrizi, e di religiosi, soprattutto dell'ordine basiliano,
che detengono patrimoni terrieri enormi, da secoli, sin dall'età
normanna. Troina partecipa ai moti siciliani del 1820-21, ma preponderante
in questa scelta è la volontà di assecondare la famiglia Bazan, di antica
origine troinese e protagonista della rivolta palermitana, in difesa delle
ragioni della quale il popolo troinese viene chiamato a combattere; così
come decisivo , nell'orientare la scelta del comune di Troina di dare
armi alle folle è la presenza, in quegli anni, nel convento basiliano
di San Michele a Troina, dell'abate Chiavetta, animatore, del periodico
isolano Il giornale patriottico diretto da Aceto, anche lui di
antica discendenza troinese.I
diversi orientamenti di questi ceti dominanti determineranno il corso
degli eventi troinesi sin oltre alla metà del secolo.
Tant'è che passata
la rivolta siciliana, a Troina ritorna la normalizzazzione
e se non in maniera sparuta e scarsamente incisiva, il popolo partecipa
ai moti del 48, riprendendo la vita nella comunità secondo gli antichi
assetti: il ceto dominante che stenta a dare dignità e sviluppo alla cittadina,
cercando di far realizzare infrastrutture (strade, collegamenti ) necessarie
a far uscire Troina dal naturale isolamento di centro montano e
istituzioni (educative, sanitarie ) capaci di migliorare la qualità della
vita; il mondo contadino, annichilito dal lavoro come pura fatica, afflitto
dalle angherie, costretto al furto campestre, all'illegalità come autodifesa
e lotta per la sopravvivenza.
Gli eventi rivoluzionari
del '60, peraltro cruenti nel vicinato (Bronte e Randazzo distano appena
una trentina di chilometri da Troina) non vedono la comunità partecipe:
le cronache narrano di pochi garibaldini ma soprattutto assente è qualunque
progetto di rivolgimento sociale o di riflessione critica sulle vicende
italiane del tempo.
Sostanzialmente il paese
è governato dal notabilato, alleato alle alte cariche religiose, spesso
uniti da legami parentali, oltre ché da comuni interessi economici.
Timidi tentativi di
formazione di una Società operaia vengono fatti da un piccolo gruppo di
artigiani: ma il ruolo del circolo di Troina è assai modesto. Il mondo
paesano appare staticamente chiuso e impermeabile ai fatti esterni: anche
qui è da valutare il ruolo dei gruppi egemoni: la direzione spirituale
affidata all'abate Antonino Russo del convento
discendenti
da antichi casati patrizi, e di religiosi, soprattutto dell'ordine basiliano,
che detengono patrimoni terrieri enormi, da secoli, sin dall'età
normanna. Troina partecipa ai moti siciliani del 1820-21, ma preponderante
in questa scelta è la volontà di assecondare la famiglia Bazan, di antica
origine troinese e protagonista della rivolta palermitana, in difesa delle
ragioni della quale il popolo troinese viene chiamato a combattere; così
come decisivo , nell'orientare la scelta del comune di Troina di dare
armi alle folle è la presenza, in quegli anni, nel convento basiliano
di San Michele a Troina, dell'abate Chiavetta, animatore, del periodico
isolano Il giornale patriottico diretto da Aceto, anche lui di
antica discendenza troinese.I
diversi orientamenti di questi ceti dominanti determineranno il corso
degli eventi troinesi sin oltre alla metà del secolo.
Tant'è che passata
la rivolta siciliana, a Troina ritorna la normalizzazzione
e se non in maniera sparuta e scarsamente incisiva, il popolo partecipa
ai moti del 48, riprendendo la vita nella comunità secondo gli antichi
assetti: il ceto dominante che stenta a dare dignità e sviluppo alla cittadina,
cercando di far realizzare infrastrutture (strade, collegamenti ) necessarie
a far uscire Troina dal naturale isolamento di centro montano e
istituzioni (educative, sanitarie ) capaci di migliorare la qualità della
vita; il mondo contadino, annichilito dal lavoro come pura fatica, afflitto
dalle angherie, costretto al furto campestre, all'illegalità come autodifesa
e lotta per la sopravvivenza.
Gli eventi rivoluzionari
del '60, peraltro cruenti nel vicinato (Bronte e Randazzo distano appena
una trentina di chilometri da Troina) non vedono la comunità partecipe:
le cronache narrano di pochi garibaldini ma soprattutto assente è qualunque
progetto di rivolgimento sociale o di riflessione critica sulle vicende
italiane del tempo.
Sostanzialmente il paese
è governato dal notabilato, alleato alle alte cariche religiose, spesso
uniti da legami parentali, oltre ché da comuni interessi economici.
Timidi tentativi di
formazione di una Società operaia vengono fatti da un piccolo gruppo di
artigiani: ma il ruolo del circolo di Troina è assai modesto. Il mondo
paesano appare staticamente chiuso e impermeabile ai fatti esterni: anche
qui è da valutare il ruolo dei gruppi egemoni: la direzione spirituale
affidata all'abate Antonino Russo del convento basiliano, dentro il quale si forma la gioventù istruita e ricca del paese,
è fatta di conservatorismo e opposizione tradizionalista e clericale alla
nuova Italia che si delinea con l'impresa garibaldina. La crisi del dominio
di questa élite avverrà non per moto interno di opposizione, né per la
nascita di nuovi ceti produttivi in grado di sostituirsi ad una 'immobile'
guida patrizia della città: accadrà a seguito delle misure prese dallo
Stato unitario, in merito all'alienazione dei beni ecclesiastici, a partire
dal 1886. La
crisi della grande proprietà religiosa, a Troina, dove all'inizio del
secolo le Chiese e i conventi erano la gran parte della struttura urbana
del paese, sopravanzavano tutti gli altri edifici pubblici e privati,
determinò il crollo definitivo dell'economia tutta e la nascita di una
classe di proprietari 'parvenu' diventati ricchi, avendo acquistato con
poche lire le terre dei religiosi. Questa nuova classe di proprietari
rozzi e incattiviti dalla volontà di realizzare profitti alti e in tempi
rapidi, inasprì le condizioni di vita dei contadini; il possesso della
cosa pubblica conseguito al nuovo ruolo economico si trasformò in una
miope e incosciente pratica amministrativa, tendente a eliminare vecchi
istituti che servivano in qualche modo a tutelare i bisogni alimentari
del popolo: gli ammassi comunali di grano per.es. In ragione di tale arretramento
socio-economico, nel rigido febbraio del 1898, scoppia a Troina una rivolta
contadina, dalla genesi spontanea, dalle rivendicazioni confuse e generiche
(le uniche parole d'ordine sono 'avimu a fama, vulimu u pani',
e poi 'apriamo i magazzini dei proprietari' mentre stranamente
la marcia dei rivoltosi si avvia verso il palazzo del Comune), dall'epilogo
tragico. I rivoltosi che attraversano il paese, capeggiati anche da una
coraggiosa donna, rappresentano la materializzazione della Rivoluzione,
in una comunità che di fatti violenti ha
basiliano, dentro il quale si forma la gioventù istruita e ricca del paese,
è fatta di conservatorismo e opposizione tradizionalista e clericale alla
nuova Italia che si delinea con l'impresa garibaldina. La crisi del dominio
di questa élite avverrà non per moto interno di opposizione, né per la
nascita di nuovi ceti produttivi in grado di sostituirsi ad una 'immobile'
guida patrizia della città: accadrà a seguito delle misure prese dallo
Stato unitario, in merito all'alienazione dei beni ecclesiastici, a partire
dal 1886. La
crisi della grande proprietà religiosa, a Troina, dove all'inizio del
secolo le Chiese e i conventi erano la gran parte della struttura urbana
del paese, sopravanzavano tutti gli altri edifici pubblici e privati,
determinò il crollo definitivo dell'economia tutta e la nascita di una
classe di proprietari 'parvenu' diventati ricchi, avendo acquistato con
poche lire le terre dei religiosi. Questa nuova classe di proprietari
rozzi e incattiviti dalla volontà di realizzare profitti alti e in tempi
rapidi, inasprì le condizioni di vita dei contadini; il possesso della
cosa pubblica conseguito al nuovo ruolo economico si trasformò in una
miope e incosciente pratica amministrativa, tendente a eliminare vecchi
istituti che servivano in qualche modo a tutelare i bisogni alimentari
del popolo: gli ammassi comunali di grano per.es. In ragione di tale arretramento
socio-economico, nel rigido febbraio del 1898, scoppia a Troina una rivolta
contadina, dalla genesi spontanea, dalle rivendicazioni confuse e generiche
(le uniche parole d'ordine sono 'avimu a fama, vulimu u pani',
e poi 'apriamo i magazzini dei proprietari' mentre stranamente
la marcia dei rivoltosi si avvia verso il palazzo del Comune), dall'epilogo
tragico. I rivoltosi che attraversano il paese, capeggiati anche da una
coraggiosa donna, rappresentano la materializzazione della Rivoluzione,
in una comunità che di fatti violenti ha  solo
sentito parlare e che ha visto nel '93 una semplice e timida presenza
dell'organizzazione dei Fasci. Suscitano paura nel loro intrepido avanzare
i contadini ostinati e finalmente presenti, dopo anni per non dire secoli
di rassegnazione e pazienza. Vengono fermati da un'eccessiva reazione
delle forze dell'ordine che sparano sui rivoltosi, quando questi stanno
con certezza avviandosi verso la parte del paese, dove vi sono le residenze
dei notabili del paese e la sede del Comune. Il bilancio è quello di più
di dieci morti e di numerosi feriti: quasi tutti gli altri, arrestati,
verranno processati e condannati. Si scrive quel giorno una pagina
di storia che rende Troina, assieme a Modica dove avvengono quasi al contempo
gli stessi moti, la città che dà il via alle numerose agitazioni che dalla
Sicilia attraverseranno l'Italia ed avranno il punto culminante nelle
giornate milanesi del maggio 98.
Osservava stupito,
commentando alla Camera i fatti, l'on. Majorana che ben conosceva il paese,
essendo parte del suo collegio elettorale e dove tanti voti aveva avuto,
che 'il socialismo è sconosciuto a Troina'. Ed in effetti la storia
del secondo ottocento a Troina ci conferma la scarsa consistenza e presenza
non solo di tendenze e uomini che è possibile ricondurre ad una visione
'socialista' ma anche di gruppi moderatamente sensibili alle idee di progresso
e di riconsiderazione dei rapporti tra le classi sociali. S'erano piuttosto
formate negli anni 1873 e 1881 due logge massoniche, Aspromonte e Imacara,
composte da esponenti del ceto medio delle maestranze e della borghesia
anticlericale che utilizzò la rete massonica delle logge per ricevere
appoggi e consolidare amicizie con i gruppi dirigenti del nuovo governo
unitario. La rivolta del 1898 ebbe comunque un impatto sulla collettività
e produsse una certa presa di coscienza dei meno abbienti, che produsse
i suoi effetti ed
infatti all'inizio del XX secolo, la vita pubblica è scandita dal successo
delle forze progressiste in ambito amministrativo e dalle rivendicazioni
del 'combattentismo', il movimento che voleva l'applicazione del decreto
del ministro Visocchi, che prevedeva l'assegnazione di parti di terreno
da coltivare ai reduci
della prima guerra mondiale.
Come reazione all'avanzata
popolare, i proprietari e conservatori di Troina diedero vita (ante-marcia)
al movimento fascista , e già nel 1920 si apprestarono a conquistare il
Comune, detenendolo, poi, fino al 1943, quando con l'ingresso delle truppe
americane, il podestà venne deposto.
Proprio nell'agosto
del '43 il territorio di Troina diviene campo della storica 'battaglia'
che dal giorno 1 al 6 del mese vede impegnati i soldati americani, che
avanzano verso Messina, a contrastare la resistenza di un nucleo di teedschi
arroccati in paese. I giorni di battaglia, cruenti e nefasti per la popolazione
solo
sentito parlare e che ha visto nel '93 una semplice e timida presenza
dell'organizzazione dei Fasci. Suscitano paura nel loro intrepido avanzare
i contadini ostinati e finalmente presenti, dopo anni per non dire secoli
di rassegnazione e pazienza. Vengono fermati da un'eccessiva reazione
delle forze dell'ordine che sparano sui rivoltosi, quando questi stanno
con certezza avviandosi verso la parte del paese, dove vi sono le residenze
dei notabili del paese e la sede del Comune. Il bilancio è quello di più
di dieci morti e di numerosi feriti: quasi tutti gli altri, arrestati,
verranno processati e condannati. Si scrive quel giorno una pagina
di storia che rende Troina, assieme a Modica dove avvengono quasi al contempo
gli stessi moti, la città che dà il via alle numerose agitazioni che dalla
Sicilia attraverseranno l'Italia ed avranno il punto culminante nelle
giornate milanesi del maggio 98.
Osservava stupito,
commentando alla Camera i fatti, l'on. Majorana che ben conosceva il paese,
essendo parte del suo collegio elettorale e dove tanti voti aveva avuto,
che 'il socialismo è sconosciuto a Troina'. Ed in effetti la storia
del secondo ottocento a Troina ci conferma la scarsa consistenza e presenza
non solo di tendenze e uomini che è possibile ricondurre ad una visione
'socialista' ma anche di gruppi moderatamente sensibili alle idee di progresso
e di riconsiderazione dei rapporti tra le classi sociali. S'erano piuttosto
formate negli anni 1873 e 1881 due logge massoniche, Aspromonte e Imacara,
composte da esponenti del ceto medio delle maestranze e della borghesia
anticlericale che utilizzò la rete massonica delle logge per ricevere
appoggi e consolidare amicizie con i gruppi dirigenti del nuovo governo
unitario. La rivolta del 1898 ebbe comunque un impatto sulla collettività
e produsse una certa presa di coscienza dei meno abbienti, che produsse
i suoi effetti ed
infatti all'inizio del XX secolo, la vita pubblica è scandita dal successo
delle forze progressiste in ambito amministrativo e dalle rivendicazioni
del 'combattentismo', il movimento che voleva l'applicazione del decreto
del ministro Visocchi, che prevedeva l'assegnazione di parti di terreno
da coltivare ai reduci
della prima guerra mondiale.
Come reazione all'avanzata
popolare, i proprietari e conservatori di Troina diedero vita (ante-marcia)
al movimento fascista , e già nel 1920 si apprestarono a conquistare il
Comune, detenendolo, poi, fino al 1943, quando con l'ingresso delle truppe
americane, il podestà venne deposto.
Proprio nell'agosto
del '43 il territorio di Troina diviene campo della storica 'battaglia'
che dal giorno 1 al 6 del mese vede impegnati i soldati americani, che
avanzano verso Messina, a contrastare la resistenza di un nucleo di teedschi
arroccati in paese. I giorni di battaglia, cruenti e nefasti per la popolazione
 che ebbe più
di 100 vittime e per l'abitato, in gran parte ridotto a macerie verranno
fotografati da Robert Capa. Oggi, i suoi scatti su Troina fanno parte
dell'immaginario e della cultura visiva mondiale, ed è di estremo interesse,
per chi viene a Troina, confrontare i luoghi odierni con quelli ripresi
dall'obiettivo di Capa. Come è possibile, ancora, osservare, sui monti
vicini all'abitato, i segni dei bombardamenti o scoprire gli inprovvisati
rifugi della gente del paese, durante quei sei giorni di incessante combattimento.
Segnato dalla guerra,
il paese affronta il peso della ricostruzione con caparbietà. La
vita sociale riprende nella libertà. A dare impulso alla trasformazione
della condizione rurale in una più moderna e avanzata realtà economica,
commerciale e dei servizi, nei primi anni '50 è la costruzione della diga
dell'Ancipa. L'imponente lavoro determina per Troina una sorta di periodo
di boom economico: produce occupazone,fa sì che si fomi un ceto operaio,
richiama manodopera e tecnici specializzati da fuori, crea un clima generale
di ottimismo e di apertura alle novità nella mentalità collettiva (pur
non mancando purtroppo episodi tragici di vittime per incidenti sul lavoro,
durante gli anni di costruzione dell'opera).
L'evento avrà forza
propulsiva per l'economia el paese, ma non strutturale e di lungo periodo.
Così anche la storia
di Troina nel secondo '900 sarà simile a quella di tanti paesi dell'entroterra
siciliano, fatta di cicliche ondate migratorie e di congiunture favorevoli
al lavoro e allo sviluppo (espansioni edilizie, metanizzazione, crescita
dell'Oasi, l'Istituto per l'assistenza e cura dei bambini con handicap).
Il territorio ha
subito modifiche profonde: si sono aggiunti diversi e nuovi quartieri
che sembrano però ancora senza fisionomia e identità. Pur decorose le
casette a schiera e i complessi abitativi nati da cooperative nella zona
chiamata Mulino a Vento o posti gli edifici in luogo climaticamente temperato,
nella zona San Michele, mancano però di quelle caratteristiche di immediata
socialità del vicolo, di pregio estetico, di persistenza delle consuetudini
che il centro storico ancora fortunatamente conserva. Il suo fascino è
intatto e ancora vale, per il forestiero, l'invito che fece Luigi Veronelli
decenni orsono:
'passeggiane le quiete vie; in ogni 'luogo' hai solari panorami e le testimonianze:
mura di età megalitica e greca, torre normanna, chiese basiliane, neoclassiche,
barocche'
che ebbe più
di 100 vittime e per l'abitato, in gran parte ridotto a macerie verranno
fotografati da Robert Capa. Oggi, i suoi scatti su Troina fanno parte
dell'immaginario e della cultura visiva mondiale, ed è di estremo interesse,
per chi viene a Troina, confrontare i luoghi odierni con quelli ripresi
dall'obiettivo di Capa. Come è possibile, ancora, osservare, sui monti
vicini all'abitato, i segni dei bombardamenti o scoprire gli inprovvisati
rifugi della gente del paese, durante quei sei giorni di incessante combattimento.
Segnato dalla guerra,
il paese affronta il peso della ricostruzione con caparbietà. La
vita sociale riprende nella libertà. A dare impulso alla trasformazione
della condizione rurale in una più moderna e avanzata realtà economica,
commerciale e dei servizi, nei primi anni '50 è la costruzione della diga
dell'Ancipa. L'imponente lavoro determina per Troina una sorta di periodo
di boom economico: produce occupazone,fa sì che si fomi un ceto operaio,
richiama manodopera e tecnici specializzati da fuori, crea un clima generale
di ottimismo e di apertura alle novità nella mentalità collettiva (pur
non mancando purtroppo episodi tragici di vittime per incidenti sul lavoro,
durante gli anni di costruzione dell'opera).
L'evento avrà forza
propulsiva per l'economia el paese, ma non strutturale e di lungo periodo.
Così anche la storia
di Troina nel secondo '900 sarà simile a quella di tanti paesi dell'entroterra
siciliano, fatta di cicliche ondate migratorie e di congiunture favorevoli
al lavoro e allo sviluppo (espansioni edilizie, metanizzazione, crescita
dell'Oasi, l'Istituto per l'assistenza e cura dei bambini con handicap).
Il territorio ha
subito modifiche profonde: si sono aggiunti diversi e nuovi quartieri
che sembrano però ancora senza fisionomia e identità. Pur decorose le
casette a schiera e i complessi abitativi nati da cooperative nella zona
chiamata Mulino a Vento o posti gli edifici in luogo climaticamente temperato,
nella zona San Michele, mancano però di quelle caratteristiche di immediata
socialità del vicolo, di pregio estetico, di persistenza delle consuetudini
che il centro storico ancora fortunatamente conserva. Il suo fascino è
intatto e ancora vale, per il forestiero, l'invito che fece Luigi Veronelli
decenni orsono:
'passeggiane le quiete vie; in ogni 'luogo' hai solari panorami e le testimonianze:
mura di età megalitica e greca, torre normanna, chiese basiliane, neoclassiche,
barocche'