|
|
Un contributo alle scienze agrarie, riferito agli allevamenti ed alle
tecniche di caseificazione presenti nell’entroterra siciliano nella seconda
metà dell’Ottocento, ci viene fornito da un manuale di agricoltura, a dire
il vero poco citato nei lavori bibliografici, ma abbastanza ricco di notizie
e particolari.
Nell’ambito di quel movimento isolano tendente al progresso culturale,
iniziato già a partire dal Settecento e che portò a diverse pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico oltre che letterario, si inserisce infatti la
figura poco conosciuta del sacerdote mistrettese don Gaetano Salamone,
vissuto nel XIX secolo ed autore di un interessante lavoro sull’agricoltura
e la pastorizia.
 Tale
pubblicazione, tra gli studi relativi alle scienze agrarie in Sicilia,
riveste una certa importanza poiché fornisce una serie di notizie descritte
minuziosamente, legate all’agricoltura ed alla zootecnia della seconda metà
dell’Ottocento, ed aventi come base territoriale il circondario nebroideo
facente capo a Mistretta con gli aggregati paesi di Capizzi, Castelluccio
(l’attuale Castel di Lucio), Reitano, Cesarò, San Teodoro, San Fratello,
Santo Stefano di Camastra, Caronia, Motta d’Affermo, Pettineo e Tusa. Tutto
ciò a testimonianza di un processo culturale che in Sicilia non si è mai
identificato con i grossi centri urbani, ma si è sviluppato in molti paesini
e cittadine di medie dimensioni attraverso un interesse nuovo, “scientifico”
per l’agricoltura, espressione di quella scoperta dell’”utile”, in
coincidenza con quanto avveniva nel resto dell’Europa. Tale
pubblicazione, tra gli studi relativi alle scienze agrarie in Sicilia,
riveste una certa importanza poiché fornisce una serie di notizie descritte
minuziosamente, legate all’agricoltura ed alla zootecnia della seconda metà
dell’Ottocento, ed aventi come base territoriale il circondario nebroideo
facente capo a Mistretta con gli aggregati paesi di Capizzi, Castelluccio
(l’attuale Castel di Lucio), Reitano, Cesarò, San Teodoro, San Fratello,
Santo Stefano di Camastra, Caronia, Motta d’Affermo, Pettineo e Tusa. Tutto
ciò a testimonianza di un processo culturale che in Sicilia non si è mai
identificato con i grossi centri urbani, ma si è sviluppato in molti paesini
e cittadine di medie dimensioni attraverso un interesse nuovo, “scientifico”
per l’agricoltura, espressione di quella scoperta dell’”utile”, in
coincidenza con quanto avveniva nel resto dell’Europa.
I risultati della ricerca in questione vennero pubblicati dal Salamone in
due volumi a distanza di pochi anni; in particolare, la prima parte del
lavoro, composta da circa 180 pagine, venne data alle stampe nel 1870,
presso la locale tipografia comunale, col titolo “Manuale teorico-pratico di
agricoltura, adattato alla intelligenza delle persone idiote di Sicilia, ed
in inspecialità a quelle del circondario di Mistretta”; la seconda parte,
composta da circa 270 pagine, venne pubblicata nel 1872, presso la
tipografia diretta da G. Mauro, dal titolo “Manuale teorico-pratico
d’agricoltura e pastorizia adattato all’intelligenza popolare”. Ognuno dei
due volumi si presenta suddiviso in dodici trattati composti a loro volta da
parecchi paragrafi.
Lo scopo di pubblicare notizie di agricoltura e pastorizia da parte del
sacerdote mistrettese aveva la finalità di abbassare il livello di ignoranza
e di istruire gli agricoltori ed i pastori di quelle zone montuose e povere,
attraverso un manuale che fosse comprensibile a tutti, sia per il
circondario sia per l’intera Isola. In effetti, il Salamone, pur essendo un
erudito, scrive e parla di agricoltura e di zootecnia con parole semplici,
descrivendo tutto quello che vede ed osserva nelle campagne, anche se non
riporta nel testo disegni ed illustrazioni.
Il secondo volume, in particolare, per gli studiosi di zootecnia e di
industrie agrarie sulla caseificazione, risulta un’opera degna di essere
ripubblicata ai giorni nostri. L’autore, partendo da notizie relative alla
pastorizia ed agli allevamenti, spazia con trattati che vanno
dall’apicoltura alla bachicoltura e dall’economia e contabilità ai pesi e
misure del circondario. Ma il capitolo che riscuote maggiore interesse, per
l’attendibilità delle notizie riportate, rimane il sedicesimo trattato dal
titolo “Caseificio: cioè modo di fare il cacio”, importante supporto e guida
per gli addetti ai lavori, nel quale sono descritte le varie fasi e tecniche
di produzione dei formaggi tipici dell’areale dei Nebrodi.
In effetti, di manuali definiti teorico-pratici degni di menzione, con una
composizione prettamente tecnica e non esclusivamente erudita, ed aventi per
oggetto la pastorizia e le tecniche di produzione dei formaggi in Sicilia,
se ne contano pochi. Pur tuttavia si può fare riferimento al lavoro del
priore Gregorio Barnaba La Via, il quale nel 1851 pubblica negli “Annali di
Agricoltura” l’articolo dal titolo “Dei latticinii, dei formaggi, loro
manipolazione e conservazione”; un successivo lavoro, meritevole di essere
attenzionato, è quello del dottor S. Toscano, pubblicato nel 1880 presso la
stamperia Campailla di Modica, avente
 per
titolo “Notizie sulla fabbricazione dei formaggi nel circondario di Modica.
Su i miglioramenti dei prodotti di cascina, da servire per la compilazione
di una monografia su vari metodi di caseificio delle regioni meridionali”;
infine, un ulteriore lavoro riguarda gli studi del barone Nicolò
Turrisi-Colonna, pubblicati a Palermo nel 1882 dal titolo “Industria
pastorale nel territorio di Palermo”. per
titolo “Notizie sulla fabbricazione dei formaggi nel circondario di Modica.
Su i miglioramenti dei prodotti di cascina, da servire per la compilazione
di una monografia su vari metodi di caseificio delle regioni meridionali”;
infine, un ulteriore lavoro riguarda gli studi del barone Nicolò
Turrisi-Colonna, pubblicati a Palermo nel 1882 dal titolo “Industria
pastorale nel territorio di Palermo”.
Bisogna giungere al secolo successivo per menzionare l’opera di Carmelo
Campisi (1933) “Pecore e pecorino della Sicilia”, ed il lavoro del professor
Alberto Romolotti (1936) “I formaggi Siciliani”. I nostri giorni permettono
di leggere ulteriori ed interessanti notizie sulla caseificazione in
Sicilia; si tratta di due ricerche pubblicate alcuni decenni or sono,
riferibili più alla cultura materiale che a veri e propri trattati di
industrie agrarie, i quali hanno fatto sì che gli aspetti tradizionali della
pastorizia e della zootecnia non andassero perduti per sempre. E’ d’obbligo
pertanto citare il lavoro di Antonino Uccello che ha per titolo “Bovari -
Pecorai - Cùratuli. Cultura casearia in Sicilia”, edito nel 1980, e quello
di Mario Giacomarra “I pastori delle Madonie. Ambiente, tecniche, società”,
pubblicato qualche anno dopo, nel 1983. Infine, si fa menzione del recente
volume pubblicato nel 2001 “I formaggi storici di nicchia della Sicilia”, in
cui confluiscono conoscenze ed esperienze specifiche in questo settore da
parte dell’Associazione Allevatori della Sicilia.
Il trattato del Salamone, pertanto, risulta importante poiché, se fino alla
seconda metà del Novecento erano ancora presenti pastori, allevatori e
casari che conoscevano l’arte di produrre i formaggi, al giorno d’oggi poche
sono quelle figure che hanno ereditato il sapere e le conoscenze tramandate
da padre in figlio; addirittura è del tutto scomparso quell’indotto legato
all’attività zootecnica e casearia, quale per esempio la figura del
cosiddetto “fasciddaru” (fabbricatore di fiscelle e fascere di giunco), o lo
“stagnataru” o “quadararu” (artigiano che realizza le caldaie in rame,
rivestite nel loro interno di stagno).
In Sicilia i formaggi sono stati, fin dai tempi più antichi, uno dei
fondamenti dell’alimentazione umana poiché il latte, consumato fresco solo
in minima parte, rendeva necessaria e quasi obbligatoria la sua
trasformazione, l’importanza di quest’ultima si comprende meglio qualora si
pensi al fatto che essa consentiva di conservare il latte nel tempo. Notizie
riguardanti il formaggio si ritrovano già nella mitologia greca, secondo la
quale l’arte di caseificare fu rivelata dal centauro Chirone al pastore
Aristeo, figlio della ninfa Cirene e del dio Apollo. Un altro mito
attribuisce l’origine del formaggio alla nutrice del dio Giove, Amaltea, dal
cui seno sgorgò il latte che, rappresosi, diede origine al formaggio.
Più verosimilmente il formaggio nacque per caso, quando si constatò che
lasciando il latte all’aria esso subiva una fermentazione e, quindi, una
coagulazione, tecnica di produzione in seguito affinata ed evoluta che ha
dato luogo ad una moltitudine di prodotti a partire dalla stessa materia
prima.
 Notizie
storiche sulla presenza di formaggi in Sicilia, già con una differenziazione
ben precisa, si hanno nel Medioevo, precisamente nei calmieri
quattrocenteschi e nei registri di conventi e monasteri, essendo utilizzati
anche come merce di scambio o nei contratti di affitto. Certo è che il più
antico formaggio prodotto in Sicilia è con ogni probabilità il “Pecorino”; i
caratteristici ma precari ambienti demandati alla caseificazione descritti
dal Salamone, i cosiddetti “marcati”, disseminati ancora nelle campagne
siciliane ed utilizzati fino a qualche decennio fa, come pure i pastori che
vi lavoravano, rimandano ai versi del IX canto dell’Odissea, in cui il poeta
Omero narra dell’incontro avvenuto tra Ulisse ed il ciclope Poliremo, quest’ultimo
con le mansioni di pastore e casaro: <<Quando dunque arrivammo alla terra
vicina, qui sull’estrema punta una grotta vedemmo, sul mare, eccelsa,
ombreggiata da lauri; e qui molte greggi, pecore e capre, avevano stalla;
intorno un recinto alto correva, fatto di blocchi di pietra […] nell’antro,
osservammo ogni cosa; dal peso dei caci i graticci piegavano; steccato
c’erano, per gli agnelli e i capretti, e separata ogni età vi stava chiusa,
a parte i primi nati, a parte i secondi, a parte ancora i lattonzoli; tutti
i boccali traboccavan di siero, e i secchi e i vasi nei quali mungeva. Lui [Polifemo]
nell’ampia caverna spinse le pecore pingui, tutte quante ne aveva da
mungere; ma i maschi li lasciò fuori, montoni, caproni, all’aperto nell’alto
steccato. Seduto, quindi, mungeva le pecore e le capre belanti, ognuna per
ordine, e cacciò sotto a tutte il lattonzolo. E subito cagliò una metà del
candido latte, e, rappreso, lo mise nei canestrelli intrecciati; metà nei
boccali lo tenne, per averne da prendere e bere, che gli facesse da cena…>>. Notizie
storiche sulla presenza di formaggi in Sicilia, già con una differenziazione
ben precisa, si hanno nel Medioevo, precisamente nei calmieri
quattrocenteschi e nei registri di conventi e monasteri, essendo utilizzati
anche come merce di scambio o nei contratti di affitto. Certo è che il più
antico formaggio prodotto in Sicilia è con ogni probabilità il “Pecorino”; i
caratteristici ma precari ambienti demandati alla caseificazione descritti
dal Salamone, i cosiddetti “marcati”, disseminati ancora nelle campagne
siciliane ed utilizzati fino a qualche decennio fa, come pure i pastori che
vi lavoravano, rimandano ai versi del IX canto dell’Odissea, in cui il poeta
Omero narra dell’incontro avvenuto tra Ulisse ed il ciclope Poliremo, quest’ultimo
con le mansioni di pastore e casaro: <<Quando dunque arrivammo alla terra
vicina, qui sull’estrema punta una grotta vedemmo, sul mare, eccelsa,
ombreggiata da lauri; e qui molte greggi, pecore e capre, avevano stalla;
intorno un recinto alto correva, fatto di blocchi di pietra […] nell’antro,
osservammo ogni cosa; dal peso dei caci i graticci piegavano; steccato
c’erano, per gli agnelli e i capretti, e separata ogni età vi stava chiusa,
a parte i primi nati, a parte i secondi, a parte ancora i lattonzoli; tutti
i boccali traboccavan di siero, e i secchi e i vasi nei quali mungeva. Lui [Polifemo]
nell’ampia caverna spinse le pecore pingui, tutte quante ne aveva da
mungere; ma i maschi li lasciò fuori, montoni, caproni, all’aperto nell’alto
steccato. Seduto, quindi, mungeva le pecore e le capre belanti, ognuna per
ordine, e cacciò sotto a tutte il lattonzolo. E subito cagliò una metà del
candido latte, e, rappreso, lo mise nei canestrelli intrecciati; metà nei
boccali lo tenne, per averne da prendere e bere, che gli facesse da cena…>>.
Anche nel trattato di tecnologia casearia proposto da Columella, tra nozioni
zootecniche e precetti pratici, viene identificata come elemento di maggiore
rilievo, la descrizione sulla produzione del formaggio, la cui materia
prima, il latte, <<...viene generalmente rappreso con caglio di agnello o di
capretto, anche se è possibile farlo cagliare col fiore di cardo campestre o
col fiore del cartamo, e anche col lattice del fico […] e appena il liquido
si sarà rappreso dovrà essere trasferito in cestelli, panieri o forme. È
infatti essenziale che il siero possa scolare immediatamente e essere
separato dalla materia solida [...] poi, quando è tolto dalle forme o dai
panieri dovrà essere collocato in un ambiente fresco e oscuro, perché non
possa guastarsi, su tavole più pulite possibile, e cosparso di sale
tritato...>>.
Oggi come ieri si è ben convinti che la cura del gregge e la qualità del
latte che se ne ottiene, le tecniche di lavorazione del formaggio, assieme
ai locali dove viene stagionato, sono tutti fattori che influenzano in modo
determinante la qualità degli stessi formaggi. E si è ben più convinti che
le tecniche empiriche dei piccoli trasformatori rivestono un valore ed un
ruolo importante nel determinare la stessa qualità dei formaggi, anche se
tra le varie osservazioni fatte dal canonico Salamone ve ne è una
fondamentale: <<nella formazione dei
 caci
concorrono la natura e l’arte>>. caci
concorrono la natura e l’arte>>.
Se il caseificio industriale risulta più utile per manipolare notevoli
quantità di latte provenienti da allevamenti intensivi, piccole realtà,
denominate a “capacità limitata”, potrebbero far risaltare la qualità del
latte prodotto da razze rustiche; ed i pascoli montani con la loro flora
eterogenea, ricca di essenze aromatiche, rappresentano un elemento di
tipicità.
Tra i formaggi descritti dal Salamone si annovera, in primo luogo, il
“Caciocavallo” o “Cascavaddu” prodotto dal solo latte di vacca o dal latte
di capra mescolato a quello di vacca, anche se il migliore si ricava da
quello ottenuto dal latte di vacca. Per questo tipo di formaggio vengono
descritte accuratamente le varie fasi di produzione, comprese le
attrezzature impiegate (“scisca”, “ruotula”, “quadara”, “tavolieri”, “tina”,
“piddiaturi”, “manuvedda”, “busuniettu”, “fascedda”, ecc.). Con la pasta
dello stesso caciocavallo, per fare divertire i bambini, si creavano figure
a forma di daino, cervo, cavallo, bue, volatili ed altro, anche se alcuni
pezzi simili a focacce, detti “ardicori”, da mangiare freschi, venivano
realizzati dai pastori per essere regalati agli amici o al proprietario
della masseria.
Altri formaggi, menzionati nel trattato del Salamone, le cui tecniche di
lavorazione sono del tutto scomparse o poco conosciute dalle nuove
generazioni di allevatori, sono il “Cannestrato o piacentino ordinario
crudo, cotto a tutta scalda”, il quale si produceva da qualunque latte, sia
di vacca, di pecora o di capra. Segue il “Cannestrato cotto a mezza scalda”,
anch’esso detto “Piacentino”, ottenuto da una lavorazione simile al
precedente, con la sola differenza che, una volta messo nelle fiscelle,
queste venivano tenute immerse nel siero bollente fino al suo
raffreddamento. Un quarto tipo di formaggio è il “Cannestrato o piacentino
cotto a tutta scalda”, detto pure “Squadatu” o “Tumazzu cuottu”. Seguono
altri formaggi, quali il “Maiorchino”, che si produceva nelle zone di
Francavilla e nei dintorni di Taormina e Messina ed il cosiddetto “Bufalo”.
 Il
“Primo sale”, cacio usato prima dei quaranta giorni, si produceva in alte e
strette fiscelle di giunco; esso veniva consumato in pezzi della grossezza
di alcune dita detti “rasuna”, presente generalmente nella tavola dei
proprietari, degli impiegati della stessa masseria o per “complimentare”
visitatori e passanti. Il
“Primo sale”, cacio usato prima dei quaranta giorni, si produceva in alte e
strette fiscelle di giunco; esso veniva consumato in pezzi della grossezza
di alcune dita detti “rasuna”, presente generalmente nella tavola dei
proprietari, degli impiegati della stessa masseria o per “complimentare”
visitatori e passanti.
Un cacio aromatizzato, denominato “Cacio ‘mmisturatu”, si presentava di
colore giallo dorato per l’aggiunta dello zafferano; ordinariamente, nel
pecorino vi si metteva il pepe nero o “spiezzi”, ma a volte anche la
cannella o il garofano, pestati grossolanamente.
Tra i sottoprodotti della caseificazione, il Salamone ricorda la “Ricotta”,
ottenuta dal siero o “lacciata” e distinta in “Ricotta di vacca” e “Ricotta
di capra” fatte con il cosiddetto “agro”. La <<Ricotta di pecora>>, invece,
pur essendo prodotta con le stesse modalità, differisce poiché al posto
dell’”agro” vi si immergono dei rametti di fico o di gelso, dopo aver
portato ad elevata temperatura lo stesso siero.
Per finire, un paragrafo che descrive la vita dei pastori in quell’epoca,
interessante forse tanto quanto le inchieste agrarie che si svolsero in quei
periodi, riguarda la “Descrizione dell’ordinaria abitazione dei pastori in
Sicilia”, che vale la pena riportare così come pubblicato nel menzionato
manuale: <<In punti soleggiati, per quanto si può riparati dai venti e dalle
tempeste ed in terra silicea ed asciutta vicino a qualche rivolo d’acqua
[...] ed in un punto per
 quanto
si può centrale al feudo che serve di pascolo al bestiame, si stabilisce
l’abitazione de’ pastori, ed il locale scelto si chiama “marcatu”. Ivi si
forma un muretto, ordinariamente di forma circolare, di pietre a secco,
senza calce, o cemento o al più rarissime volte cementato con argilla, del
diametro di 4 o 5 metri, alto al massimo un metro e mezzo o due. Sopra a
questo muro si pongono de’ travicelli di due decimetri circa di diametro
alla base, alti circa 6 metri, detti “ciarivuna”, distanti mezzo metro circa
alla base e riuniti in cima in forma conica, intessuti di verghe lunghe e
pieghevoli detti “flacuna”, quali coverti d’alga di giunchi o da altre
simili erbe paludose, o di ginestre o disa, secondo l’opportunità dei luoghi
per riparo delle piogge, formano l’abitazione de’ pastori. Al didentro si
formano intorno 2 ordini di letti, uno all’altezza di 2 palmi, un altro
all’altezza di 6 circa, intessuti di legni per sostegno, detti “stacci” e
coverti di giunchi o altre paglie e frasche, al quale letto [i pastori]
danno il nome di “jazzu”. Alla fine vi formano un fosso attorniato di pietre
nel centro del suolo per focolare e lo dicono “fucagnu”. In tale
restrettissima abitazione si ricoverano 12, 16, 20, 24, 30, pastori. Ne ciò
dovrà sembrarvi esagerato [...]. Quivi pure si conservano la tina del latte,
la tina con l’agro, il “tavoliere”, quantità di fiscelle, le bardelle di 3,
4 o 6 vetture [muli] che servono per uso della mandra, e molti altri ordegni
ancora di minor conto, ma assai numerosi. Le caldaie ove si fa la ricotta,
sono sempre murati fuori, senza tettoia, all’aria aperta. Fuori pure
all’aria aperta è costruito il forno, garentito da una piccola tettoia nel
breve circuito della sua estensione, e la madia e tutti gli arnesi del pane
si conservano pure nell’abitazione sopra descritta, detta “pagghiaru”. Ad
un’altra capanna più piccola, formata allo stesso modo si dà il nome di “sammataria”.
Ivi si salano e si conservano i caci e le ricotte, il pane e qualche altra
cosa essenziale e se ne ottura ermeticamente la porta d’entrata con un
fascio di legna per non entrarvi i cani [...]. Pochissime persone tengono un
straccio per covertarsi la notte, detto “carpita”; gli altri tutti si
cuovrono con quel cappotto che li garantisce il giorno dalle piogge. I
giovani sventurati prendono un poco di sonno sulla nuda terra, spesso
fangosa per la quantità d’acqua e di siero che perculano li dentro. E’
penosa ed in certo modo sublime la veduta di quell’abitazione, in cui
soggiorna quel popolo di pastori [...]. Una tale abitazione io la credo
molto simile alla capanna che raccoglieva nel suo seno i pastori
d’Abramo…>>. quanto
si può centrale al feudo che serve di pascolo al bestiame, si stabilisce
l’abitazione de’ pastori, ed il locale scelto si chiama “marcatu”. Ivi si
forma un muretto, ordinariamente di forma circolare, di pietre a secco,
senza calce, o cemento o al più rarissime volte cementato con argilla, del
diametro di 4 o 5 metri, alto al massimo un metro e mezzo o due. Sopra a
questo muro si pongono de’ travicelli di due decimetri circa di diametro
alla base, alti circa 6 metri, detti “ciarivuna”, distanti mezzo metro circa
alla base e riuniti in cima in forma conica, intessuti di verghe lunghe e
pieghevoli detti “flacuna”, quali coverti d’alga di giunchi o da altre
simili erbe paludose, o di ginestre o disa, secondo l’opportunità dei luoghi
per riparo delle piogge, formano l’abitazione de’ pastori. Al didentro si
formano intorno 2 ordini di letti, uno all’altezza di 2 palmi, un altro
all’altezza di 6 circa, intessuti di legni per sostegno, detti “stacci” e
coverti di giunchi o altre paglie e frasche, al quale letto [i pastori]
danno il nome di “jazzu”. Alla fine vi formano un fosso attorniato di pietre
nel centro del suolo per focolare e lo dicono “fucagnu”. In tale
restrettissima abitazione si ricoverano 12, 16, 20, 24, 30, pastori. Ne ciò
dovrà sembrarvi esagerato [...]. Quivi pure si conservano la tina del latte,
la tina con l’agro, il “tavoliere”, quantità di fiscelle, le bardelle di 3,
4 o 6 vetture [muli] che servono per uso della mandra, e molti altri ordegni
ancora di minor conto, ma assai numerosi. Le caldaie ove si fa la ricotta,
sono sempre murati fuori, senza tettoia, all’aria aperta. Fuori pure
all’aria aperta è costruito il forno, garentito da una piccola tettoia nel
breve circuito della sua estensione, e la madia e tutti gli arnesi del pane
si conservano pure nell’abitazione sopra descritta, detta “pagghiaru”. Ad
un’altra capanna più piccola, formata allo stesso modo si dà il nome di “sammataria”.
Ivi si salano e si conservano i caci e le ricotte, il pane e qualche altra
cosa essenziale e se ne ottura ermeticamente la porta d’entrata con un
fascio di legna per non entrarvi i cani [...]. Pochissime persone tengono un
straccio per covertarsi la notte, detto “carpita”; gli altri tutti si
cuovrono con quel cappotto che li garantisce il giorno dalle piogge. I
giovani sventurati prendono un poco di sonno sulla nuda terra, spesso
fangosa per la quantità d’acqua e di siero che perculano li dentro. E’
penosa ed in certo modo sublime la veduta di quell’abitazione, in cui
soggiorna quel popolo di pastori [...]. Una tale abitazione io la credo
molto simile alla capanna che raccoglieva nel suo seno i pastori
d’Abramo…>>.
|
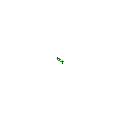

 Tale
pubblicazione, tra gli studi relativi alle scienze agrarie in Sicilia,
riveste una certa importanza poiché fornisce una serie di notizie descritte
minuziosamente, legate all’agricoltura ed alla zootecnia della seconda metà
dell’Ottocento, ed aventi come base territoriale il circondario nebroideo
facente capo a Mistretta con gli aggregati paesi di Capizzi, Castelluccio
(l’attuale Castel di Lucio), Reitano, Cesarò, San Teodoro, San Fratello,
Santo Stefano di Camastra, Caronia, Motta d’Affermo, Pettineo e Tusa. Tutto
ciò a testimonianza di un processo culturale che in Sicilia non si è mai
identificato con i grossi centri urbani, ma si è sviluppato in molti paesini
e cittadine di medie dimensioni attraverso un interesse nuovo, “scientifico”
per l’agricoltura, espressione di quella scoperta dell’”utile”, in
coincidenza con quanto avveniva nel resto dell’Europa.
Tale
pubblicazione, tra gli studi relativi alle scienze agrarie in Sicilia,
riveste una certa importanza poiché fornisce una serie di notizie descritte
minuziosamente, legate all’agricoltura ed alla zootecnia della seconda metà
dell’Ottocento, ed aventi come base territoriale il circondario nebroideo
facente capo a Mistretta con gli aggregati paesi di Capizzi, Castelluccio
(l’attuale Castel di Lucio), Reitano, Cesarò, San Teodoro, San Fratello,
Santo Stefano di Camastra, Caronia, Motta d’Affermo, Pettineo e Tusa. Tutto
ciò a testimonianza di un processo culturale che in Sicilia non si è mai
identificato con i grossi centri urbani, ma si è sviluppato in molti paesini
e cittadine di medie dimensioni attraverso un interesse nuovo, “scientifico”
per l’agricoltura, espressione di quella scoperta dell’”utile”, in
coincidenza con quanto avveniva nel resto dell’Europa. per
titolo “Notizie sulla fabbricazione dei formaggi nel circondario di Modica.
Su i miglioramenti dei prodotti di cascina, da servire per la compilazione
di una monografia su vari metodi di caseificio delle regioni meridionali”;
infine, un ulteriore lavoro riguarda gli studi del barone Nicolò
Turrisi-Colonna, pubblicati a Palermo nel 1882 dal titolo “Industria
pastorale nel territorio di Palermo”.
per
titolo “Notizie sulla fabbricazione dei formaggi nel circondario di Modica.
Su i miglioramenti dei prodotti di cascina, da servire per la compilazione
di una monografia su vari metodi di caseificio delle regioni meridionali”;
infine, un ulteriore lavoro riguarda gli studi del barone Nicolò
Turrisi-Colonna, pubblicati a Palermo nel 1882 dal titolo “Industria
pastorale nel territorio di Palermo”. caci
concorrono la natura e l’arte>>.
caci
concorrono la natura e l’arte>>.  Il
“Primo sale”, cacio usato prima dei quaranta giorni, si produceva in alte e
strette fiscelle di giunco; esso veniva consumato in pezzi della grossezza
di alcune dita detti “rasuna”, presente generalmente nella tavola dei
proprietari, degli impiegati della stessa masseria o per “complimentare”
visitatori e passanti.
Il
“Primo sale”, cacio usato prima dei quaranta giorni, si produceva in alte e
strette fiscelle di giunco; esso veniva consumato in pezzi della grossezza
di alcune dita detti “rasuna”, presente generalmente nella tavola dei
proprietari, degli impiegati della stessa masseria o per “complimentare”
visitatori e passanti. quanto
si può centrale al feudo che serve di pascolo al bestiame, si stabilisce
l’abitazione de’ pastori, ed il locale scelto si chiama “marcatu”. Ivi si
forma un muretto, ordinariamente di forma circolare, di pietre a secco,
senza calce, o cemento o al più rarissime volte cementato con argilla, del
diametro di 4 o 5 metri, alto al massimo un metro e mezzo o due. Sopra a
questo muro si pongono de’ travicelli di due decimetri circa di diametro
alla base, alti circa 6 metri, detti “ciarivuna”, distanti mezzo metro circa
alla base e riuniti in cima in forma conica, intessuti di verghe lunghe e
pieghevoli detti “flacuna”, quali coverti d’alga di giunchi o da altre
simili erbe paludose, o di ginestre o disa, secondo l’opportunità dei luoghi
per riparo delle piogge, formano l’abitazione de’ pastori. Al didentro si
formano intorno 2 ordini di letti, uno all’altezza di 2 palmi, un altro
all’altezza di 6 circa, intessuti di legni per sostegno, detti “stacci” e
coverti di giunchi o altre paglie e frasche, al quale letto [i pastori]
danno il nome di “jazzu”. Alla fine vi formano un fosso attorniato di pietre
nel centro del suolo per focolare e lo dicono “fucagnu”. In tale
restrettissima abitazione si ricoverano 12, 16, 20, 24, 30, pastori. Ne ciò
dovrà sembrarvi esagerato [...]. Quivi pure si conservano la tina del latte,
la tina con l’agro, il “tavoliere”, quantità di fiscelle, le bardelle di 3,
4 o 6 vetture [muli] che servono per uso della mandra, e molti altri ordegni
ancora di minor conto, ma assai numerosi. Le caldaie ove si fa la ricotta,
sono sempre murati fuori, senza tettoia, all’aria aperta. Fuori pure
all’aria aperta è costruito il forno, garentito da una piccola tettoia nel
breve circuito della sua estensione, e la madia e tutti gli arnesi del pane
si conservano pure nell’abitazione sopra descritta, detta “pagghiaru”. Ad
un’altra capanna più piccola, formata allo stesso modo si dà il nome di “sammataria”.
Ivi si salano e si conservano i caci e le ricotte, il pane e qualche altra
cosa essenziale e se ne ottura ermeticamente la porta d’entrata con un
fascio di legna per non entrarvi i cani [...]. Pochissime persone tengono un
straccio per covertarsi la notte, detto “carpita”; gli altri tutti si
cuovrono con quel cappotto che li garantisce il giorno dalle piogge. I
giovani sventurati prendono un poco di sonno sulla nuda terra, spesso
fangosa per la quantità d’acqua e di siero che perculano li dentro. E’
penosa ed in certo modo sublime la veduta di quell’abitazione, in cui
soggiorna quel popolo di pastori [...]. Una tale abitazione io la credo
molto simile alla capanna che raccoglieva nel suo seno i pastori
d’Abramo…>>.
quanto
si può centrale al feudo che serve di pascolo al bestiame, si stabilisce
l’abitazione de’ pastori, ed il locale scelto si chiama “marcatu”. Ivi si
forma un muretto, ordinariamente di forma circolare, di pietre a secco,
senza calce, o cemento o al più rarissime volte cementato con argilla, del
diametro di 4 o 5 metri, alto al massimo un metro e mezzo o due. Sopra a
questo muro si pongono de’ travicelli di due decimetri circa di diametro
alla base, alti circa 6 metri, detti “ciarivuna”, distanti mezzo metro circa
alla base e riuniti in cima in forma conica, intessuti di verghe lunghe e
pieghevoli detti “flacuna”, quali coverti d’alga di giunchi o da altre
simili erbe paludose, o di ginestre o disa, secondo l’opportunità dei luoghi
per riparo delle piogge, formano l’abitazione de’ pastori. Al didentro si
formano intorno 2 ordini di letti, uno all’altezza di 2 palmi, un altro
all’altezza di 6 circa, intessuti di legni per sostegno, detti “stacci” e
coverti di giunchi o altre paglie e frasche, al quale letto [i pastori]
danno il nome di “jazzu”. Alla fine vi formano un fosso attorniato di pietre
nel centro del suolo per focolare e lo dicono “fucagnu”. In tale
restrettissima abitazione si ricoverano 12, 16, 20, 24, 30, pastori. Ne ciò
dovrà sembrarvi esagerato [...]. Quivi pure si conservano la tina del latte,
la tina con l’agro, il “tavoliere”, quantità di fiscelle, le bardelle di 3,
4 o 6 vetture [muli] che servono per uso della mandra, e molti altri ordegni
ancora di minor conto, ma assai numerosi. Le caldaie ove si fa la ricotta,
sono sempre murati fuori, senza tettoia, all’aria aperta. Fuori pure
all’aria aperta è costruito il forno, garentito da una piccola tettoia nel
breve circuito della sua estensione, e la madia e tutti gli arnesi del pane
si conservano pure nell’abitazione sopra descritta, detta “pagghiaru”. Ad
un’altra capanna più piccola, formata allo stesso modo si dà il nome di “sammataria”.
Ivi si salano e si conservano i caci e le ricotte, il pane e qualche altra
cosa essenziale e se ne ottura ermeticamente la porta d’entrata con un
fascio di legna per non entrarvi i cani [...]. Pochissime persone tengono un
straccio per covertarsi la notte, detto “carpita”; gli altri tutti si
cuovrono con quel cappotto che li garantisce il giorno dalle piogge. I
giovani sventurati prendono un poco di sonno sulla nuda terra, spesso
fangosa per la quantità d’acqua e di siero che perculano li dentro. E’
penosa ed in certo modo sublime la veduta di quell’abitazione, in cui
soggiorna quel popolo di pastori [...]. Una tale abitazione io la credo
molto simile alla capanna che raccoglieva nel suo seno i pastori
d’Abramo…>>.